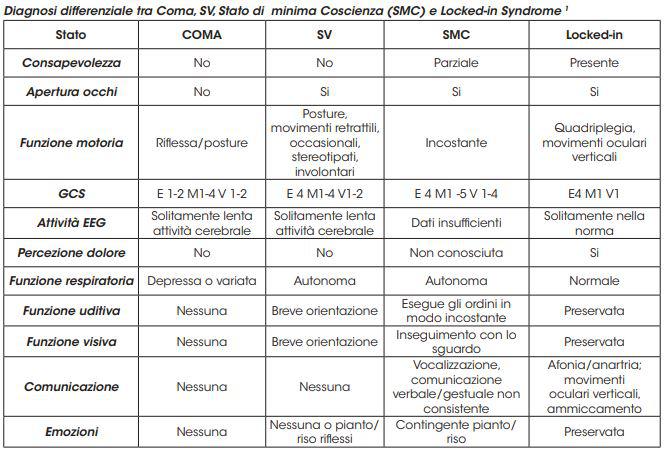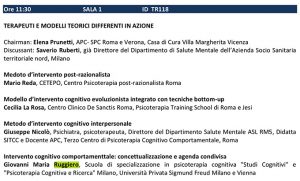Spoiler – Ciottoli di Psicopatologia Generale Nr. 41
Attenzione! Spoiler, spoiler, spoiler! Il rischio di spoiler oggi sembra essere una delle minacce più pericolose che possano capitarci… ma in realtà poi cosa succede?
CIOTTOLI DI PSICOPATOLOGIA GENERALE – Spoiler (Nr. 41)
La mia avversione per i termini inglesi mi ha tenuto finora lontano dalla comprensione del termine
spoiler che restava nell’area indefinita ma densamente popolata delle cose che non s’hanno da fare e che, essendo in qualche oscuro modo collegato al parlar troppo, mi riguardava direttamente.
L’orgoglio mi tratteneva dal chiederne il significato ai figli, sempre in agguato con lo sberleffo sulla pronuncia anglosassone, e così ho riesumato il metodo prepuberale quando per cercare di capire come nascessero i bambini azzardavo ipotesi a partire dalle barzellette e dalle allusioni degli adulti. Con il risultato allora di sottrarmi agli sbaciucchiamenti dei parenti in nome di una paternità responsabile. In seguito neppure i sei anni di medicina hanno connesso saldamente il trombare, attività dalle molte cause e dai molti scopi, con la gravidanza, che continua a sembrarmi un effetto collaterale più o meno desiderato.
Le prime intuizioni partirono dall’affermazione del figlio più grande rivolta al piccolo “in questa puntata Karl muore!” fatta con la faccia soddisfatta da dispetto definitivo. Per la cronaca Karl non morì affatto ma da allora “Karl muore” è diventato una sorta di tormentone che segnala la volontà di rovinare un godimento tanto atteso.
Col tempo il termine spoiler è entrato nel linguaggio pubblicitario di “Cielo a richiesta” ( trad. it.) e non ho potuto non capire che significasse rovinare la sorpresa di come andranno le cose svelandone l’esito. Ho anche scoperto che su internet esiste anche una sorta di galateo su ciò che si può e non si può dire rispetto a film, libri, serie tv (le più a rischio), eventi sportivi, con anche una serie di consigli maligni di “come dire senza dire”, “come utilizzare il non verbale e lasciar intuire”.
Perchè lo spoiler ci dà così fastidio?
Tornando in un terreno più familiare mi chiedo quale sia il danno che produce lo spoiler per rilevare quanto diversi, se non opposti, possano essere gli atteggiamenti umani.
Personalmente sapere come va a finire non mi priva di alcun piacere ed anzi, eliminando quella piccola quota d’ansia legata all’incertezza mi permette un godimento estetico più pieno. Per non parlare del fatto che, ad esempio in un giallo, sapendo già chi è l’assassino mi accorgo per tempo di tutti gli indizi in tal senso e mi sento perciò se non intelligente almeno furbo perché, si sa, agli storici tutto torna perfettamente e colgono nessi di causalità e necessità che invece non sono affatto evidenti prima, quando si fanno previsioni che non tengono conto di quel signore che vorremmo ignorare perché sfugge al nostro controllo e si chiama “Caso”.
Lo spoiler più importante dell’esistenza pone fine all’età dell’innocenza quando a motivo di un animale domestico, di un nonno, o peggio, scopriamo come la vita va a finire sempre e comunque.
Da allora parte l’atteggiamento ambiguo di voler sapere e non sapere contemporaneamente. Vogliamo sapere altrimenti non avrebbero senso gli oroscopi, le zingare che leggono la mano, i veggenti, tutte le religioni, ma anche le analisi cliniche, le risonanze magnetiche, Standard &Poors, Fitch, Moody’s. Però nessuna deve essere assolutamente certa, lasciandoci l’illusione che le cose andrebbero in quel modo se non ci fossimo noi, che invece sapendolo preventivamente faremo in modo… di scongiurarlo o di accelerarlo? Ci vorrebbe un’altra previsione per saperlo.
Questa prospettiva dello spoiler ci fornisce anche un’altra chiave di lettura dei conflitti generazionali
Noi vecchi siamo lo spoiler dei nostri figli che vedono in noi come andranno a finire (mio nonno, che mi sembrava vecchissimo quando era più giovane di me adesso e al quale allora non mi sembrava affatto di somigliare e adesso sono uguale, diceva che prima di fidanzarsi bisognava andare a vedere la madre e la nonna della ragazza perché “se tanto mi da tanto…”). Al contrario, da parte nostra anche vedere il prequel dalle mille promesse e speranze che non saranno mantenute può essere irritante o triste.
Ora mi viene da immaginare una storia dove un gruppo di terroristi riesce a penetrare nel cavau al centro della terra dove sono custoditi gli spoiler della vita di ciascuno (mi rendo conto solo ora che un racconto sullo stesso tema lo scrissi a vent’anni, lo ricopio alla fine) e con in mano quest’arma tenta di asservire l’umanità. Naturalmente fallisce sia perché i cattivoni non devono vincere mai, almeno nelle realtà che ci inventiamo, e secondo perché la conoscenza del finale suscita reazioni diverse.
C’è chi si dispera e vuole lasciarsi morire o uccidersi ma ovviamente non riesce perché altrimenti contraddirebbe lo spoiler stesso.
C’è chi diventa un eroe e sprezzante di ogni pericolo si batte per cambiare il mondo, o non perde nessuna occasione di godimento, certo che nulla potrà fargli male, e non sa che sarà una stupida salmonella nel tiramisù dell’Hotel Splendid di Amalfi a scioglierlo a 85 anni suonati nella tazza del cesso dove alloggerà col prestigioso “centro anziani parioli di Roma”.
I più continuerebbero la vita di tutti i giorni assaporando la ciccia e sputando le spine e ai terroristi riderebbero in faccia dicendo “lo sapevamo già”.
In effetti questa è una vicenda reale avvenuta nel 987 in Turchia quando l’umanità era presa dalle paure millenaristiche e se ne è ritrovata traccia solo nel 1945 quando furono scoperti i corpi dei terroristi nella meravigliosa Cisterna basilica di Istanbul. Sembra che trovato l’archivio per prima cosa iniziarono a spoilerarsi reciprocamente l’esistenza ma, al contrario dei miei figli, erano armati.
Comunque Karl è morto come è inveterata usanza di tutti i viventi.
Ma sì, certo, tranne noi.
Ecco il racconto dei vent’anni: Lo scherzo di Calcantera
I primi anni del regno del giovane Carlo corsero felici e rapidissimi, come quei periodi di serenità di cui ci si avvede soltanto quando sono passati.
Tutta la corte viveva in un clima di festa nell’attesa di un futuro sempre migliore che sembrava a portata di mano; lo stesso Carlo sembrava aver dimenticato le parole del padre morente che lo avevano, per la prima volta, messo al corrente della leggenda (ma sarà poi solo leggenda?) che tutti sapevano e tacevano e solo lui, principe ereditario, ignorava fino a quel momento.
Del resto Carlo era sì un re ma era soprattutto un ventenne ed a quell’età non si pensa a tali cose se non in certi pomeriggi piovigginosi di novembre, quando, il freddo e la morte ti afferrano, magari solo per un istante, lo stomaco.
La leggenda che il re padre aveva raccontato a Carlo sul letto di morte voleva che per ogni regnante che succedeva sul trono, esisteva un suddito che era a conoscenza della data esatta della morte del nuovo re. Il padre disse ancora a Carlo che lui aveva per tutta la vita allontanato questo pensiero, anche se negli scantinati dell’anima era sempre rimasto come un tumore non debellato che non gli aveva permesso di assaporare appieno il gusto di una vita giusta e piena di soddisfazioni.
Ancora più improbabile era stato il confuso racconto che il padre aveva fatto circa l’origine di tutta la vicenda; egli sosteneva infatti che tale maledizione provenisse direttamente da un demonio, detto Calcantera, piuttosto altolocato nella gerarchia infernale, che circa quattrocento anni prima albergava in una grotta sul fondo del fiume Tinna che attraversa tutto il regno, dalla quale venne fatto brutalmente sloggiare, con grande sollievo della popolazione tutta, grazie ad un’idea geniale del loro avo Agostino III che fece benedire il fiume trasformandolo in un fiume di acqua santa e il lago Tuttatinna in una sorta di gigantesca acquasantiera. Calcantera che per poco non morì sul colpo, conservò addosso un tale odore di acquasanta che divenne insopportabile a tutti gli altri diavoli e, persi tutti i suoi privilegi, fu relegato ai più umili servizi infernali tra la derisione generale.
Lucifero tuttavia, memore dei meriti del suo sfortunato collaboratore, ormai per sempre inutilizzabile dato quell’orribile odore di sacrestano che aveva, gli concesse di organizzare questo scherzetto ai danni dei successori di AgostinoIII, ben sapendo quanto gli uomini temano di conoscere l’ora della propria morte pur essendo questa l’unica certezza della vita. Tuttavia non poteva, neppure Lucifero in persona, andare contro la regola generalesche il Buon Dio aveva messo, sapendo quanto penosa sarebbe stata la vita dei suoi figli se avessero conosciuto il tempo esatto che è dato loro: tale regola vieta all’uomo di sapere quando sarà il suo momento. Lucifero, però, aggirò l’ostacolo perché la data della morte del re sarebbe stata conosciuta da un altro.
Carlo, con la sfrontatezza dei giovani che credono di essere quelli che finalmente risolveranno ogni problema, decise di prendere il toro per le corna e inviò i suoi gendarmi per tutto il reame a rintracciare con la lusinga di una grossa ricompensa, “colui che sapeva”. Furono necessari mesi e mesi di ricerche, e non ci fu affatto, come re Carlo temeva, chi si facesse avanti, magari pur non sapendo un bel niente: alla gente questa storia non piaceva, anzi aveva paura e cercava in ogni modo di allontanare da sé qualsiasi sospetto.
La grossa ricompensa si trasformo in una taglia; iniziarono le spiate, Re Carlo non sopportava più che “colui che sapeva gli sfuggisse, ciò era una ulteriore riprova delle sue cattive intenzioni.
Quando glielo portarono in catene Carlo provò un senso enorme di sollievo e quasi rise delle sue passate preoccupazioni. Si trattava di Arturo, un carrettiere basso, giallognolo, grasso a tal punto da muoversi con difficoltà e soprattutto quasi analfabeta.
Re Carlo volle rimanere da solo con Arturo e gli spiegò come lui stesso in persona si sarebbe occupato con amore del mantenimento dei suoi figli dopo che la sua testa fosse caduta sotto l’ascia del boia mettendo fine a questa incresciosa storia.
Carlo spiegò al carrettiere che non ce l’aveva affatto con lui personalmente che anzi era conosciuto per essere un suddito fedele, ma che era costretto ad ucciderlo perché se Arturo, magari per cattiveria o per trarne vantaggio, o anche solo perché impazzito o ubriaco avesse parlato con altri, i suoi oppositori si sarebbero enormemente avvantaggiati dal conoscere il tempo della sua morte; se invece avesse parlato con il re stesso gli avrebbe rovinato l’esistenza, oscurandola con quella consapevolezza tanto gravosa all’animo umano.
Arturo con calma e umiliandosi della sua misera condizione spiegò al Re come lui fosse l’unico suddito della cui salute sua maestà si sarebbe dovuto preoccupare per prolungargli al massimo la vita, Infatti se la maledizione di Calcantera voleva che ci fosse sempre un suddito a conoscenza della data della morte del re evidentemente tale suddito, lasciò intendere con un certo imbarazzo e quasi scusandosi, doveva vivere sicuramente più del re; altrimenti quel “sempre almeno uno” non sarebbe stato rispettato.
Arturo aggiunse che sua maestà poteva certamente fargli tagliare la testa, ma, per non morire anch’egli un istante prima, doveva prima permettere a lui di comunicare il suo segreto ad un altro e così il problema non sarebbe stato risolto ma solo spostato, a meno che uno dopo l’altro non avesse tagliato la testa a tutti i suoi sudditi; fino a rimanere in vita solo lui e l’ultimo dei suoi sudditi, detentore del segreto e destinato a vivere più del re e probabilmente desideroso di vendicarsi per la strage e con un’arma terribile a disposizione: la parola.
Da quel momento qualcosa si ruppe definitivamente dentro l’animo spavaldo di re Carlo e sul suo viso iniziarono a marcarsi i segni degli anni: si era cacciato in una situazione da cui non poteva tornare indietro, la spensieratezza era irrimediabilmente perduta.
Arturo intanto si stabilì a corte ed era oggetto di ogni cura per ordine dello stesso re Carlo, che voleva essere costantemente informato sulla sua salute e sul suo umore. In poco tempo perse i modi da carrettiere, acquistò un linguaggio forbito e, rivestito dal sarto reale, non sembrava più lo stesso: sì, sempre piuttosto basso, ma quasi bello. Di giorno in giorno le sue richieste al re aumentavano. Aveva iniziato col chiedergli un cavallo ed il re gli aveva dato il migliore, ma lui, non contento, quasi per un capriccio, aveva preteso quello del re stesso. Intendiamoci nel chiedere non aveva affatto modi arroganti, anzi si scherniva, si scusava ed il più delle volte non chiedeva neppure ma si limitava a far capire che si, insomma, avrebbe gradito. Il cavallo era stato il primo passo, poi volle palazzi e ville in campagna, le donne più belle e persino la preferita di re Carlo. Voleva partecipare a tutte le manifestazioni a fianco del re e Carlo non osava mai dirgli di no sebbene la sua esistenza fosse divenuta un inferno insopportabile dal quale non vedeva via d’uscita e che reputava la meritata punizione per il suo orgoglio giovanile.
Un giorno la possibile via d’uscita gliela suggerì involontariamente lo stesso Arturo che ormai despota incontrastato del palazzo reale chiese a Carlo di fargli provare la corona durante una festa di gala. La notte stessa Carlo mise a punto il suo piano che gli parve geniale. In piena notte svegliò personalmente il primo ministro ed il suo vecchio confessore, un vecchio frate che aveva battezzato Carlo ed era stato per lui un secondo affettuosissimo padre. Si trattava in sostanza di abdicare in favore di Arturo con la sola clausola che alla morte di questi la corona sarebbe tornata sul capo di Carlo. Arturo diventato re, avrebbe conosciuto l’ora della sua morte e tale insopportabile pensiero l’avrebbe rapidamente condotto a morte per crepacuore.
I tre ragionarono attentamente per cogliere eventuali falle del piano; non c’era dubbio che Arturo era destinato a conoscere l’ora della morte del re, cioè di colui che regnava in quel momento e quindi in quel caso di se stesso. Il frate sollevò perplessità circa il fatto che la morte di Arturo potesse essere anticipata proprio dalla conoscenza della data di tale morte: come era possibile che un evento fosse causa della modificazione di se stesso? Come sarebbe potuto morire subito Arturo per aver saputo che sarebbe morto tra tre anni? Infatti, se fosse morto subito si sarebbe dimostrata falsa la sua conoscenza circa la data della morte e dunque egli effettivamente non sapeva esattamente quando sarebbe morto, ma solo che ciò sarebbe accaduto come tutti noi.
La mattina Arturo che dormiva nella stanza più bella di tutta la reggia fù svegliato dal rullio del tamburo del banditore che proclamava ad ogni angolo, nelle piazze, nelle frazioni del regno sparse sulle colline come margherite in un prato che re Carlo aveva abdicato in suo favore. Nello stesso momento in cui si rendeva conto di essere diventato Re Arturo I, la primavera che prepotentemente entrava dalla sua finestra si raggelò e perse di significato e colore e con lo sguardo fisso in cielo che gli parve per sempre grigio, Arturo vide con certezza quando a lui toccava morire.
Un altro al suo posto sarebbe sicuramente morto di crepacuore, ma il suo animo di carrettiere, abituato alla fatica e al dolore, il suo passato di offese e umiliazioni lo avevano temprato anche a vivere con la morte nel cuore. E così visse.
Carlo costatato il fallimento del suo piano e la sua cattiveria per aver prima rifiutato l’insegnamento del padre, poi sfidato Calcantera ed alla fine aver rovinato la vita al carrettiere, si pentì amaramente e rinunciato al diritto di rientrare in possesso del suo regno, si ritirò in preghiera in una grotta del monte Sutinna dove fu presto dimenticato da tutti.
Per trent’anni Arturo regnò con la morte a fianco e tutto il reame divenne triste e lugubre: non più feste, non più allegria. Tutte queste cose erano punite con ferocia estrema dal re che invidiava con malvagità ogni suo suddito che poteva sorridere ignaro della propria morte.
Dopo trent’anni Arturo sentì di essere enormemente stanco e chiese aiuto al giovane cappellano di corte: era disposto a tutto pur di togliersi quel pensiero che lo tormentava.
Il giovane prete disse che personalmente non poteva far nulla ma sapeva di un vecchio eremita che viveva da sempre sulla montagna ed a cui erano attribuiti tanti miracoli.
Re Arturo si vestì da penitente e da solo si avviò alla montagna. Quando furono faccia a faccia i due vecchi non si riconobbero ma provarono entrambi un enorme struggimento.
L’eremita sedette, prese tra le mani la testa di Arturo in ginocchio di fronte a lui e asciugandogli le lacrime lo invitò a confessare a Dio ogni sua pena per liberarsene. Arturò singhiozzo e parlo per ore e solo quando disse a Carlo la data della sua morte si senti liberato, dimenticò tutto, gli sembrò persino che quei trent’anni di sofferenza non fossero mai esistiti.
Passarono alcuni mesi felici e rapidissimi di cui ci si avvede solo quando sono passati. Una mattina il cappellano per rassicurare ancora di più re Arturo disse che doveva star certo che il vecchio eremita non avrebbe rilevato a nessuno la data della morte del re e che… Arturo impallidì, non capiva… quale eremita?
Si fece spiegare tutto dal riluttante cappellano che si era nel frattempo reso conto di aver combinato un guaio gravissimo: il re non ricordava più perché l’uomo non può sapere di aver saputo una cosa che non sa più.
Ascoltato tutto il racconto piombò su di lui l’inferno, non trovando più pace inviò i suoi gendarmi per tutto il reame a rintracciare “colui che sapeva”; gli avrebbe fatto tagliare la testa e tutto si sarebbe sistemato.
Quando gli condussero dinanzi in catene il vecchio Carlo, questi si mostrò calmissimo ed iniziò a spiegargli perchè non gli avrebbe mai fatto tagliare la testa ed anzi…
RUBRICA CIOTTOLI DI PSICOPATOLOGIA GENERALE