Alimentazione e salute mentale – Report dal Convegno di Palermo, 28 e 29 Settembre 2018
La PsicoNutrizione si rende necessaria quando si riscontrano difficoltà ad attenersi a un modello dietetico idoneo; essa affronta le problematiche della fame emotiva e della dipendenza da cibo supportando chi vuole dimagrire ma incontra difficoltà a lungo termine.
Alimentazione, salute psicofisica, prevenzione, sensibilizzazione a un corretto stile di vita: questi i temi centrali del Convegno “Alimentazione e Salute Mentale. Le nuove conquiste del legame mente-corpo” svoltosi il 28 e 29 Settembre scorsi nella sontuosa cornice di Villa Igiea.
Un susseguirsi di relazioni a carattere medico e psicologico, in linea con quanto indicato dall’OMS sul concetto di salute come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”, dove un ruolo centrale occupa la prevenzione delle malattie correlate all’obesità, quali le malattie cardivascolari e il diabete.
Il Convegno sottolinea la sinergia tra psicologo e nutrizionista a supporto del paziente che si accinge a seguire con successo un piano alimentare personalizzato e si pone, altresì, l’obiettivo di sensibilizzare gli aspetti di prevenzione e cura per uno stile di vita sano e duraturo nel tempo – introduce la dott.ssa Paola Di Natale, Presidente e Responsabile Scientifico del convegno – In questa direzione si muove la PsicoNutrizione come sostegno a uno stile di vita sano, prima dell’insorgenza dei problemi.
La prevenzione deve iniziare già nella vita prenatale, nella misura in cui i geni possono essere modificati dalle esperienze ambientali, così che il DNA non sia il nostro destino, come sottolinea l’epigenetica – argomenta la dott.ssa Nicoletta Salviato, Responsabile UOS Educazione e Promozione della salute, ARNAS Civico di Palermo – Una corretta prevenzione si rende necessaria per ridurre la probabilità di insorgenza della sindrome metabolica, complessa, patologia che vede associate, tra le altre, insulino-resistenza, obesità centrale e ipertensione arteriosa ed è collegata all’insorgenza dell’Alzheimer.
Oggi sempre più importanza si dà in medicina al concetto di nutraceutica, che indica come il cibo possa essere la prima efficace soluzione terapeutica – sottolinea Raffaella Mallaci Bocchio, biologo nutrizionista – In particolare i nutraceutici, come la Berberina e le fibre solubili, sono un buon coadiuvante insieme a dieta e trattamento farmacologico sia in fase di prevenzione che trattamento del diabete mellito di tipo 2, associato con aumento del rischio cardiovascolare.
L’ARTICOLO CONTINUA DOPO LE IMMAGINI:
![]() Imm. 1 e 2 – Immagini dal convegno Alimentazione e Salute Mentale
Imm. 1 e 2 – Immagini dal convegno Alimentazione e Salute Mentale
Dal punto di vista della lotta ai problemi di sovrappeso e obesità e considerando l’importanza di un piano alimentare sostenibile, praticabile e accettato dalla persona colpita dal disturbo alimentare, che apporti cambiamenti duraturi nel tempo, e che si interessi della gestione della fame emotiva, un ruolo di primo piano è svolto dalla PsicoNutrizione, approccio olistico e integrato tra Psicologia e Scienza dell’Alimentazione.
La PsicoNutrizione si rende necessaria quando si riscontra difficoltà ad attenersi a un modello dietetico idoneo; essa affronta le problematiche della fame emotiva e della dipendenza da cibo supportando chi vuole dimagrire, ma incontra difficoltà a lungo termine – spiega Di Natale – Ecco che lo psicologo lavorerà sulla motivazione al cambiamento, sull’immagine corporea e sull’autostima, mentre il nutrizionista, attraverso il percorso di educazione alimentare, la dieta e la perdita di peso, inciderà sugli aspetti psicologici.
Psicologia e biologia, un binomio che richiama la correlazione tra alimentazione e salute mentale, come afferma il prof. Ramilli, fondatore della Psicobiotica.
La Psicobiotica considera non solo l’importanza del cibo inteso nel senso classico, ma anche come il cibo-emotivo, poiché le emozioni possano condizionare la fisiologia e la funzionalità dell’organismo fino a creare vere e proprie patologie (stress, depressione…). È importante sottolineare, in tal senso, l’importanza dei rapporti sociali, delle relazioni amicali e degli ambienti di lavoro poiché condizionano notevolmente la nostra salute.
Un’integrazione che richiama il concetto di unità mente-corpo e che rimanda alla necessità di un monitoraggio dei propri stati mentali che, se scarsamente regolati, per esempio sul versante depressivo, si traducono in disregolazione alimentare, promuovendo malessere psicofisico e rendendo sempre più complesso, con lo strutturarsi di abitudini disfunzionali, l’obiettivo di uno stile di vita salutare, preventivo rispetto a ogni sorta di patologia dell’organismo.






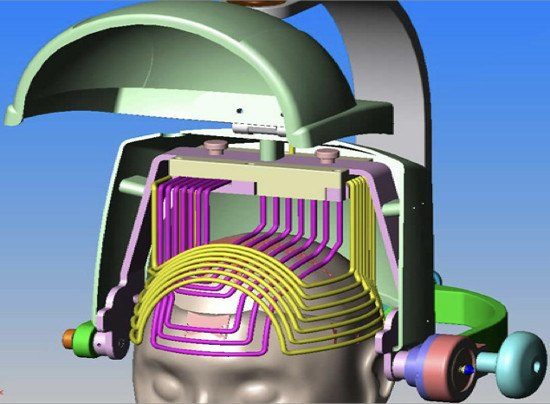

 RUBRICA: INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA
RUBRICA: INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA