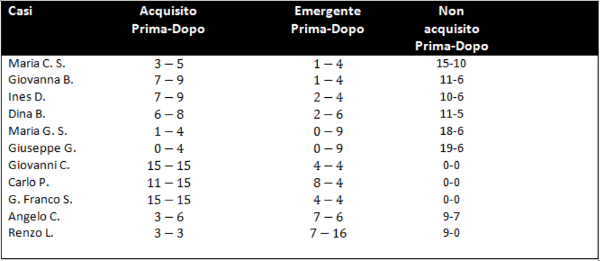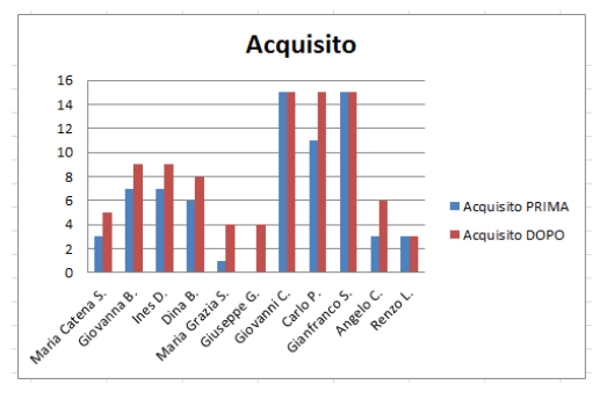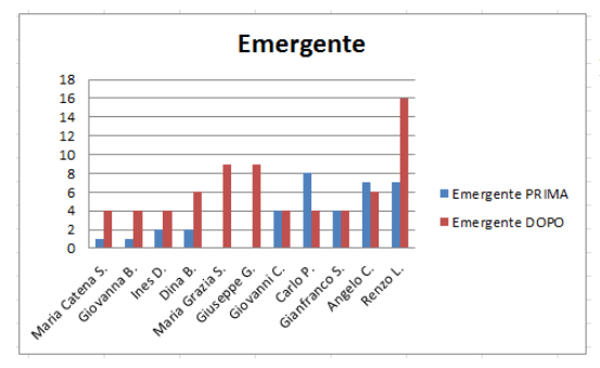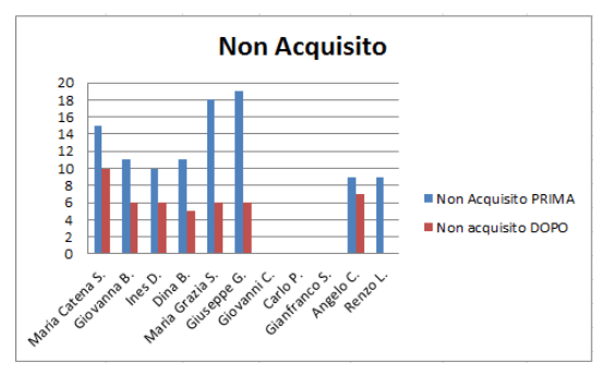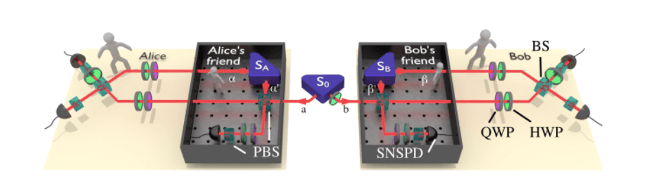In attesa del delirio – In preparazione all’inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020 della Sigmund Freud University di Milano
Questo articolo su State of Mind vuole essere premessa e cornice di riferimento all’intervento che Sandra Sassaroli, benevolente, per antica amicizia e prolungata complicità, mi ha chiesto di portare all’inaugurazione dell’anno accademico 2019/20 della Sigmund Freud University
(NdR: Roberto Lorenzini non sarà presente all’inaugurazione dell’anno accademico, al suo posto interverrà il Prof. Giovanni Maria Ruggiero)
In attesa del delirio – I parte
Questo articolo su State of Mind vuole essere premessa e cornice di riferimento all’ intervento che Sandra Sassaroli, benevolente, per antica amicizia e prolungata complicità, mi ha chiesto di portare all’inaugurazione dell’anno accademico 2019/20 della
Sigmund Freud University (mica pizza e fichi!) su quello che era il mio cavallo di battaglia nei tempi esaltanti degli ideali antipsichiatrici e della sporca pratica territoriale, ovvero “la comprensione, il senso ed il trattamento del delirio” e che ora definirei più propriamente il mio ronzino da marchette nel tempo del pensionamento e delle incalzanti spese sanitarie. Approfitto, dunque, come ogni buon italiano che si rispetti affascinato dai balconi, del pulpito che mi è offerto per abbaiare arrogante una predica, come si addice ai vecchi, diretta a coloro che saranno i futuri ricercatori e psicoterapeuti o sono tuttora in servizio permanente effettivo nell’esercito dei consolatori di anime inquiete come la loro per evitare che ripetano quelli che reputo gli errori perpetrati dalla mia generazione permettendogli di farne altri magari opposti ma comunque del tutto nuovi.
Il ‘900, il cosiddetto secolo breve (che tale risulta ad Hobsbawm solo perché lo considera dal 1914 al 1991), ha visto con l’affermarsi degli stati-nazione e della tecnologia una conflittualità globale senza precedenti. Allo stesso modo, forse per alchemico isomorfismo una sorta di spinta sovranista, per dirla con un termine tristemente attuale, ha motivato la psichiatria a rivendicare la propria autonomia dalla neurologia e invocato “la separazione delle carriere” per cui mentre prima con tre anni di specializzazione si diventava neuropsichiatri tout court, poi ne sono diventati necessari 4 per la neurologia e altrettanti per la psichiatria, ma ognuno era felicemente padrone in casa propria. Poco importa se al prezzo di disorientare i pazienti, sarebbe valso loro come utile allenamento per orientarsi poi tra le mille diverse e più o meno blasonate psicoterapie che andavano affermandosi, distinguendosi puntigliosamente e orgogliosamente l’un l’altra nel tempo della inarrestabile avanzata farmacologica somigliando così ai proverbiali capponi di Renzo Tramaglino.
Tale processo sovranista e autonomistico era in linea con la deriva iperspecialistica di tutta la medicina occidentale che è diventata sempre più medicina d’organo, di cellule se non di molecole, perdendo di vista la complessità dell’essere umano e lasciando così ampio spazio agli approcci olistici delle medicine non tradizionali che mantenevano, se non altro, il pregio di visitare, toccare, guardare, annusare e persino ascoltare il paziente creando una relazione, indicata dal saggio Ippocrate su cui ancora giuriamo, come il primo dei medicamenti, non limitandosi semplicemente a prescrivere esami strumentali e di laboratorio per inviare poi ad un altro e più specifico iperspecialista. La medicina difensiva ha poi accelerato ulteriormente questo processo e il paziente abbandonato a se stesso si è rivolto senza un Virgilio a guidarlo sui tortuosi sentieri di internet combustibile pregiato per ogni onanismo ipocondriaco.
La medicina in generale e con essa la psichiatria soprattutto accademica -un po’ meno quella dei colleghi ruspanti e praticoni impegnati sui molteplici fronti della psichiatria territoriale nata nel 1978 dalla legge Basaglia che però, ingiustamente afflitti da un complesso di inferiorità da deprivazione da camice bianco e stetoscopio a tracolla, non producevano cultura scientifica- ha smesso di considerare la malattia come un segnale di disagio esistenziale da ascoltare e utilizzare per reindirizzare la propria vita e, invece, l’ha oggettivata come un nemico esterno ed estraneo semplicemente da sconfiggere e annientare –ovvero rendere niente- come fosse altro dal soggetto che l’ha prodotta, da qui l’utilizzo di una terminologia prevalentemente bellica del rapporto tra il malato e la sua malattia. In tal senso trovo inopportuna la personificazione della malattia come quando si parla del disturbo ossessivo compulsivo come di un parassita estraneo che ci ha infettato. In tal modo si asseconda l’idea che non dipenda da noi e sia fuori del nostro controllo alimentando la fantasia di molti pazienti che ci chiedono di eliminare il sintomo non modificando però nulla del loro modo di stare al mondo (non si può fare, non funziona). Illusione su cui prolifera la lobby farmaceutica. Negli ultimi decenni del secolo scorso il pendolo ha invertito la direzione ed è iniziato un movimento opposto di ricomposizione mente/corpo grazie alle neuroscienze che tuttavia rischia di generare quelle terribili semplificazioni, verso cui metteva in guardia già Bateson, che possono uccidere la psicologia, la riflessione psicopatologica e conseguentemente la psicoterapia mentre, al contrario, i suoi risultati, se esaminati criticamente in una prospettiva a centralità psicologica che ponga l’uomo come il livello su cui è utile riflettere, possono esserne un sostegno solidissimo. Ormai è evidente come gli psicofarmaci non mantengano affatto le strepitose promesse delle aziende produttrici perché la loro efficacia è spesso parziale, modesta o nulla; la loro azione è tutt’altro che specifica e mirata, ma piuttosto generica e grossolana (non più intelligente delle bombe americane che colpiscono asili e ospedali); l’effetto è quasi esclusivamente sintomatico e transitorio e non è affatto chiaro su quali dimensioni agiscano per produrre la riduzione sintomatologica auspicata. Detto in altri termini, significa che se ne conosce appena il meccanismo d’azione a livello biochimico e si ignora quasi del tutto il passaggio tra questo e lo psichico. A tal proposito si consideri che alcuni farmaci (vedi gli antidepressivi serotoninergici) sono efficaci su sintomi molto diversi tra loro come ansia e depressione, è dunque ipotizzabile che agiscano su una sottostante dimensione comune. La sfida per l’identificazione di un mediatore prossimale dell’efficacia non riguarda solo i farmaci.
Infatti se è vero che sarebbe importante capire come gli antidepressivi serotoninergici migliorino sia la depressione che l’ansia, ad esempio reindirizzando l’attenzione su eventi positivi (se ci concentriamo sul bene siamo sia meno depressi che meno ansiosi) potenziando così l’illusione ottimistica che ci rende tollerabile l’esistenza, altrettanto importante sarebbe, ad esempio, comprendere in che modo le esperienze precoci negative costituiscano un fattore di rischio per la salute mentale. Insomma, entrambi gli approcci dovranno collaborare per definire quelli che possiamo chiamare “mediatori prossimali” o “dimensioni sottostanti” per scoprire probabilmente che sono gli stessi. Questo è un compito comune per dare una solida base sia agli interventi farmacologici che a quelli psicosociali e riabilitativi. Per procedere in questa direzione occorrono modelli esplicativi psicologici che non possono essere inferiti dalle ricerche delle neuroscienze che spesso compiono l’errore, tipico di una scienza giovane, di scambiare semplici correlazioni per rapporti causali. Ciò, speriamo, varrà a superare l’attuale genericità del modello “multifattoriale sommatoristico” (conio questo orribile neologismo) che non risolve il problema centrale di stabilire se esista una differenza tra “res extensa” e “res cogitans” e, se sì, dove sia il passaggio, insomma dove la materia diventi spirito e il cervello mente. Che la mente stia nel sistema nervoso (forse non solo in quel pezzo che sta nel cranio) e sia un suo prodotto è un’ovvietà, ma questo non significa affatto che le malattie della mente siano malattie del cervello e neppure che tutte le malattie del cervello determinino necessariamente malattie mentali, sebbene possa darsi che i due fenomeni in taluni casi siano sovrapposti.
Attenzione! Non si tratta di stabilire quale sia il livello di descrizione ultimo, basilare, quello più vero a cui tutti gli altri possono essere ridotti -perché ciò già presupporrebbe che esistano livelli diversi e non semplicemente categorie e linguaggi differenti per parlare della stessa cosa- ma semmai quale sia il livello di descrizione più utile ovvero più euristico, che permetta cioè di fare previsioni attendibili. Ora considerato che noi siamo persone e ci interessa capire e prevedere come funzionino le persone, ad iniziare da noi stessi, il livello di descrizione più utile è quello personale. Se fossimo mitocondri ci sarebbero utili teorie sul funzionamento dei nostri colleghi e altri organelli vicini nel citoplasma cellulare e se fossimo molecole di carbonio saremmo interessati alle attitudini dell’ossigeno e dell’idrogeno. Un romanzo può essere descritto e valutato per il suo contenuto ed altrettanto correttamente analizzando l’inchiostro o i pixel con cui è scritto ma quale è il livello che ci interessa? Se voglio raggiungere Milano in treno non è interessante conoscere la struttura delle vetture, delle rotaie e il tipo di propulsione, ma gli orari, le fermate e i costi. Allo stesso modo, un essere umano può essere descritto a livello del suo funzionamento globale oppure del funzionamento dei suoi singoli apparati vitali, o, scendendo ancora, degli organi che li compongono, delle cellule di cui questi sono costituiti e infine delle singole molecole.
Ancora, non è forse vero che la cultura e l’arte, in tutte le loro manifestazioni, altro non sono che biochimica che funziona secondo le leggi immutabili della chimica stessa e della fisica quantistica come qualsiasi entità esistente. Ma è quello il livello euristico quando parliamo di arte e cultura? Certo tutto quello che avviene nel mondo fisico è secondo le sue leggi, ma vederlo da questo micro punto di vista non ci aiuta a fare previsioni, che è ciò che ci interessa per indirizzare gli eventi secondo i nostri scopi. Ognuna di queste descrizioni può essere vera, ma quale è euristica per noi essere umani? Discuterò le conseguenze di queste considerazioni nella seconda parte.
In attesa del delirio – II parte
Insomma, il rischio di un’interpretazione banale di neuroscienze priva di un modello psicologico è di trovare i siti, i loci, i recettori, i mediatori e di perdere l’uomo che solo nell’incontro con un altro essere umano si rivela pienamente. Ogni riduzionismo a un livello sub personale può essere utile solo se serve a sostenere o a falsificare una spiegazione a livello personale. Rivendicare questa centralità è compito precipuo delle scienze umane e in primis della psicologia che non deve sentirsi in soggezione rispetto ad altre scienze “dure” ma, al contrario, rivendicare orgogliosamente il suo primato. Il modello mentalistico cognitivista attuale che utilizza i concetti di “scopi, credenze ed emozioni” permette finora previsioni facili e chiare sul funzionamento sano e patologico degli esseri umani e sono tali modelli a dover guidare la ricerca delle neuroscienze.
Un ulteriore equivoco spesso frequente nelle neuroscienze è che una diversità morfologica o funzionale nel cervello di un malato viene considerata la causa della malattia stessa. Il cervello di un panicoso con la sua amigdala extra large (non so se sia vero, è solo un esempio che mi veniva bene) è diverso dal cervello di chi non lo è; anche i cervelli di un pianista, di un tennista, di un wrestler, di un monaco zen sono diversi da quelli degli altri, ma ciò non significa assolutamente nulla. Potremmo più correttamente affermare che le menti sono ciascuna diversa dall’altra esattamente come i cervelli che le ospitano e, di più, che ogni mente modella il suo cervello e ogni cervello modella la sua mente. Certo, un processo psicopatologico, come ogni processo psicologico, è un processo cerebrale (per tali ovvietà si è usi ringraziare “le tre Grazie” in un modo conciso e poco elegante) e possiamo dire che l’esperienza plasma continuamente il cervello, per cui le parole (psicoterapia) e ogni esperienza (riabilitazione) ristrutturano morfologia e funzionamento del cervello. A sua volta il cervello modifica la mente e determina così le esperienze che lo modificheranno retroattivamente. Addirittura si può ipotizzare come fa Daniel Dennet che il meccanismo di funzionamento scopi/credenze, valido per il livello psicologico personale, lo si ritrovi sebbene senza la coscienza a tutti i livelli sub-personali fino alle molecole, per cui tutti hanno un target da raggiungere e una mappa più o meno grossolana dell’ambiente circostante e, dunque, l’intenzionalità e la conoscenza ambientale riguardano ogni elemento vivente, senza bisogno di scomodare coscienza e consapevolezza che spesso fanno più casino che altro inceppando la fluidità degli automatismi istintuali.
Oddio stavo per perdere il filo e il tono minaccioso della predica per cui serro le mani sul pulpito e riprendo savonarolamente.
Un altro pericolo verso cui mettere in guardia i giovani colleghi è quello della diagnosi. Le diagnosi categoriali si moltiplicano a ogni nuova edizione del DSM con molteplici rischi: in primo luogo una diagnosi, soprattutto se grave, rischia di diventare una profezia che si autoavvera, un destino; in secondo luogo rende ciechi a tutto ciò che non la invalida e iperattenti alle conferme come ci ha drammaticamente insegnato l’esperimento agghiacciante noto come “la beffa di Rosenhan”?; in terzo luogo mortifica l’originalità e unicità nel bene e nel male di ogni essere umano; in quarto luogo ci dà l’illusione di spiegare un funzionamento mentre lo etichetta soltanto; in quinto luogo ormai l’incontinenza diagnostica del DSM finisce per “patologizzare” e ovviamente “farmacologizzare” (non state subito a pensar male o vi prenderete, appunto, la diagnosi di “paranoici complottisti” e sarete spediti nel girone dei terrapiattisti, striatori chimici, ecc.) territori sempre più vasti dell’esperienza umana deresponsabilizzando gli individui: non esistono più i cattivi, i depravati, i delinquenti e i viziosi ma solo “indisposti” o al massimo “disturbati” per cui trovare la pasticchetta giusta. Utilizziamo pure le diagnosi dunque per parlarci ai congressi e scrivere articoli ma senza crederci veramente perché altrimenti oggettivando le persone ostacoliamo quella comprensione empatica profonda degli esseri umani possibile perché nulla di ciò che è umano ci è estraneo come scriveva già Terenzio l’altro ieri: ”Homo sum, humani nihil a me alienum puto”.
Il funzionamento o disfunzionamento di un individuo è un concetto relazionale e riguarda il suo adattamento a un determinato ambiente che per la specie umana è sempre un ambiente sociale e culturale, per cui “sano” è interpretabile come “adattato” e ciò crea non pochi problemi quando a non essere sano è il contesto: vedi tutta l’originale opera di Ronald Laing, un tempo vangelo dei giovani psichiatri ed oggi pressoché ignorata dai più. Molto può insegnarci in tal senso la psichiatria transculturale, oggi sempre più attuale grazie ai flussi migratori. I nostri comportamenti e le nostre emozioni possono apparire del tutto folli ad altre culture e viceversa. Infine (i luoghi usati come ordinali per le argomentazioni contro le diagnosi sono finiti col quinto) la diagnosi ci induce a credere che le malattie esistano veramente, che nella realtà oggettiva esista qualcosa come la schizofrenia o il disturbo ossessivo compulsivo: non è vero!
Mi piace pensare invece che ogni tipo di disturbo rappresenti in forma estrema un certo modo di stare al mondo -sto pensando in particolare ai disturbi di personalità- che in qualche fase dell’ontogenesi (storia individuale) e della filogenesi (evoluzione della specie) sia stato utile e adattivo e dunque costituisca una potenzialità che, paradossalmente andrebbe protetta come la biodiversità.
Dal pericolo del diagnosticismo militante si genera l’altrettanto dannoso mito delle tecniche che vanno enormemente proliferando e che, secondo un modello medico deteriore vedono il terapeuta applicarle, come se si trattasse di farmaci o manovre chirurgiche su un paziente passivo che le accetta possibilmente senza tante storie o, per dirlo più elegantemente, resistenze.
In attesa del delirio – III parte
L’ultima favola da cui voglio mettere in guardia i giovani colleghi è quella della guarigione, proponendo un’attenta riflessione sul ruolo sociale della psichiatria e della psicoterapia. Una scienza, infatti, non può smettere mai di interrogarsi, oltre che sulle sue procedure, per migliorarle continuamente, sul suo scopo o, come si dice oggi, sulla sua “mission”. Qual è l’uomo sano e quello da curare? Da questo problema se ne esce solo accettando l’autoreferenzialità per cui non è sano e da curare solo chi soggettivamente si ritiene tale, il che significa che solo i vissuti egodistonici meritino un’attenzione terapeutica. Ciò, tuttavia, non esaurisce il campo tradizionale della psichiatria che, da sempre, oltre ad una vocazione realmente terapeutica che pone al centro l’individuo e vuole renderlo libero e autenticamente se stesso, ha anche un’implicita missione normalizzatrice e custodialistica che protegge la società e i suoi valori, arrivando agli eccessi dei manicomi dove i regimi totalitari rinchiudono i dissidenti ma che è sempre stata presente sin dai tempi del grande internamento che relegava in un unico recinto tutti i devianti fisici, mentali, morali e culturali (mio nonno chiamava chi faceva il mio lavoro “castigamatti”, sempre meglio dell’odioso “strizzacervelli” newyorchese).
Se la mano che la psichiatria mostra più volentieri è quella compassionevole che sostiene l’individuo in difficoltà e cerca di promuoverlo, ne ha anche un’altra nascosta dietro la schiena che vuole normalizzare e omologare. Dovremmo ripensare la malattia, dal disturbo d’ansia al delirio più franco, come il modo migliore che l’individuo ha trovato per sopravvivere in un certo ambiente, quanto di meglio è riuscito a fare per cavarsela. È un po’ come per gli stili di attaccamento (sicuro, evitante, ambivalente, disorganizzato): ciascuno di essi è il più efficace per mantenere la maggiore vicinanza possibile con la figura di attaccamento che si è avuta in sorte, quindi possiamo dire che ogni pattern è il migliore possibile per cavarsela in un certo contesto. Occorre, dunque, chiedersi quale sia il modello verso il quale siamo inconsapevolmente indotti ad adeguare i nostri pazienti e quanto tale modello dipenda dalla nostra cultura dominante e la patologia dall’originalità con cui il soggetto cerca di adattarvisi senza riuscirvi, pur senza cedere alla mistica del folle come rivoluzionario o artista.
Insomma, i modi di stare al mondo sono tantissimi, forse tanti quanti gli uomini, e questa variabilità andrebbe perlomeno rispettata. Quanto ci perderebbe l’umanità (e non solo i nostri bilanci professionali) se scomparissero completamente gli ossessivi, i fobici sociali, gli istrionici o i brillanti narcisisti, per non parlare del danno irreparabile se i diversi temperamenti e caratteri di Cloninger fossero sostituiti da un unico modello base, buono per tutte le stagioni, le latitudini, le culture. Prima di porci il classico proposito ippocratico “Primum non nocere”, dobbiamo chiederci proprio se curare, analizzando attentamente la richiesta e la sua provenienza (la cosiddetta committenza). Un terapeuta deve dunque essere consapevole del contesto culturale in cui opera e che gli conferisce il mandato ed un potere enorme (si pensi al trattamento sanitario obbligatorio e dunque alla possibilità di privare della libertà). La cultura, pur influenzando ogni nostra espressione, lo fa senza che ce ne rendiamo conto. È potente proprio perché la diamo per scontata. Non è l’oggetto del discorso ma la sua premessa, la luce che illumina la scena non gli oggetti o l’azione che vi si svolge. Anche la psicoterapia ne è da un lato un prodotto diretto e recente -appena 150 anni dalle prime sedute, o meglio sdraiate, viennesi di Freud, nume protettore di tutti noi e di questa università in particolare- e dall’altro un onesto servo idiota con l’aggravante di ritenersi intelligente. Escludendo alcuni santoni che dichiaratamente vogliono insegnare come vivere ai propri pazienti trasformandoli in adepti, che sia secondo i dettami del pensiero positivo, del razionalismo, dello scientismo o dell’etica evangelica della chiesa avventizia del penultimo giorno/tardo pomeriggio, poco conta. Gli altri, diciamo gli psicoterapeuti seri, tentano di evitare questo pericolo con una serie di attenzioni che, tuttavia, non eliminano il rischio di proporre inconsapevolmente modelli normativi. Per evitarlo, sono principalmente due le strategie che si usano. La prima è il cosiddetto “atteggiamento non giudicante”. La seconda è partire sempre da “un’egodistonia” del paziente, fissando insieme a lui gli obiettivi.
Soffermiamoci allora sulle premesse culturali implicite che tali strategie presuppongono. L’atteggiamento “non giudicante” tanto sbandierato non afferma in fondo con forza, per usare un ossimoro, un relativismo assoluto per cui tutto va bene e tutto è ammissibile? Attenzione, non che questo sia necessariamente sbagliato, solo che bisogna essere consapevoli che anch’esso è una premessa ideologica, non meno assoluta di tante altre, e che non è l’unico modo di stare al mondo. L’egodistonia, a sua volta, e l’autodeterminazione degli obiettivi mettono al centro di tutto l’individuo, il suo benessere e il conseguente diritto a fare di tutto per ottenerlo. Atteggiamento che dal XV secolo con l’umanesimo ha messo l’uomo e non più Dio al centro dell’universo e che potremmo definire “egocentrismo edonico”. Il messaggio che passa più o meno esplicitamente è “Pensa a te, ai tuoi bisogni e desideri” (ricentramento su di sé) e “Fai di tutto per realizzare il tuo benessere” (assertività), con l’unica attenzione a non essere guidato solo dal principio del piacere immediato ma di tenere conto anche del principio di realtà, per perseguire un piacere che non sia solo a breve ma anche a medio e lungo termine”. Questo è un modello di uomo sano tipico della attuale cultura occidentale di matrice statunitense in cui ognuno deve darsi da fare al massimo per costruire il proprio personale benessere, la propria autorealizzazione, ma non è certo l’unico modo possibile di attraversare l’esistenza. Si pensi ai modelli orientali dove “l’Io” è stemperato nel “Noi” ed il fare in secondo piano rispetto all’essere.
Voglio chiudere queste sgangherate righe con un breve accenno al delirio di cui volevano essere premessa e cornice e che sarà il tema affidatomi all’inaugurazione senza però entrare nel merito della patogenesi, del mantenimento e della terapia il che ridurrebbe l’appeal dell’incontro ottobrino.
Secondo la classica prospettiva cognitivo/costruttivista il mondo in cui viviamo non è fatto di cose ma di opinioni sulle stesse, di significati che ci fanno stare bene o male a seconda dei nostri scopi. La nostra realtà è costituita da rappresentazioni mentali, pallido e soggettivamente deformato simulacro della “cosa in sé” kantiana. Dunque si può dire che ciascuno viva in un proprio mondo privato, in una sorta di delirio benigno. E non sono forse tali le cosiddette illusioni narcisistiche di Sullivan circa il nostro valore, importanza ed immortalità che fanno parte di quel narcisismo “sano” che abbiamo individualmente e come specie umana per controbilanciare la disperazione che scaturirebbe dall’essere gli unici viventi consapevoli della inevitabilità della loro fine e di quella di tutti i propri cari, cui è dedicato l’ultimo lavoro di Gianni Liotti cui ho avuto per caso la straordinaria fortuna di partecipare.
Affermata l’assoluta omogeneità del pensiero delirante con quello normale e che dunque non di una categoria nosografica si tratta ma semmai di una dimensione che va dal confermazionismo della vita quotidiana, all’autoinganno, per arrivare fino al capolinea del delirio paranoico passando per la rigidità (testardaggine) nevrotica, mi sembra che due siano le sottodimensioni di cui tener conto: la perduta consensualità con gli altri che riporta ad una dimensione relazionale la genesi, il mantenimento ma anche la cura dell’isolamento delirante. La fissità versus il cambiamento che è il modo di essere funzionale della conoscenza al punto da poter affermare che tutte le psicopatologie siano connotabili come modalità diverse di malfunzionamento del processo naturale di cambiamento e progresso della conoscenza: tutta la psicopatologia è, a mio avviso, “Patognoseologia”, ma questa è un’altra lunga e noiosissima storia.
Processi e relazioni in terapia cognitiva: scenari futuri
Abstract dell’intervento di Giovanni M. Ruggiero per l’inaugurazione dell’anno accademico 2019-2020 della Sigmund Freud University
L’evoluzione scientifica della psicoterapia è davanti a un bivio decisivo. Due sono i possibili esiti. Il primo è la lenta confluenza dei troppi modelli teorici di sofferenza emotiva e di funzionamento della psicoterapia nel paradigma post-teorico dei fattori comuni e della centralità della relazione terapeutica -scenario in cui chiamarsi cognitivisti, sistemici, psicanalisti o altro avrà solo un significato teneramente folcloristico e saremo tutti in fondo dei relazionalisti umanistico-esperienziali rogersiani- oppure avrà successo l’ultimo tentativo residuale di costruzione empiricamente verificabile di un paradigma specifico, distinto dagli altri modelli e con essi in competizione scientifica a viso aperto, quello del cognitivismo clinico, prima standard e poi processualista. Tentativo disperato o lungimirante? Lo scopriremo solo vivendo. La presentazione esplora gli aspetti scientifici ma anche sociali e culturali dei due scenari.