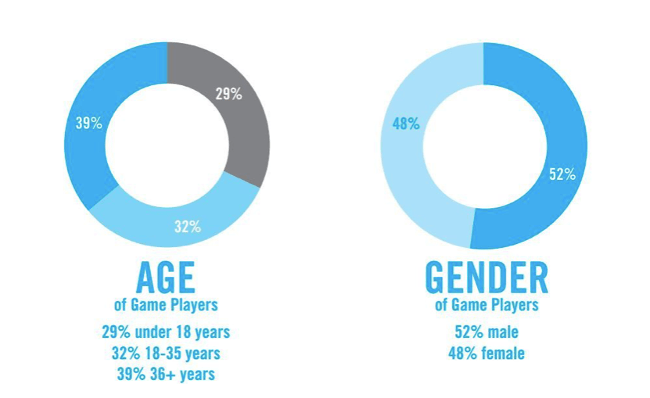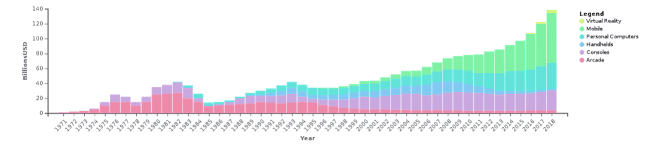Genderqueer: indicazioni cliniche per il colloquio oltre al binarismo di genere
Una persona, che non si sente né maschio né femmina o che si sente entrambi, può arrivare ad un colloquio psicologico per l’eventuale disagio connesso alla propria identità di genere o per altre motivazioni, ma purtroppo la maggior parte degli psicologi ignora le tematiche “transgender and gender nonconforming” (TGNC).
Greta Riboli – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi Milano
Perché si possa lavorare meglio con
clienti non-binary, Chang e colleghi (Chang, Singh & Rossman, 2017) suggeriscono ai professionisti della salute di sviluppare tre componenti: consapevolezza, conoscenze e competenze.
Lo scopo di questo articolo è dunque quello di aumentare le conoscenze dei clinici rispetto a tematiche legate al TGNC e in particolare al genere non binario (non-binary), al vocabolario ad esso connesso e ai rischi clinici a cui queste persone sono maggiormente esposte. Si intende, inoltre, lasciare spazio a indicazioni utili per la consulenza psicologica destinata a persone non-binary.
Identità sessuale: sesso, ruolo, genere
L’identità sessuale è la percezione che le persone hanno di sé come individui sessuati. È un costrutto multidimensionale composto da sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere, orientamento sessuale e orientamento affettivo.
Il sesso biologico include caratteristiche biologiche (determinate da ormoni, caratteristiche sessuali secondarie e cromosomi). I bambini possono nascere maschi, femmine o intersessuali.
Il ruolo di genere è l’esternalizzazione della propria identità di genere (modo di vestire e atteggiarsi), come costrutto socioculturale.
Solitamente l’identità di genere, definita come il senso interno e privato del genere esperito, viene dato per scontato sia coerente al sesso biologico (cisgender). Così i neonati, spesso, nascono in un ambiente che li tratta in modo socialmente aderente alla percezione del sesso biologico, parlando loro al maschile o femminile, dando loro un nome maschile o femminile, insegnando loro ad entrare nel bagno dei maschi piuttosto che delle femmine e talvolta vestendoli o insegnando loro come comportarsi in base alle norme sociali di genere che si sono strutturate nel tempo. Eppure, non è un dato scontato che l’identità di genere sia cisgender, essa potrebbe, ad esempio, essere anche transgender binary o non-binary.
L’orientamento sessuale, infine, è un’ulteriore componente dell’identità sessuale e si riferisce all’attrazione affettivo-sessuale di una persona nei confronti di un’altra. Gli orientamenti sessuali sono diversi e sono ad oggi considerati come normali varianti della sessualità, tra i più conosciuti troviamo l’orientamento eterosessuale, omosessuale e bisessuale.
Genderqueer: non-binary identity
A livello sociale ci sono diverse comunità che, nell’arco della storia, hanno abbracciato identità di genere non binarie: un esempio sono i gruppi indigeni degli attuali Stati Uniti d’America che riconoscono una “two-spirit identity” in coloro che sono sia maschili sia femminili (Robinson, 2017), oppure i Chuckchi in Siberia, i Bakla nelle Filippine, i Hijra in India e i Quariwarmi in Perù (Stryker, 2008).
L’APA considera le identità transgender e nonconforming (TGNC) come una normale parte della diversità umana, anziché come aspetti da patologizzare (APA, 2015; Singh & dickey, 2017), eppure, le identità non binarie sono considerate non valide o inesistenti (Chang et al., 2017). La maggior parte delle persone, infatti, è convinta del fatto che i generi siano due, maschile e femminile, e che siano collegati al sesso biologico. Questo è il binarismo di genere. In questi anni sorge invece la necessità di andare oltre al binarismo, includendo nuove categorie di genere.
Il significato di identità di genere non binaria non è stato ancora ben indagato. Emmie Matsuno, dell’Università della California – Santa Barbara (USA), sta effettuando diversi studi relativi al tema dell’identità di genere non binaria e attualmente in letteratura troviamo come il termine “non-binary identity” si riferisca a diversi gruppi di persone, tra cui: individui la cui identità di genere non è rispecchiata né da quella femminile né da quella maschile, individui che esperiscono un’identità talvolta maschile talvolta femminile e individui che non esperiscono l’appartenenza ad un genere o che si rifiutano di avere un’identità di genere precisa.
Solitamente l’espressione “gender fluid” viene usata per persone che possono sentirsi uomini o donne in diversi momenti: questo significa che in alcuni giorni la persona assumerà il ruolo di genere maschile o femminile in modo alternato, arrivando talvolta a definire se stesso con pronomi maschili o femminili a seconda del genere esperito. I termini che rientrano sotto all’ombrello “gender fluid” sono in realtà molteplici, tra i più comuni si ritrovano “agender”, “nogender” “neutrois”, “bigender”, “intergender”, fino ad arrivare al più classico “non-binary”.
A dimostrazione del fatto anche l’identità di genere, così come l’orientamento sessuale (Diamond, 2008), possono fluttuare e modificarsi nel tempo (talvolta a fronte di una maggiore consapevolezza), non è raro il fenomeno che vede persone, inizialmente identificatesi come uomini o donne transgender, identificarsi successivamente come non-binary (Galupo, Pulice-Farrow & Ramirez, 2017). La comprensione che le persone maturano del proprio genere è complessa, può variare nel tempo e può includere infinite possibilità oltre al maschile e femminile (APA, 2015).
Allo scopo di aumentare le conoscenze relative alle persone dal genere non binario, si ritiene opportuno presentare una serie di giudizi erronei che psicologi e psicoterapeuti potrebbero avere rispetto al genere:
- tutti sono cisgender, ovvero l’identità di genere di chiunque corrisponde al suo sesso biologico (es. un maschio è un uomo e si sente tale);
- esistono per natura solo due generi (maschile e femminile), determinati dall’anatomia;
- è possibile intuire qual è il genere di una persona in base all’apparenza con la quale si mostra agli altri;
- tutte le persone transessuali desiderano transitare binariamente da un genere all’altro;
- le persone con identità non binaria sono in realtà persone con orientamento omosessuale;
- essere non-binary fa parte di un fenomeno di moda o di un capriccio.
Tutti questi giudizi possono portare il clinico alla gestione di un trattamento psicologico inappropriato (Chang et al., 2017).
Rischi per la salute delle persone non binary
Gli studi scientifici condotti sulle persone con genere non binario non sono molti. Tuttavia, la letteratura sottolinea comunque l’esistenza di un forte rischio per questi soggetti di sviluppare un disagio psichico (sintomatologia ansiosa e depressiva). La letteratura mostra, inoltre, come questi rischi siano più alti dei rischi delle persone transgender binarie medicalizzate (coloro che transizionano ad esempio, dal genere femminile a quello maschile – FTM (o viceversa – MTF) (Budge, Rossman & Howard, 2014; James, Herman, Rankin, Keisling, Mottet & Anafi, 2016).
Lo studio con il campione più ampio ad oggi condotto ha mostrato come, su 27.715 adulti americani, il 49% delle persone con genere non binario ha riportato distress psicologico, rispetto al 35% delle persone transgender binarie e rispetto al 5% della popolazione cisgender (persone il cui genere è coerente rispetto al proprio sesso biologico). Gli individui non-binary, inoltre, riportano più alti tassi di discriminazione e di molestie rispetto a persone transgender binary (Harrison, Grant & Herman, 2012) e anche un rischio suicidario molto più elevato rispetto ai soggetti con genere binario e dieci volte più alto rispetto alla popolazione generale (Harrison et al., 2012).
L’alto rischio di sviluppare un disturbo mentale sarebbe dovuto a “minority stress”, quali lo stigma sociale, le esperienze di violenza, le molestie e il rifiuto (Harrison et al., 2012; Hendricks & Testa, 2012). Stressor esterni o distali influenzano lo sviluppo di pensieri negativi rispetto alla propria identità (transnegatività interiorizzata), aspettative di rifiuto da parte degli altri e occultamento agli occhi altrui della propria identità (Testa, Habarth, Peta, Balsam & Bockting, 2015).
Indicazioni cliniche per la presa in carico di persone non-binary
Dall’analisi della letteratura emerge un basso livello di conoscenze dei clinici rispetto alle tematiche legate all’
identità di genere non binaria e una scarsa presenza indicazioni cliniche per condurre un
colloquio psicologico con questo tipo di pazienti. Il rischio è che si generalizzi la categoria transgender a tutti i soggetti con
identità di genere non coerente al proprio sesso biologico, dando per scontato che, ad esempio, qualsiasi maschio che non si senta uomo sia transgender binario e tendente dunque al genere femminile (MTF).
Genderqueer: assunti di base
Nella pratica clinica, all’interno di un percorso affermativo, sarebbe buona norma essere al corrente di alcune caratteristiche dei soggetti genderqueer. I pazienti genderqueer non desiderano necessariamente intraprendere un percorso di transizione medicalizzato per modificare le proprie caratteristiche sessuali secondarie rendendole coerenti con la propria identità di genere. Nonostante ciò, alcuni di essi, desiderano intraprendere trattamenti medici (assunzione di ormoni o interventi chirurgici) per sentirsi più in armonia col proprio corpo (Alexander, Orovecz, Salkas, Stahl & Budge, 2016). Coloro i quali non desiderano intraprendere un percorso di natura medica, rispetto alla controparte binaria medicalizzata, corrono minor rischi connessi alla salute fisica.
Un altro aspetto importate riguarda le diverse forme di stigma che possono subire le persone genderqueer rispetto alle persone transgender binarie: infatti, non esiste un linguaggio specifico per riferirsi ad essi, i negozi di vestiti sono dedicati unicamente al genere maschile o femminile e così via. Essi spesso hanno la sensazione che la società non abbia ritagliato nemmeno un piccolo angolo dedicato al loro riconoscimento. Gli individui con genere non binario vivono una forte discriminazione, come anche i soggetti con orientamento bisessuale, da parte non solo della comunità cisgender, ma dalla comunità transessuale stessa, la quale non li ritiene “abbastanza transessuali” (Ross, Dobinson & Eady, 2010). Solitamente si pensa che le persone non binarie siano confuse rispetto alla propria identità di genere o che stiano attraversando una fase destinata a concludersi con una scelta in favore del genere maschile o femminile (Singh & Burnes, 2009).
Alcune indicazioni per i clinici, per evitare che siano sempre gli eventuali pazienti genderqueer a doverci istruire, sono le seguenti: il clinico potrebbe accorgersi di trovarsi innanzi ad una persona non binaria, quando questa tronca le parole (es. bello o bella divengono bell*), oppure quando si sforza di produrre frasi in cui al posto del pronome si inserisce sempre un nome, oppure varia i pronomi ed usa desinenze diverse a seconda del proprio genere percepito. Allo stesso tempo, sarebbe opportuno non dare per scontata l’identità di genere di qualcuno in base all’uso di pronomi, nomi e desinenze: la persona potrebbe declinarli in base al sesso biologico per comodità o, più spesso, per non trovarsi in situazioni di “coming out” e di conseguenza dover dare spiegazioni.
È importante incoraggiare i propri clienti ad auto-definire il proprio genere, accompagnandoli verso una maggiore comprensione della propria autentica identità, ed evitare di dar per scontata l’identità di genere. A questo proposito, qualora ci fosse della testistica da compilare, si potrebbe aggiungere alla casella del “genere” (anziché del “sesso”) la possibilità di trovare spazio per definire se stessi. Questo può essere percepito dal cliente come una conoscenza del clinico relativa a queste tematiche, aumentando l’alleanza e diminuendo l’eventuale difficoltà sperimentata dal paziente nel fare coming-out nel corso delle sedute.
Per ampliare le proprie conoscenze, si consiglia la lettura del seguente manuale: The Gender Quest Workbook: A Guide for Teens and Young Adults Exploring Gender Identity (Testa, Coolhart & Peta, 2018).
Genderqueer: la presa in carico
Riprendendo le indicazioni di Chang e colleghi, in seguito ad una maggiore conoscenza del fenomeno, si dedicherà quest’ultima parte alle terapie affermative e, più in generale, alla presa in carico di clienti non-binary (Chang et al., 2017).
Come già accennato, in primo luogo si deve evitare che siano i pazienti stessi a dover istruire il proprio clinico rispetto alle tematiche di genere. Esistono molteplici siti che affrontano queste tematiche ed è importante che gli psicologici si aggiornino rispetto alla terminologia e ai nuovi concetti nascenti, per poter interagire al meglio soprattutto con clienti adolescenti. Non facendosi cogliere impreparato, il clinico può chiedere all’inizio del colloquio il nome, i pronomi e le desinenze che la persona preferisce usare per parlare di sé, servendosene poi nei colloqui e nelle eventuali note scritte-homework da condividere con il paziente (Singh & dickey, 2017). Può essere d’aiuto, inoltre, usare un linguaggio neutro, privo di “signora/signore”, “lei/lui”. Un esempio è quello fornito da Matsuno (2017): “c’è una persona con una camicia rossa che l’aspetta in sala d’attesa” anziché “c’è una donna che l’aspetta in sala d’attesa”.
Durante i primi colloqui è compito del clinico concettualizzare il caso, cogliendo quanto lo stigma sociale e il binarismo impattino sulla salute del cliente, quanto gli stressor minoritari abbiano contribuito allo svilupparsi dell’eventuale sintomatologia presentata (es. sintomi ansiosi) ed indagando l’eventuale disforia legata alla propria anatomia. Inoltre è importante non dare per scontato che i sintomi siano necessariamente connessi al genere esperito dalla persona, solo perché nella percezione del clinico presentarsi con un genere non binario sia inusuale. Fondamentale è supportare il paziente nell’elaborazione dello stigma internalizzato: essendo nato e cresciuto in un ambiente prettamente binario, molto probabilmente avrà la sensazione di essere lui stesso “sbagliato”. I clinici possono aiutare i propri clienti in questo processo attraverso la psicoeducazione, validando gli effetti negativi che tale stigma può avere sulla persona. Attraverso l’uso di tecniche della terapia cognitivo-comportamentale (CBT), si può aiutare il paziente a lavorare sui propri pensieri disfunzionali connessi alla transessualità (es. “non piacerò a nessuno perché sono non-binary”, “nessuno mi amerà mai perché sono non-binary”) (Austin & Craig, 2015). Infine, il clinico può condividere materiale che promuove messaggi positivi relativi alle non-binary identities: serie tv, film, libri, blog, etc.
Essere continuamente scambiati per membri appartenenti ad un genere in cui non ci si riconosce è un forte stress, anche a causa della paura di rifiuti, molestie o violenze. Il paziente dovrà quindi essere accompagnato e sostenuto dal clinico verso la scelta di un consapevole coming-out o meno: è bene discutere con il proprio cliente rispetto ai vantaggi e ai rischi di una disclosure piuttosto che di una nondisclosure, in diversi contesti (famiglia, colleghi, compagni, partner). Non essendoci una scelta giusta o sbagliata, è importante che il paziente decida ciò che ritiene sia meglio per sé. Detto ciò, lo psicologo può aiutare il cliente ad individuare le possibili strategie di coping, qualora vi fossero effettive risposte negative.
Il clinico può dedicarsi a interventi sociali (nelle scuole, ad esempio) per la diffusione di informazioni relative all’identità di genere, con lo scopo di prevenire discriminazioni e atti di bullismo a matrice transfobica.
Infine, psicologi e psicoterapeuti non devono dimenticare i genitori di questi clienti, i quali spesso necessitano di una psicoeducazione o di un effettivo supporto psicologico. Un intervento familiare può aumentare le possibilità di accettazione e di benessere della persona transessuale (binaria o non) (Coolhart & Shipman, 2017) e diminuire le probabilità che venga agito un atto suicidario. Quest’ultimo aspetto viene sottolineato da uno studio del 2012, in cui i tassi di tentato suicidio della popolazione presa i esame erano il 57% per i giovani transgender rifiutati in famiglia e solo il 4% per i giovani transgender accettati in famiglia (Travers, Bauer, Pyne & Bradley, 2012).