Dal gemello “sacrificato” alla rinascita della individualità – PARTE I
Alessandra Cocchi.
Dal gemello “sacrificato” alla rinascita della individualità
Un intervento di Danza Movimento Terapia
PARTE I
 L. non aveva potuto sperimentare la pienezza e completezza impersonata da Apollo e Artemide: il suo farsi carico, rivestendo il ruolo del gemello “sacrificato”, delle sofferenze narcisistiche della mamma non gli aveva permesso di interiorizzare la parte maschile, solare, attiva, guerriera, né di integrarla con le sue parti più delicate, sensibili ombrose.
L. non aveva potuto sperimentare la pienezza e completezza impersonata da Apollo e Artemide: il suo farsi carico, rivestendo il ruolo del gemello “sacrificato”, delle sofferenze narcisistiche della mamma non gli aveva permesso di interiorizzare la parte maschile, solare, attiva, guerriera, né di integrarla con le sue parti più delicate, sensibili ombrose.
In questo scritto analizzerò la specificità della DMT – Danza Movimento Terapia- nel processo di crescita e consapevolezza di un bambino che viveva in famiglia il ruolo di gemello “sacrificato”.
Il ruolo di gemello “debole”, “in ombra”, “sacrificato” all’interno della famiglia con figli gemelli, è da sempre presente in molte culture, ed è stato analizzato dal punto di vista sociologico, antropologico, psicologico: esso ha alluso ad uno stato di possibile, probabile conflitto (Girard, 1972), dovuto alla presenza contemporanea di due esseri molto somiglianti, che hanno bisogni e desideri simili e spesso contemporanei.
La competitività per lo spazio esistenziale è un fattore presente nelle coppie gemellari già dalla vita uterina. Tale concorrenza perdura dopo la nascita, poiché è difficile che i gemelli trovino possibilità per soddisfare bisogni a volte sono identici e che spesso insorgono nello stesso momento; la competizione fra gemelli, così, può essere favorita dai genitori.
Le originarie asimmetrie fisiche e comportamentali sfociano nell’assunzione di ruoli complementari: un individuo tende ad essere più attivo, l’altro più passivo, uno dominante, l’altro dominato. Ed è così che, da una differenza reale, i genitori possono indurre una “specializzazione” della personalità dei gemelli e una cristallizzazione dei ruoli (Valente Torre 2001).
Più si sviluppano ruoli complementari, più la separazione/individuazione sarà difficile, perché questa comporta la perdita di una parte esistenzialmente indispensabile. Allora le potenzialità psichiche si sviluppano nei due in modo complementare, ma riduttivo: per non perdere il senso di appartenenza alla coppia gemellare, che si è basato e costruito su ruoli complementari, vi è un blocco della spinta evolutiva, una limitazione della volontà esplorativa delle specifiche possibilità esistenziali di ciascun gemello.
I gemelli sono quindi nella condizione unica di dover dividere la figura di attaccamento con un altro, però, hanno nel co-gemello un altro da sé su cui fare affidamento, e quindi la loro separazione/individuazione viene rallentata dal cosiddetto effetto coppia (Zazzo 1987).
Secondo Sandbank l’effetto coppia favorirebbe nei gemelli lo svilupparsi di competenze specifiche, ma complementari, che rafforzano e mantengono il bisogno di unione e dipendenza, poiché ognuno ha bisogno dell’altro per completarsi (Sandbank 1988).
Lo psicologo francese René Zazzo (Zazzo 1987) sottolinea poi come nel periodo perinatale si definisca il triangolo relazionale tra la madre ed i gemelli, che fortifica il legame tra i figli a scapito di quello tra mamma e bambini. I gemelli sperimentano da subito come il rapporto con la madre sia meno intenso di quello fra di loro: essi vivono momenti di frustrazione, poiché la madre deve dividere le sue attenzioni e le sue cure, ed entrano allora in competizione per ottenere un rapporto privilegiato con la madre (Agnev, Klein, Ganon 2006).
La madre, se fatica a fare fronte alla difficoltà della situazione triadica, può tentare di ricostruire la diade madre-bambino comportandosi con i gemelli come se fossero un’unità (Barbieri, Fischetti 1997), oppure può incoraggiare il passaggio da una situazione di triade ad una a quattro, in cui viene stabilito un rapporto privilegiato tra la madre ed uno dei gemelli e il padre e l’altro gemello (Sandbank 1988).
E’ proprio ciò che era accaduto nella famiglia di L., gemello “sacrificato” da me seguito per due anni e mezzo (dall’età di 10 anni ai 12) presso la NPIA di un comune emiliano.
Il bambino aveva una diagnosi di inibizione intellettiva causata da depressione. Tuttavia presentava anche fortissime tematiche narcisistiche, che si esprimevano in fantasie di leadership e di grandezza, dal momento che L. cercava di corrispondere alle aspettative della madre.
Invece L., fin da piccolissimo, era risultato ben diverso dalle fantasie che la madre si era fatta durante la gravidanza, rivelandosi, sin dai primi mesi, più lento, passivo e debole fisicamente rispetto alla gemella. L. aveva deluso le aspettative della madre: ella non si sentiva in grado di accudire un bambino che riteneva poco reattivo alle sue sollecitazioni e viveva come un fallimento il temperamento timido e a suo avviso poco vitale del figlio.
Così, i genitori si erano “spartiti” le cure dei bambini: alla madre la gemellina solare e vitale, corrispondente alla sua idea di “figlia buona”, al padre il timido, passivo, silenzioso L.. Il bambino aveva, quindi, sperimentato un rifiuto da parte della madre, una netta divisione della coppia gemellare e un posto più in ombra nelle relazioni familiari, rispetto alla gemella. L’originaria difficoltà della coppia “madre-bambino” ad adattarsi alle caratteristiche portate reciprocamente nella relazione, aveva nel tempo causato un irrigidimento del ruolo di “gemello in ombra” che L. aveva in famiglia: la coppia gemellare era stata divisa precocemente in due, i ruoli nella coppia gemellare si erano polarizzati e cristallizzati.
L. aveva subito un rifiuto dalla mamma e una separazione precoce dalla gemella; a causa di ciò, si era poi trovato in un ruolo che negli anni gli è stato riconfermato in famiglia, a scuola, nel gruppo dei pari. Ora, vicino all’età puberale, avvertiva l’incompletezza, la divisione, la mancanza della sua altra parte: avrebbe voluto stare alla pari con la gemella, ma non aveva strumenti per farlo, cercava disperatamente un aggancio col suo lato vitale e assertivo.
Pensando a L. e la sua famiglia, mi è tornato alla mente il mito greco di Apollo e Artemide, dèi gemelli che incarnano il concetto della necessaria e auspicabile coesistenza di qualità diverse o opposte. Apollo e Artemide riassumono, ciascuno nella propria figura, ruoli e compiti tradizionalmente sia maschili che femminili, sia attivi che contemplativi. Apollo e Artemide rappresentano, sia come coppia, che come singoli, la ricomposizione dell’intero, ma anche il lato scisso, in ombra, che viene alla luce e dà completezza all’essere umano: l’androgino, l’attivo, il guerriero nella donna, il femmineo, il meditativo, lo spirituale nell’uomo.
L., invece, non aveva potuto sperimentare la pienezza e completezza impersonata da Apollo e Artemide: il suo farsi carico, rivestendo il ruolo del gemello “sacrificato”, delle sofferenze narcisistiche della mamma non gli aveva permesso di interiorizzare la parte maschile, solare, attiva, guerriera, né di integrarla con le sue parti più delicate, sensibili ombrose.
I genitori, rinforzando il sistema relazionale della coppia, avevano ostacolato un adeguato processo di separazione, necessario affinché ciascun gemello potesse organizzare una propria identità ed una propria autonomia, slegata dal ruolo gemellare. Il bambino provava a dedicarsi alle arti marziali, alla batteria, nel tentativo di rendere noto e di integrare in sé il suo lato forte, vitale, assertivo, e di mettersi alla pari, nella considerazione genitoriale, con la solare e energica gemellina, ritrovando al contempo, il legame perduto con lei. Ma L. era incapace di trovare in sé le risorse, non riusciva a trovare la giusta via per riemergere, riaffiorare dall’ombra né in famiglia, né a scuole, né nel gruppo dei pari.
In tali condizioni è arrivato a me: chiuso nel suo mondo, fantasticando di impersonare ruoli forti e attivi. Nel corpo manifestava una grande rigidità e una scarsa coordinazione: ciò non gli permetteva di muoversi, di pensare, di relazionarsi in modo efficace, espressivo, comunicativo, intenzionale, causandogli grande frustrazione.
Il bambino era infatti ritirato in un mondo di fantasie grandiose e irrealistiche, che lo proteggeva dalle continue frustrazioni, impedendogli di ancorarsi alla sua realtà: in questo mondo fantastico immaginava di ricoprire ruoli di leader, cosa impossibile per lui nella realtà, compiendo imprese pericolose e spettacolari, a capo della banda di amici.
Per inquadrare il caso di L., prenderò spunti dalla teoria dello sviluppo di Stern, Winnicott, e dalla psicopatologia del Sé secondo Kohut. Questi autori si soffermano sulla sofferenza psichica dovuta alla inadeguata costituzione di strutture mentali, di un non corretto sviluppo della coesione del Sé, a causa di trauma cumulativo dovuto all’insufficienza prolungata delle figure di accudimento.
Secondo questi autori, l’origine della psicopatologia risiede nella rigidità di adattamento reciproco della diade madre-bambino alla relazione, o in una sintonizzazione selettiva della madre (Stern 1975), che accetta e rinforza solo alcune esperienze del bambino, oppure nella mancata o imperfetta empatia genitoriale (Kohut 1971) verso l’originaria unità psicosomatica del bambino.
In tali evenienze le azioni del bambino non vengono colte e valorizzate: il piccolo deve sottomettersi alle sollecitazioni e alle aspettative altrui, a scapito della presa di contatto coi propri bisogni e gesti spontanei (Stern 1985).
Avviene dunque una atrofizzazione del vero Sé, che coincide col gesto spontaneo, col sentimento di essere reali e creativi, e lo sviluppo del Falso Sé, difesa compiacente di fronte a un ambiente che non si adatta in maniera appropriata ai suoi bisogni (Winnicott 1960), non permettendogli di interagire genuinamente con la realtà.
Winnicott e Kohut teorizzano analogamente che il procedere dello sviluppo è legato alla capacità della madre di disilludere il bambino gradualmente circa la sua originaria dimensione narcisistica di onnipotenza. Il bambino che soffre un trauma narcisistico (rifiuto, abbandono, prolungata disconferma o carenza della funzione empatica genitoriale), è costretto a subire esperienze eccessivamente frustranti; dunque egli non può sviluppare una struttura del Sé consolidata e rimane ancorato alla primitiva esperienza dell’onnipotente Sé grandioso (Kohut 1971).
Così il bambino si trincera in un sentimento di sé grandioso e onnipotente, essendo dipendente da un riconoscimento della propria immagine grandiosa e corre il rischio di frammentazione quando ciò non accada. Di conseguenza si creerà una scissione verticale del Sé (Kohut 1971), in cui coesistono grandiosità esibita e totale insicurezza e vulnerabilità all’interno dell’individuo.
Il duro lavoro che L. ed io abbiamo svolto per due anni e mezzo si è svolto attraverso i principi e gli strumenti della Danza Movimento Terapia. La DMT si è rivelata un intervento utile e specifico, un paio di occhiali diversi per guardare L., nell’esplorare le fasi precoci dello sviluppo del Sé e della sua relazione primaria.
Utilizzando l’attenzione corporea, strumento basilare del setting di DMT, si accede a sentimenti e vissuti appartenenti al periodo pre-verbale dello sviluppo, ai quali non è mai stato permesso di esprimersi.
Nel prossimo articolo prenderemo in considerazionegli strumenti metodologici della DMT.
LEGGI ANCHE:
ARTICOLO CONSIGLIATO:
BIBLIOGRAFIA:
- Agnew ,C.L., Klein, A., Ganon, J.A. (2006), Twins! Pregnancy, birth and the first year of life, Harper Collins Publishers, New York .
- Bacal, H. A., Newmann, K. M. (1990), Teorie delle relazioni oggettuali e psicologia del Sé, Bollati Boringhieri, Torino 1993.
- Barbieri, F., Fischetti, C. (1997), Crescere gemelli. Individuazione psichica e relazione con l’ambiente delle coppie gemellari. Phoenix Editrice, Roma 1997.
- Bartenieff, I. (1983), Body Movement: Coping with the Environment, Gordon & Breach, New York, 1983.
- Bick, E. (1968), The Experience if the skin in early object-relations, in Meg Harris Williams, in Collected papers of Martha Harris and Ester Bick, The Clunie Press, Perthshire, Scotland 1978
- Bion, W. (1963), Gli elementi della psicoanalisi, Armando, Roma 1979.
- Bloom, K. (2006), Il Sé nel corpo, Astrolabio, Roma 2007.
- Bollas, C. (1987), L’ombra dell’oggetto, Borla, Roma, 1989.
- Brazelton, T., Cramer, B. (1990), Il primo legame, Frassinelli, Milano 1991.
- Chodorow, J. (1991), Danza Terapia e psicologia del profondo, Red Milano 2005.
- Dosamantes- Beaudry, I. (2007), Somatic Transference and Countertransference in Psychoanalytic Intersubjective Dance/Movement Therapy, in: American Journal of Dance Therapy, 29(2), American Dance Therapy Association 2007.
- Favaretti Camposampiero F., Di Benedetto P., Cauzer M. (1998), L’esperienza del corpo. Fenomeni corporei in psicoterapia psicoanalitica, Dunod Masson, Milano 1998.
- Girard, R. (1972), La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 1980.
- Govoni, R. M. (1998), Danza: Linguaggio poetico del corpo e strumento di cura, in: Belfiore, M., Colli L. M. (a cura di) (1998), Dall’esprimere al comunicare. Immagine, gesto e linguaggio nell’Arte e nella Danzamovimento Terapia, Pitagora, Roma 1998.
- —————— (1998a), Emozione, espressione, cura. Movimento e danza: modalità espressive nel processo psicoterapeutico, in: Ricci-Bitti, P. E. (a cura di) (1998), Regolazione delle emozioni e artiterapie, Carocci, Roma 1998.
- —————— (2012), Corpi in movimento, luoghi generativi di trasformazione, in: Atti del Convegno APID 2010 ,Il corpo contemporaneo, Ed. Psychomedia, 2012
- Hackney, P. (1998), Making connections, total body integration through Bartenieff Fundamentals, NY, Routledge 2002.
- La Barre F., (2001) Muoversi in analisi, Astrolabio, Roma 2008.
- Kestenberg, J. (1975), Children and Parents: Psychoanalytic Studies in Development, New York: Jason Aronson, Inc., 1975.
- Kestenberg, J., Sossin, K. M. (1979), The role of Movement patterns in development, Dance Notation Bureau Press, New York.
- Kohut, H. (1971), Narcisismo e analisi del Sé, Bollati Boringhieri, Torino 1976.
- ———— (1977), La guarigione del Sé, Bollati Boringhieri, Torino 1980.
- Pallaro, P. (a cura di) (1999), Movimento Autentico. Scritti di Mary Starks Whitehouse, Janet Adler e Joan Chodorow, Cosmopolis, Torino 2003.
- Pieraccini P. (2012), Il Corpo in movimento come luogo generativo di trasformazione. Un approccio della DMT al paziente borderline, in Atti del Convegno APID 2010 “Il corpo contemporaneo”, Ed. Psychomedia, 2012.
- Sandbank A. (1988), Manuale ad uso dei genitori di gemelli, Raffaello Cortina 1999.
- Spitz R. (1965), Il primo anno di vita del bambino, Giunti, 2009.
- Stella G, Zavattini G. C. (1999), Manuale di Psicologia dinamica, Il Mulino, Bologna.
- Stern, D.N. (1985), Il mondo interpersonale del bambino, Bollati Boringhieri, Torino 1987.
- ————— (1989), I disturbi delle relazioni nella prima infanzia, Bollati Boringhieri, Torino 1991.
- ————— (1995), La costellazione materna. Il trattamento psicoterapeutico della coppia madre-bambino, Bollati Boringhieri, Torino 1995.
- Valente Torre L. (1999), La singolarità del doppio. Studi sui gemelli. La Nuova Italia Editrice, Firenze.
- ——————— (2001), La conflittualità nei gemelli, in Atti del Convegno: I gemelli, la persona, la famiglia e la scuola. 2 Febbraio 2001, Edizioni Città di Torino.
- Winnicott, D. (1945), Lo sviluppo emozionale primario, in: (1965), Dalla pediatria alla psicoanalisi, cit.
- —————— (1950), L’aggressività e il suo rapporto con lo sviluppo emozionale, in: (1978), Dalla pediatria alla psicoanalisi, cit.
- —————— (1953), L’intelletto e il suo rapporto con lo psiche-soma, in: (1965), Dalla pediatria alla psicoanalisi, cit.
- —————— (1954), Gli aspetti metapsicologici e clinici della regressione nell’ambito della situazione analitica, in: (1965), Dalla pediatria alla psicoanalisi, cit.
- —————— (1955), Le forme cliniche del transfert, in: (1965), Dalla pediatria alla psicoanalisi, cit.
- —————— (1958), Dalla pediatria alla psicoanalisi, Martinelli, Firenze 1975.
- —————— (1960), La teoria del rapporto infante-genitore, in: (1970), Sviluppo affettivo e ambiente, cit.
- —————— (1962), L’integrazione dell’Io nello sviluppo del bambino, in: (1970), Sviluppo affettivo e ambiente, cit.
- —————— (1965), Sviluppo affettivo e ambiente, Armando, Roma 1970.
- —————— (1971), Gioco e realtà, Armando, Roma 1974.
- Zazzo R. (1984), Il paradosso dei gemelli. La Nuova Italia, Firenze 1987.
 Il primo congresso nazionale sulla Metacognizione, dedicato al confronto tra i diversi modelli teorici che trattano l’argomento, si è concluso con la lettura magistrale di Adrian Wells, noto autore della Terapia Metacognitiva (MCT).
Il primo congresso nazionale sulla Metacognizione, dedicato al confronto tra i diversi modelli teorici che trattano l’argomento, si è concluso con la lettura magistrale di Adrian Wells, noto autore della Terapia Metacognitiva (MCT).





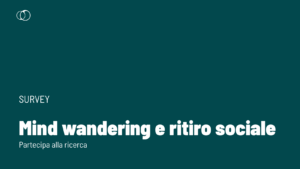











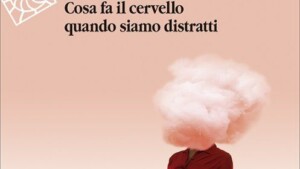






 Spesso i soggetti che hanno difficoltà ad esprimersi in maniera chiara e definita accumulano rabbia e oscillano tra passività e aggressività.
Spesso i soggetti che hanno difficoltà ad esprimersi in maniera chiara e definita accumulano rabbia e oscillano tra passività e aggressività.  L. non aveva potuto sperimentare la pienezza e completezza impersonata da Apollo e Artemide: il suo farsi carico, rivestendo il ruolo del gemello “sacrificato”, delle sofferenze narcisistiche della mamma non gli aveva permesso di interiorizzare la parte maschile, solare, attiva, guerriera, né di integrarla con le sue parti più delicate, sensibili ombrose.
L. non aveva potuto sperimentare la pienezza e completezza impersonata da Apollo e Artemide: il suo farsi carico, rivestendo il ruolo del gemello “sacrificato”, delle sofferenze narcisistiche della mamma non gli aveva permesso di interiorizzare la parte maschile, solare, attiva, guerriera, né di integrarla con le sue parti più delicate, sensibili ombrose.


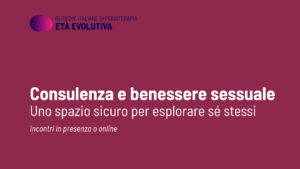
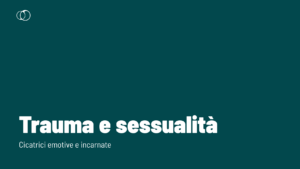

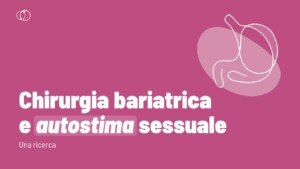





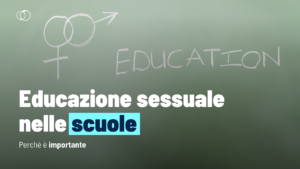

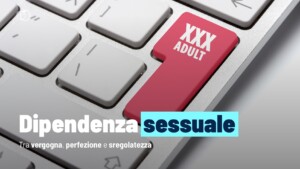
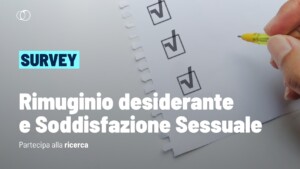
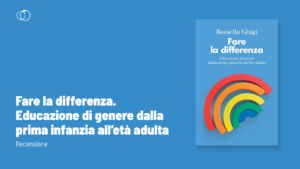




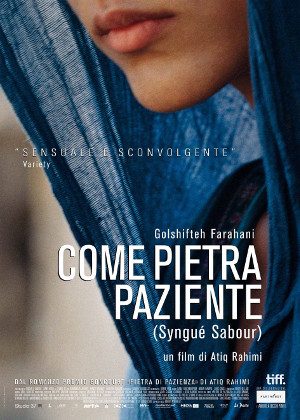 “Come pietra paziente”, film afghano del 2013, è una sorprendente opera dal carattere intimista che tratta con delicatezza e poesia le sofferenze di una donna prigioniera del rapporto col marito e della condizione femminile in cui è cresciuta.
“Come pietra paziente”, film afghano del 2013, è una sorprendente opera dal carattere intimista che tratta con delicatezza e poesia le sofferenze di una donna prigioniera del rapporto col marito e della condizione femminile in cui è cresciuta.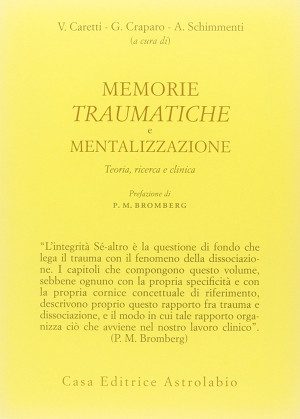 Un attaccamento traumatico, infatti, produce un indebolimento, un difetto di maturazione di aree dell’emisfero destro coinvolte nella regolazione affettiva. La dissociazione patologica riflette dunque una disintegrazione cronica del cervello destro, che perde le sua capacità di individuare e modulare emozioni insostenibili.
Un attaccamento traumatico, infatti, produce un indebolimento, un difetto di maturazione di aree dell’emisfero destro coinvolte nella regolazione affettiva. La dissociazione patologica riflette dunque una disintegrazione cronica del cervello destro, che perde le sua capacità di individuare e modulare emozioni insostenibili.

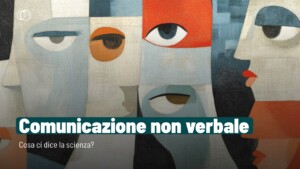
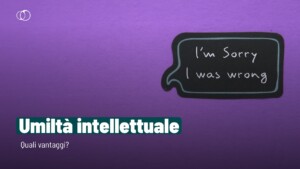

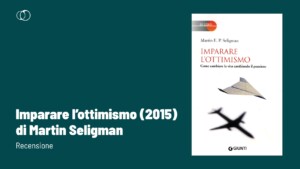














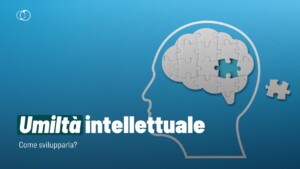
 L’Istrione non sa bene chi è, anzi non lo sa affatto e i confini sono labili, e quindi è condizionabile. Per questo gli è facile identificarsi e proiettarsi con il personaggio ideale voluto dal genitore. Un personaggio che deve primeggiare, essere ammirato, essere al centro.
L’Istrione non sa bene chi è, anzi non lo sa affatto e i confini sono labili, e quindi è condizionabile. Per questo gli è facile identificarsi e proiettarsi con il personaggio ideale voluto dal genitore. Un personaggio che deve primeggiare, essere ammirato, essere al centro. 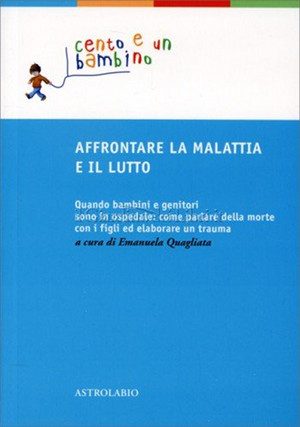 Il libro “Affrontare il lutto e la malattia” cerca di dare una risposta alle domande che spesso, in un momento così delicato, restano sospese: “come si può evitare che il dolore di un genitore resti muto? Come permettere ai bambini di parlare di ciò che temono, della loro malattia, se ne sono affetti, o di quella di un genitore? Come possiamo parlare della morte ai bambini che sono la speranza del futuro?”
Il libro “Affrontare il lutto e la malattia” cerca di dare una risposta alle domande che spesso, in un momento così delicato, restano sospese: “come si può evitare che il dolore di un genitore resti muto? Come permettere ai bambini di parlare di ciò che temono, della loro malattia, se ne sono affetti, o di quella di un genitore? Come possiamo parlare della morte ai bambini che sono la speranza del futuro?”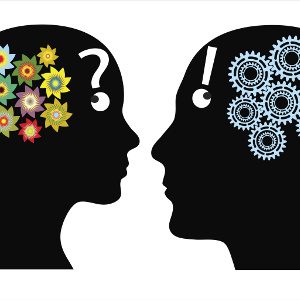 C’è poca chiarezza riguardo a quali siano le eventuali differenze cognitive o comportamentali attribuibili alla diversa morfologia del cervello maschile e di quello femminile.
C’è poca chiarezza riguardo a quali siano le eventuali differenze cognitive o comportamentali attribuibili alla diversa morfologia del cervello maschile e di quello femminile. La depressione è un disturbo della salute mentale caratterizzato da: ricorrenti stati di tristezza e insoddisfazione, bassa autostima e diminuito interesse nelle attività quotidiane, anche piacevoli.
La depressione è un disturbo della salute mentale caratterizzato da: ricorrenti stati di tristezza e insoddisfazione, bassa autostima e diminuito interesse nelle attività quotidiane, anche piacevoli.