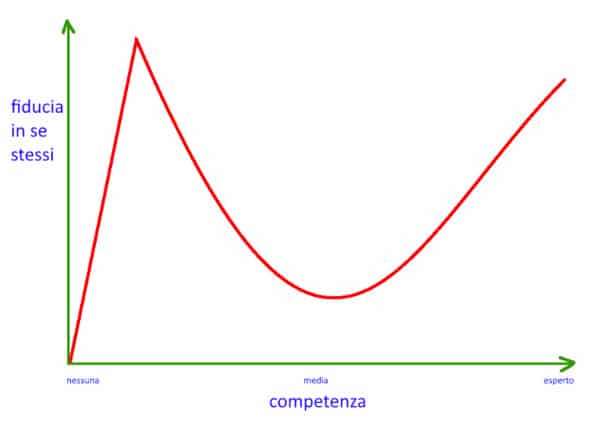I metodi alternativi alla sperimentazione animale. Lo stato dell’arte, tra tecnologia ed etica
Ormai da decenni buona parte delle discipline biomediche, unitamente ad importanti movimenti d’opinione che si battono per una maggior coscienza etica nella ricerca scientifica in biologia ed in medicina, auspicano l’affermarsi di metodi alternativi alla sperimentazione su animali. Tali metodologie esistono già e, ad oggi, hanno ormai raggiunto un certo sviluppo.
Quelle di cui diremo sono interamente in vitro ed in silico, cioè effettuate nel primo caso per mezzo di culture cellulari che poi, non di rado, vengono sottoposte a visualizzazione con tecniche di microscopia; nel secondo riguarderanno programmi informatici capaci di simulare, sulla base di calcoli probabilistici, reazioni di tessuti, organi, apparati e complessi biologici. Principalmente due sono le motivazioni allo sviluppo dei
metodi alternativi: evitare all’animale una sofferenza spesso pesante e sviluppare modelli più attendibili di quelli ottenibili con la cavia da laboratorio. Infatti, un vecchio adagio, che corre da sempre tra i ricercatori, recita così: “l’essere umano non è un topo grande”, ciò vale a dire che per quanto il modello animale possa essere interessante ai fini dello studio della biologia non potrà mai rappresentare con precisione la complessità fisiologica dell’uomo.
In termini organizzativi ed economici
Prima di proseguire però è opportuno accennare anche, almeno per sommi capi, all’impalcatura istituzionale pubblica e privata che rende possibile in Europa il graduale affermarsi dei metodi alternativi.
Tutti i metodi citati in questa dissertazione sono stati presi in considerazione da ECVAM (European Centre for Validation of Alternative Methods) e –seppur a volte non ancora approvati– sono in fase avanzata di valutazione.
Un altro organismo che dobbiamo considerare, in quanto agisce in stretta relazione con ECVAM, è l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che si sta occupando in particolare del riconoscimento delle procedure implicate nella prassi regolatoria del REACH, il protocollo comunitario che impone ai produttori e agli utilizzatori di sostanze chimiche la rivalutazione dei rischi salutistici collegati alle sostanze stesse.
I vari gruppi che “producono” metodi alternativi sono ormai realtà solide e ben strutturate: alcuni sono accreditati a livello internazionale e rappresentano un’autorità indiscussa in tutti i continenti. Citiamo, solo come esempio, l’inglese NC3RS (l’unico finanziato dal governo britannico), “punto di riferimento europeo –come afferma Isabella De Angelis, dell’Istituto Superiore di Sanità– sia per il rigore scientifico che per i finanziamenti” (Notiziario Chimico-Farmaceutico, 2016).
A livello mondiale dal 2012, secondo un Report BBC del 2014, si stanno realizzando investimenti nel settore delle cosiddette NAT (Non-Animal Technologies), miliardi di dollari, con un tasso d’incremento annuo superiore al 14% già solo per i metodi di tossicologia in vitro. Insomma, le industrie del settore farmaceutico –e più estesamente del comparto salute– stanno puntando sui metodi alternativi alla sperimentazione animale perché più convenienti, più agevoli, più economici ed in grado di salvaguardare l’immagine etica dell’azienda, immagine etica che entra come fattore di importanza non trascurabile nei piani di marketing.
In Europa esistono, a quanto mi consta, 38 laboratori, di cui 8 italiani, accreditati ed autorizzati allo sviluppo di metodi alternativi; tutti operano in stretta collaborazione con ECVAM. Questo istituto possiede un suo laboratorio in Italia, punto di riferimento tecnico per tutta la Comunità Europea, con sede ad Ispra, sul Lago Maggiore, in provincia di Varese.
La legislazione italiana ha recepito l’importanza della transazione dai modelli animali ai metodi senza animali soprattutto con il D.L. n. 26 del 4 marzo 2014, là dove all’art. 37, chiama il Ministero della Salute a farsi promotore della ricerca e dello sviluppo dei metodi che non prevedono l’uso di animali, o che consentono una riduzione del numero dei soggetti sperimentali ed il superamento delle procedure stressanti e dolorose. Per questo è stato realizzato il “Centro di Referenza Nazionale per i Metodi Alternativi, Benessere e Cura degli Animali da Laboratorio”, con residenza presso il noto “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna” (IZSLER), che funge anche da interfaccia tra il mondo della ricerca, l’industria ed ECVAM (www.ibvr.org).
A che punto siamo
Oggi i metodi verificati ed accettati da ECVAM superano la sessantina; ad essi si aggiungono altre decine di procedure validate in altri continenti da organismi equivalenti all’istituto europeo (ICCVAM – USA, JaCVAM – Giappone, BRACVAM – Brasile).
La quasi totalità dei metodi riguarda la reattività tissutale e la tossicologia regolatoria: essi hanno consentito il definitivo superamento sia del Test di irritabilità cutanea di Draize (noto per la storica immagine dell’ulcerazione dell’occhio del coniglio che ha fatto il giro del mondo), che del modello in vivo LD-50 (dose letale al 50%) che prevedeva la morte per intossicazione acuta, indotta dal composto oggetto di studio, del 50% degli animali utilizzati per la procedura.
Per quanto riguarda le ricerche di farmacocinetica e farmacodinamica sulle molecole destinate a diventare possibili farmaci, i metodi alternativi non offrono ancora proposte definitive in grado di sostituire l’animale, anche se è opinione scientifica condivisa che le osservazioni sull’animale risultino essere grossolane e –non di rado– addirittura inutili, in quanto l’attività metabolica e la complessità enzimatica variano molto da specie a specie, anche al di dentro della stessa classe dei mammiferi placentati.
La critica al modello animale, per il meccanismo d’azione delle molecole, ha spinto alla costruzione di due linee di ricerca in vivo/umano: la prima si realizza nel soggetto volontario (human-based) utilizzando “microdosi” ed ipotizzando poi le reazioni a posologia maggiore attraverso programmi informatici predittivi (in silico); la seconda prevede i “modelli fungini” (fungal-model), cioè l’utilizzo di funghi il cui metabolismo riassume molte caratteristiche del metabolismo dei farmaci nei mammiferi, quelle molecole (non poche) che vengono metabolizzate sulla linea enzimatica del citocroma P-450. Di fatto, ad oggi, l’unico fungo già utilizzato con un certo successo è la cunninghamella elegans.
Ai laboratori dell’IZSLER (Zooprofilattico Lombardia Emilia-Romagna) – come dichiara da responsabile Maura Ferrar – per quanto riguarda i metodi alternativi, si perseguono le seguenti attività in vitro:
- Test di citotossicità.
- Test di valutazione della capacità inibente l’infettività virale da parte di farmaci, nuove molecole, disinfettanti e trattamenti chimico-fisici.
- Test di trasformazione cellulare.
- Determinazione della presenza di contaminanti virali in reagenti di origine animale (siero fetale di bovino ed enzimi proteolitici) utilizzati per la produzione di prodotti biologici.
- Determinazione di contaminanti virali in prodotti biologici e farmaci, incluse le cellule stromali mesenchimali (CSM) destinati all’uomo ed agli animali.
- Test di carcinogenicità in vitro.
Dobbiamo ricordare che il processo di validazione di un Test dura di solito diversi anni e, finché il percorso non è giunto al termine, il Test non può essere ufficialmente utilizzato. È a questo punto pertinente la messa in luce del paradosso che vede i Test alternativi validati da “procedure di paragone” effettuate tradizionalmente con modello animale. In altre parole: un test alternativo/sostitutivo è valido se raggiunge gli stessi risultati di una prova con gli stessi fini effettuata sull’animale. Ma chi ha mai validato il Test sull’animale? Nessuno, se non la consuetudine della pratica sperimentale empirica. Questo è appunto un lato debole della sperimentazione tramite modelli animali.
La giornalista scientifica Caterina Lucchini, in un’intervista ad Isabella De Angelis e a Gianni Dal Negro (Notiziario Chimico-Farmaceutico, 2016), rileva come l’attrition rate, cioè il tasso di abbandono dell’esperimento, quindi l’insuccesso del modello animale, sia addirittura attorno al 95%. Ciò vuol dire che centinaia di ore di lavoro – oltre ad una grande quantità di animali – si perdono nel nulla.
Ora vorrei dire qualcosa sui sistemi in silico e sui grandi progetti.
In silico (computer simulation)
I primi tentativi di simulazione informatica nelle discipline biomediche sono abbastanza antichi. Nei primi anni ’50 la Alderson Research Labs creò un modello di rappresentazione elettromeccanica degli eventi traumatici nel contesto del traffico stradale (Crash Test). Questo Test consentì di risparmiare la vita a centinaia di maiali e di scimmie.
Negli anni a seguire, con lo sviluppo dei programmi computerizzati, si moltiplicarono i Test di simulazione biologica. Un modello ormai ampiamente usato è il PCM (modello del continuo polarizzabile), prova di chimica computazionale che simula l’interazione tra un gruppo chimico o biochimico e l’ambiente umido in cui è inserito; in altri termini descrive la relazione tra soluto e solvente, praticamente in ogni tipo di preparazione biologica in cui una cultura molecolare sia a contatto con una soluzione ospitante.
Una delle basi di fondo del calcolo computazionale in biologia è la cosiddetta “relazione quantitativa struttura-attività” (Quantitative Structure-Activity Relationship [QSAR]). Di fatto si tratta di un modello matematico/informatico che calcola l’attività biologica di un farmaco in funzione delle sue caratteristiche fisico-chimiche strutturali (polarità, ingombro sterico, energia degli orbitali di frontiera). Ciò è molto utile per valutare la capacità di una molecola di superare una certa membrana cellulare o la capacità di legarsi ad un recettore specifico.
Ancora: un esempio evoluto di metodologia mista in silico/in vitro è rappresentato dalla tossicogenomica, disciplina che unisce tossicologia e genomica al fine di studiare gli effetti della tossicità di un composto sul genoma e, di conseguenza, sull’organismo. Le principali tecnologie tossicogenomiche sono: la trascrittomica e la mRNA, molto utili in oncologia per interpretare la relazione tra espressione genica e composti oncogeni che la modificano. Queste metodiche hanno mostrato grande utilità negli studi sui vaccini in occasione dell’epidemia Covid-19.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), quattordici anni fa, rese ufficiale il rapporto “Test di tossicità nel XXI secolo: una visione e una strategia”, che ha delineato un percorso a lungo termine per trasformare i vecchi Test di tossicità basati sul modello animale (LD-50), ritenendoli troppo lenti, troppo costosi e poco predittivi. Il nuovo percorso indicato è quello della tossicogenomica. Gli elementi strutturali del piano considerano l’uso di analisi predittive, ad alta velocità, basate su cellule di origine umana (toxome umano) per valutare la perturbazione cellulare che si verifica nel contatto tra un gruppo istologico ed un composto chimico (Commissione per i Test di tossicità e valutazione degli agenti ambientali, 2013).
Esempi italiani: spigolando qua e là
Sulla linea ora citata si muove l’attività di diversi laboratori come Biogem, ad Ariano Irpino (Avellino), dove Concetta Ambrosino, ricercatrice all’Università del Sannio, coordina un articolato programma europeo sulla tossicogenomica.
Un’altra ricercatrice italiana che voglio menzionare, punto di riferimento sempre più apprezzato per la partecipazione a vari programmi in vitro/in silico – con cui ho avuto l’onore di discutere personalmente – è Costanza Rovida, operativa al CAAT-Europe (Centro per le Alternative ai Test sugli Animali), legato ad un’università tedesca. Costanza Rovida, sulla base di molti anni di esperienza, afferma con decisione l’efficacia dei Test alternativi nel senso di una loro maggiore e precisa capacità predittiva rispetto alle prove su animali. Costanza fa ora parte del progetto europeo EU-ToxRisk che si impegna a studiare nuove strategie di Test focalizzate allo studio del meccanismo di azione delle sostanze chimiche sull’uomo.
Altro progetto in fase di sviluppo è quello portato avanti da un gruppo di giovani fisici all’Università Aldo Moro di Bari, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il gruppo, partendo dalla Risonanza Magnetica (RMN) effettuata su 200 soggetti con “lieve indebolimento cognitivo”, ha creato, sulla base di un calcolo probabilistico complesso effettuato al centro di calcolo ReCaS, un modello predittivo per la Malattia di Alzheimer (La rivista New Scientist, del 14 settembre 2017, ha pubblicato parte dello studio).
Perché ho citato questi esempi, tra i mille che avrei potuto menzionarne? I primi due riguardano persone d’eccellenza scientifica che hanno scelto le NAT (tecnologie senza animali) non per una scelta animalista, ma in quanto le ritengono più attendibili e predittive rispetto al modello animale. Nel terzo caso ho voluto indicare l’esempio di un gruppo di giovani connazionali di estrazione non direttamente biomedica –e proprio per questo non avvezzi al modello animale, né alla ricerca biologica di dettaglio – che hanno intravvisto comunque l’opportunità di concentrarsi su un problema sociale e sanitario di primaria importanza: la demenza senile, ed hanno scommesso sull’approccio delle scienze esatte. Si noti che fino ad ora le ricerche sul peptide β-amiloide e sul deficit colinergico, che hanno utilizzato il modello murino (sul topo), non avevano prodotto risultati significativi, né relativamente alla predittività, né alla patogenesi.
Grandi progetti
I progetti attivati, negli ultimi 10 anni, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, sono molti. In questo paragrafo ne citiamo alcuni fra i più importanti, dando anche in nota l’indirizzo dei siti di riferimento per poterli conoscere. Bisogna ricordare che la maggior parte riguardano la tossicologia; ciò vuol dire che ampie fasce della ricerca biomedica risultano essere ancora molto indietro o addirittura totalmente sprovviste di metodi alternativi.
I progetti
EUROECOTOX – European Network for Alternative Testing Strategies in Ecotoxicology
Si tratta di una rete europea per lo studio e la produzione di strategie alternative in ecotossicologia. È finanziato dal VII PQ/CE (VII Programma Quadro del “programma ambiente” della Commissione Europea). Gli obiettivi prioritari della rete Euroecotox sono: a) contribuire allo sviluppo di Test senza animali di ecotossicità in Europa; b) promuovere la validazione e la regolamentazione di nuovi metodi.
SEURAT – 1
È un programma a medio-lungo termine composto da sei progetti di ricerca concordati tra settanta università ed istituti europei. L’obiettivo è sostituire totalmente la testistica tossicologica tradizionale con metodi che non prevedano la sperimentazione animale.
TOXCAST/2007 e TOX-21
Sono programmi governativi statunitensi ad alta tecnologia, gestiti dalla EPA (United States Environmental Protection Agency). Sono state testate, a livello tossicologico, 10.000 sostanze, con risultati giudicati altamente attendibili. In alcuni anni di attività il programma ha ampiamente dimostrato la totale superiorità dei metodi NAT per ciò che riguarda la celerità, la precisione e la possibilità di standardizzazione dei risultati e dei dati (www.epa.gov/chemical-reseach/toxicology).
AXLR8
AXLR8 può essere definito una “azione di coordinamento” all’interno del VII PQ/CE. La Comunità Europea, con questo progetto, promuove e finanzia realtà consortili (consorzio fra laboratori) che si uniscono al fine di studiare e creare procedure sostitutive.