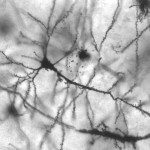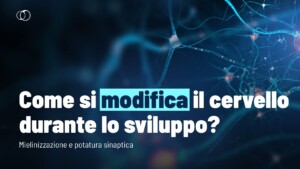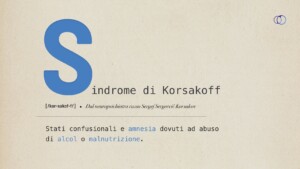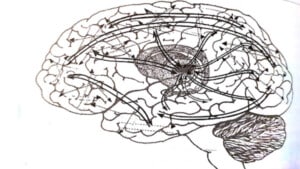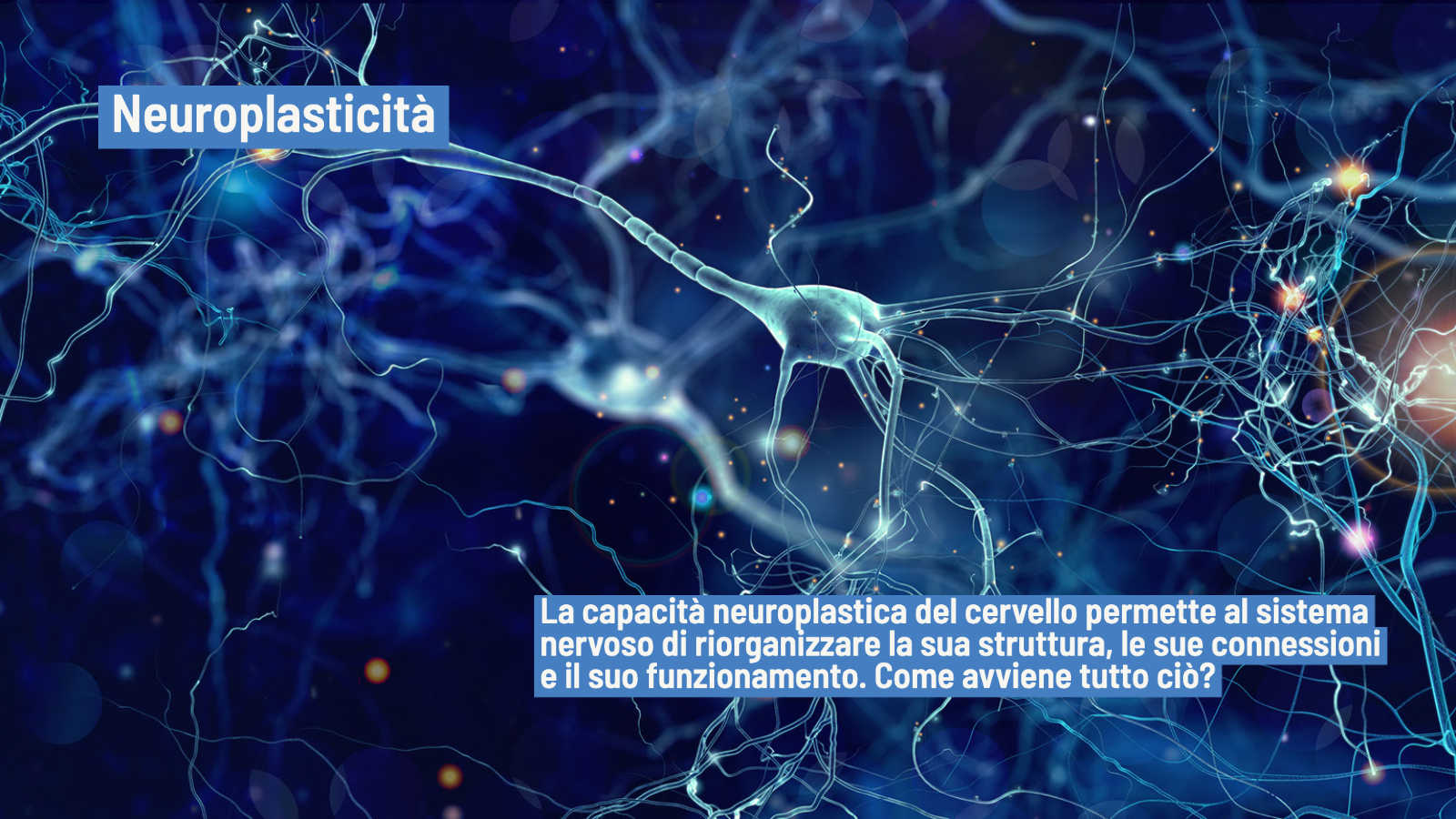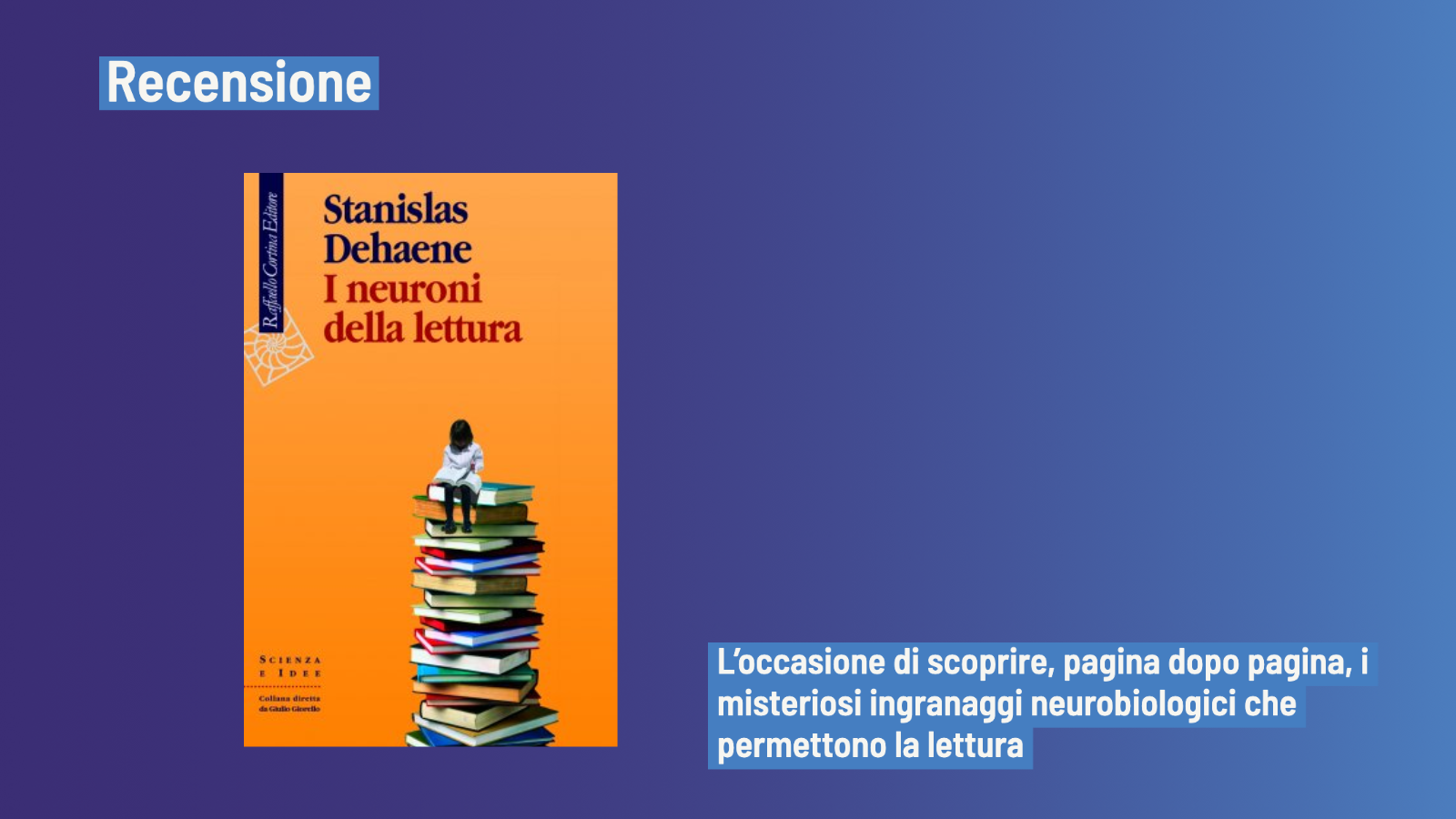Alessitimia e psicopatologia: un’analisi evolutiva – L’alessitimia in età evolutiva
Artoni Grazia, Atti Martina, Giaroli Enrica e Paterlini Susanna – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi Modena
Nel bambino, come nell’adulto, l’alessitimia rappresenta una difficoltà a sentire e modulare i propri sentimenti, a parlare e pensare su affetti ed emozioni proprie ed altrui. I bambini, come gli adolescenti e gli adulti alessitimici, hanno una relazione con sé e con il mondo esterno che esclude il riferimento agli stati emotivi.
LEGGI ANCHE: Alessitimia e psicopatologia: un’analisi evolutiva – Introduzione
Il loro cogliersi nel mondo sembra riferito ad aspetti meramente descrittivi e tangibili (come il vissuto corporeo) e quando tentano di immaginare qualcosa al di là dell’osservabile il loro vissuto perde vividezza.
In età evolutiva, però, a fronte di una grande quantità di studi che ribadiscono la centralità della crescita emotiva nel normale sviluppo psichico di una persona, si osserva un ridotto numero di ricerche che abbiano come oggetto di studio l’alessitimia. Ciò può essere dovuto anche alla mancanza fino a tempi recenti di strumenti psicometrici per la valutazione del costrutto in questa fascia d’età.
Rieffe et al. (2006) hanno validato l’Alessitimia Questionnaire for Children (AQC), una versione semplificata della 20-Item Toronto Alessitimia Scale per adulti (TAS-20), su un campione di bambini di 9-14 anni. Il questionario mantiene i 20 items della scala per adulti ricalcando gli stessi contenuti ma con un riadattamento linguistico che ne facilita la comprensione ai bambini. La scala presenta buone caratteristiche psicometriche ed una struttura a 3 fattori che riprende quella della TAS-20 (Difficoltà a Identificare i Sentimenti, DIS; Difficoltà ad Esprimere i Sentimenti, DDS; Pensiero Orientato all’Esterno, POE).
Prima di loro Fukunishi et al. (1998) avevano sviluppato in Giappone una Scala di Alessitimia Bambino/Insegnante, basata cioè su una valutazione del bambino da parte degli insegnanti. L’analisi fattoriale ha portato a mantenere 12 item che saturano due fattori: Difficoltà a descrivere i sentimenti e Difficoltà nel rapportarsi con gli altri. La scala ha inoltre mostrato una correlazione con i punteggi di depressione, carenza di cooperazione, dominanza (correlazione negativa) e estroversione sociale (correlazione negativa).
Recentemente Di Trani et al. (2009) hanno sviluppato una versione italiana del Questionario per l’Alessitimia in età evolutiva proposto da Rieffe e collaboratori (2006) e ne hanno testato la struttura fattoriale e l’attendibilità. Scopo degli autori era anche quello di indagare la struttura fattoriale del questionario assumendo che l’alessitimia possa presentare in età evolutiva caratteristiche diverse da quelle riscontrabili in età adulta. Il questionario italiano mantiene, come la scala originaria, 20 item con tre alternative di risposta (per niente vero, un po’ vero, vero). E’ stato utilizzato un campione di 576 bambini di età compresa tra gli 8 e i 14 anni suddivisi in due fasce d’età (8-10 e 11-14 anni) secondo il criterio cronologico genericamente utilizzato per definire il passaggio dall’età infantile alla prima fase dell’adolescenza. L’analisi dei dati raccolti ha permesso di evidenziare la presenza di quattro fattori di cui tre si sovrappongono a quella della versione per adulti (Difficoltà ad identificare i sentimenti, DIS; Difficoltà a descrivere i sentimenti, DDS e Pensiero orientato all’esterno, POE), mentre si evidenzia la presenza di un nuovo fattore denominato dagli autori ‘Confusione delle sensazioni fisiche, CSFi, che include gli item che fanno riferimento al corpo e a come ci si sente dentro.
Le verifiche empiriche sembrano, quindi, confermare che la capacità di regolazione emotiva si esplichi, in età evolutiva, attraverso componenti relativamente diverse da quelle osservate per l’età adulta. Mentre gli aspetti di contatto ed espressione delle emozioni sembrano rimanere alla base del costrutto dell’alessitimia, l’analisi su campioni con diverse età permette di rilevare delle componenti specifiche. In questa ricerca, infatti, è stato possibile osservare la presenza di un fattore specifico, la
Confusione sulle sensazioni fisiche, che pone l’attenzione sugli aspetti corporei dell’esperienza emotiva. Gli autori ipotizzano che, in questa fascia d’età, appaia di particolare importanza la considerazione delle percezioni corporee nella definizione del contatto con le emozioni. Per quanto riguarda i confronti rispetto al genere sessuale e le fasce d’età non si rilevano differenze tra maschi e femmine, mentre emerge che i bambini di fascia d’età 8-10 anni presentano punteggi mediamente più alti nella scala rispetto alla fascia 11-14. Secondo gli autori il dato, più che evidenziare caratteristiche alessitimiche in questa fascia d’età, sembra rappresentare la presenza di un percorso di sviluppo delle competenze emotive ancora non completamente realizzato.
Per bambini in età prescolare, nonostante siano presenti in letteratura diversi strumenti per valutare le competenze emotive, nessuno di essi si fonda sul concetto di alessitimia. Tali strumenti sono dei compiti in cui viene chiesto al bambino di riconoscere le emozioni, descriverle, raccontare storie su di esse ecc., non essendo possibile somministrare degli strumenti self-report.
Alessitimia e attaccamento: quale correlazione?
Per quanto riguarda l’alessitimia e i disturbi dello sviluppo emotivo è stata messa in luce l’influenza critica, estremamente significativa, delle prime esperienze relazionali e di attaccamento.
In linea con le osservazioni dell’Infant Research il costrutto dell’alessitimia è stato apparentato a quello di Regolazione Affettiva, funzione strettamente legata al rapporto con l’accudente che, specie nelle prime fasi di vita, interviene a regolare le emozioni del neonato e del lattante (Solano, Capozzi, De Gennaro et al., 2007).
Studi osservativi condotti su neonati nell’interazione con il caregiver principale (di solito la madre) hanno mostrato che nel bambino è rintracciabile, fin dai primi mesi di vita, capacità di espressione e comprensione delle emozioni che gli permettono di sintonizzare la propria comunicazione con quella della madre (Crugnola & Baioni, 2002). Se è quindi dimostrata la presenza di emozioni innate di base, espresse fin dall’inizio dal punto di vista comportamentale e fisiologico, l’aspetto soggettivo – esperienziale delle emozioni di base e le emozioni più complesse (amore, vergogna, invidia…) si sviluppano durante la prima infanzia. Le acquisizioni, nel secondo anno di vita, della capacità rappresentativa e del linguaggio hanno un impatto fondamentale nello sviluppo della consapevolezza emotiva soggettiva e nella capacità di identificare e regolare gli affetti, sia a livello interpersonale che nelle relazioni con gli altri.
In questo sviluppo degli affetti, oltre alla crescita cognitiva, sono le prime relazioni a giocare un ruolo di grande importanza. Nella primissima infanzia la capacità di regolazione degli affetti è, infatti, facilitata dall’esperienza di condivisione e di rispecchiamento delle espressioni emotive con il caregiver primario e, in seguito, dalle interazioni giocose nelle quali si ha l’apprendimento della denominazione e dell’espressione dei sentimenti. La madre svolge quindi un fondamentale ruolo nel contenere, elaborare e interpretare gli stati affettivi del suo bambino offrendogli una risposta sintonica all’affetto che sta provando ed aiutandolo così a riconoscere i propri stati interiori come legittime forme di esperienza che possono essere condivise con altri. Laddove questa funzione di contenitore e di regolatore fallisce le emozioni del bambino rimangono a livello di percezioni e sensazioni, non riuscendo ad essere trasformate in rappresentazioni mentali e oggetti di pensiero (da qui l’alto rischio di disturbi psicosomatici) (Taylor, 1997).
Anche le teorie della Crittenden hanno una rilevanza particolare per il costrutto di alessitimia in quanto forniscono una concettualizzazione interessante dell’importanza evolutiva delle primissime relazioni di attaccamento in cui il soggetto impara a regolare non solo il funzionamento interpersonale, ma anche quello mentale ed emotivo (Fabbri, 20015). Grazie ad un legame di attaccamento sicuro, caratterizzato da un buona sintonizzazione e responsività del caregiver, il bambino impara a utilizzare la valutazione cognitiva per modulare gli affetti e gli affetti per arricchire la cognizione.
Secondo Crittenden i problemi di inibizione o disregolazione affettiva nascono da stili di attaccamento insicuri, che si associano con modelli interni di rappresentazione caratterizzati da una mancata integrazione delle informazioni affettive e di quelle cognitive.
In particolare, il bambino con attaccamento insicuro evitante sperimenta una figura d’attaccamento che tende ad essere costantemente rifiutante e a ignorare o punire le richieste di conforto. Le informazioni causali e spazio-temporali appaiono stabili e coerenti per cui il bambino apprende ad utilizzare in modo efficace l’informazioni cognitiva e inibisce le manifestazioni affettive in quanto minacciano lo stato di relazione (si sviluppano problemi di riconoscimento ed espressione degli affetti).
Il bambino con attaccamento insicuro – ambivalente sperimenta un genitore che mette in atto comportamenti di accudimento incoerenti e imprevedibili. Viene a mancare la possibilità di coerente ordinamento sequenziale degli eventi per cui il bambino sperimenta che lo stato di relazione può essere mantenuto solo attraverso un’abnorme attivazione affettiva (non sviluppa la capacità di usare la cognizione per modulare gli affetti e funziona con affetti non regolati).
In questi casi una vasta gamma di vissuti emozionali del bambino (quali la rabbia, la tristezza, la paura) vengono costantemente (o in modo intermittente) male interpretati (es. come segnali di fame o di sonno) scoraggiati e ricevono risposte, addirittura, punitive. Questi stati emotivi sono pertanto esperiti dal bambino come sconvenienti o pericolosi; vengono inibiti, falsificati e cancellati dal repertorio delle relazioni intime, rischiando così di rimanere bloccati ad un livello puramente percettivo – somatico con scarso accesso alla consapevolezza e alla comunicazione (Fabbri, 2005).
Queste configurazioni di attaccamento predispongono ad un alto rischio di problematiche emotive e di sviluppo psicopatologico, soprattutto in assenza di variabili contestuali e sociali che possano fornire all’individuo in crescita esperienze di relazione diverse e significativamente positive (Arace, 2002).
Secondo Taylor (2004) il campo di ricerca sull’attaccamento è una preziosa fonte di informazioni sull’eziologia dell’alessitimia. Non vi sono purtroppo studi longitudinali che hanno seguito gli individui dall’infanzia all’età adulta. Molti studi effettuati sugli adulti hanno però rilevato che l’alessitimia è associata a stili insicuri di attaccamento, sia di tipo evitante che preoccupato o timoroso.
Cosa emerge dalle ricerche in età evolutiva? Eziologia e psicopatologia dello sviluppo
Come già riportato sopra, la mancanza, fino a tempi recenti, di strumenti psicometrici per la valutazione dell’alessitimia in età evolutiva ha rappresentato un limite fondamentale circa la possibilità di approfondire il ruolo che tale costrutto possa avere nella psicopatologia dello sviluppo.
Come sottolineato da diversi autori, una misura di questo costrutto adattata per i bambini sarebbe importante per offrire l’opportunità di comprendere meglio il rapporto esistente tra emozioni, parole e pensieri nello sviluppo psichico patologico e normale del bambino, nonché il peso del costrutto alessitimico nelle situazioni traumatiche, nelle malattie psicosomatiche e nei disturbi psicopatologici (depressione, DOC, ADHD, ecc.) più frequenti nella prima infanzia (Solano et al., 2007). Si riportano di seguito alcune ricerche in età evolutiva volte ad indagare direttamente tale costrutto e che possono fornire indicazioni circa la sua eziologia e correlati psicopatologici.
Di Trani e coll. (2009) riportano come, nonostante il corpus di ricerche limitato, si confermi, come per gli adulti, la presenza di alti punteggi di alessitimia in bambini e adolescenti con patologie somatiche, con disturbo del comportamento sessuale ed alimentare e con aspetti dissociativi. Rieffe e colleghi (2005) hanno osservato in soggetti di 6 e 15 anni la correlazione positiva tra alessitimia e presenza di umore negativo e di sintomi somatici. In una ricerca condotta da Marchetti e Cavalli (2013) con 152 bambini di 6-11 anni è emerso come alcune caratteristiche dell’alessitimia (difficoltà a descrivere le emozioni e pensiero orientato all’esterno) correlino con difficoltà nella mentalizzazione, che consiste nell’abilità di attribuire stati mentali a sé e agli altri e prevedere i comportamenti sulla base di essi. Tale carenza comporta pertanto importanti riflessi sia sul funzionamento sociale che sulla regolazione emotiva.
Secondo Taylor e Bagby (2004) un’altra area di ricerca che sta portando risultati interessanti deriva dal Northern Finland Birth Cohort Project in cui sono stati raccolti dati evolutivi in 12.000 bambini nati nel 1966, a cominciare dalle fasi prenatali. La TAS-20 è stata somministrata ad almeno 6.000 individui in un follow-up di 31 anni. L’alessitimia in età adulta è risultata associata con l’essere stato un bambino non desiderato dai genitori, nato in una famiglia con molti figli ed in modo particolarmente marcato con l’aver vissuto in ambiente rurale. Inoltre, l’alessitimia è stata associata alla capacità di parlare all’età di un anno, ossia il punteggio medio della TAS-20 è risultato più basso in coloro che hanno parlato precocemente. Questi risultati suggeriscono che i fattori sociali durante l’infanzia e le differenze individuali nello sviluppo del linguaggio possono avere un ruolo eziologico nello sviluppo di alessitimia.
Solano et al. (2007) riportano di un solo studio che, allo scopo di valutare il rapporto tra esperienze traumatiche infantili e presenza di alessitimia nei bambini stessi, ha esaminato bambini abusati dai tre ai sette anni e le loro madri, riscontrando che sia i bambini abusati che le loro madri mostravano maggiori difficoltà nel produrre un’espressione facciale dell’emozione, mentre solo i bambini mostravano difficoltà nel riconoscimento dell’espressione facciale stessa. Venne, inoltre, riscontrata una correlazione diretta tra capacità delle madri di produrre espressioni facciali di emozione e la capacità dei bambini di riconoscerle e produrle. Inoltre, diversi lavori che hanno utilizzato la TAS – 20, hanno evidenziato una correlazione significativa tra alessitimia materna e caratteristiche affettive della prole (Solano et al., 2007).
Quali i disturbi somatoformi in età evolutiva?
La valutazione di questi disturbi nell’età infantile non è facile, perché il corpo costituisce il primo mezzo che il bambino ha di segnalare una qualsiasi forma di sofferenza. E’ importante che il pediatra non abbia riscontrato alcune causa fisica. Nella maggior parte dei casi le manifestazioni sono transitorie e rimandano a quadri clinici di altro tipo (es. disturbo d’ansia e fobia scolare). I disturbi possono manifestarsi nell’apparato gastrointestinale (gastrite, colite ulcerosa, ulcera peptica), nell’apparato respiratorio (asma bronchiale, sindrome iperventilatoria, disturbi respiratori), nel sistema cutaneo (es. psoriasi, dermatite atopica, orticaria), nel sistema muscolo scheletrico (cefalea tensiva, crampi muscolari, cefalea nucale). Anche le vertigini possono essere una forma di somatizzazione. I bambini spesso sviluppano sintomi somatici quando sono emotivamente sofferenti e la prevalenza è di circa 11% nelle femmine e il 4% nei maschi. Le difficoltà che innescano risposte di tipo somatico spesso sono legate alle relazioni familiari, con il gruppo dei pari e anche con gli insegnanti. La presenza di problemi psicologici nella madre e difficoltà nella relazione madre – bambino costituiscono importanti fattori di rischio (Strepparava & Iacchia, 2012).
Nel caso dei disturbi somatoformi, la teoria dell’attaccamento costituisce una chiave importante per la comprensione del sintomo somatico. Questa considera, infatti, il sintomo come la strategia che il bambino ha trovato per regolare lo stato di relazione con le figure d’attaccamento e nello stesso tempo mantenere il senso di sé. Ciò è valido anche per i disturbi somatoformi il cui valore relazionale sarà pertanto differente in base alla qualità della relazione esistente tra il bambino e le sue figure d’attaccamento.
In contesti diadici coercitivi l’osservazione clinica mostra come il sintomo somatico venga costruito, amplificato e utilizzato dal bambino con la precisa finalità di stabilizzare il legame con una madre percepita come discontinua, che tuttavia egli scopre particolarmente sensibile e reattiva al disagio fisico e alla malattia. Si ritrovano su questo versante gran parte dei quadri somatici, in assenza di chiare alterazioni organiche, su cui si focalizza il lavoro dei pediatri di base e ospedalieri: coliche addominali ricorrenti, vomito, alcune forme di cefalea, sindromi dolorose di varia natura e lamentele somatiche non chiaramente definite (Ciotti & Lambruschi, 2004). Un’analisi funzionale del sintomo, nei suoi antecedenti e nei suoi conseguenti ambientali, è spesso sufficiente a mettere in luce la valenza di ancoraggio dei sintomi nei confronti delle figure di attaccamento: la loro funzione di controllo della relazione appare subito chiara.
Secondo Ruggerini, Lambruschi, Neviani et al. (2004) questi piccoli pazienti, così ‘sballottati’ tra gli affetti e con così limitate capacità auto regolative, in terapia possono usufruire positivamente di un piano di acquisizione di abilità di coping degli stati emotivi (in particolare dell’ansia e delle componenti neurofisiologiche) tramite l’utilizzo di tecniche cognitivo – comportamentali come il rilassamento muscolare progressivo unito a tecniche di ristrutturazione cognitiva.
Nei pattern relazionali difesi, invece, i disturbi psicosomatici appaiono spesso più gravi, persistenti nel tempo e scarsamente ancorati al comportamento contingente dei genitori, in un contesto relazionale connotato in genere da scarsa emotività espressa. E’ come se il corpo del bambino fosse completamente disinvestito e i sintomi fisici semplicemente delle contrarietà minori che i genitori si trovano obbligati a gestire (Strepparava & Iacchia, 2012). Data la pervasività dei sintomi, c’è un’evidente difficoltà a rintracciare specifiche situazionalità, mentre un aiuto più efficace può venire dalla ricostruzione della storia dei sintomi fisici che spesso sono legati ad importanti eventi di vita (frequentemente caratterizzati dal tema della perdita), ma che vengono connotati come scarsamente rilevanti. I contenuti affettivi tendono ad essere accantonati e il piano emotivo e scarsamente integrato (se ciò avvenisse porterebbe la consapevolezza della sofferenza). Ruggerini et al. (2004) riportano come tali situazioni si avvicinino maggiormente ai quadri classicamente descritti come alessitimici. I sintomi sembrano l’esito di un precoce e pervasivo processo di addestramento interpersonale all’inibizione degli stati affettivi e delle disposizioni all’azione a essi collegate. Il sintomo verrebbe usato dal bambino per sentirsi oggetto di attenzione e cure in una relazione in cui il genitore si occupa di lui ma nella quale non è possibile esprimere direttamente ed affrontare la paura di perdere le proprie figure d’attaccamento.
L’alopecia è un disturbo somatico che può presentarsi in età evolutiva. I fattori psicologici e ambientali sono fondamentali nel determinare tale disturbo che sembra presentarsi sia in caso di carenza affettiva, sia a seguito della perdita di figure significative d’attaccamento. Nella storia dei bambini affetti da alopecia si ritrovano spesso eventi stressanti legati al perdere qualcosa o qualcuno: situazioni dolorose o problematiche che hanno grande risonanza affettiva per il bambino, che però non è in grado di manifestare le sue difficoltà, né si trova in un ambiente in grado di farlo se solo ci provasse.
Con queste tipologie di disturbi psicosomatici dovranno essere utilizzate strategie terapeutiche che favoriscano il riconoscimento, la denominazione e la gestione degli affetti, all’interno di una relazione caratterizzata da accudimento e protezione. Occorre supportare questi bambini nel riconoscere ed elaborare i propri stati interni, dando spazio all’espressione dei loro desideri e delle loro paure. E’ importante ricostruire in seduta, con le modalità tipiche della terapia cognitiva, gli episodi critici della quotidianità aiutando i bambini a riconoscere e ad aggiungere i pezzi mancanti al loro dialogo interno (cioè quelli più densi di rabbia e dolore). Utili a riguardo si rilevano le tecniche di autosservazione emotiva come il diario di autosservazione quotidiana che, con il termometro delle emozioni, rappresenta un riferimento importante per ricostruire in seduta, sotto forma di disegno, di drammatizzazione o di gioco gli eventi critici e significativi della vita del bambino (Ruggerini et al., 2004).