Psicologia dell’Aggressività: genesi, fenomenologia e meccanismi scatenanti
L’aggressività è qualcosa di connaturato all’essere umano. Essa può avere un duplice destino, ovvero tramutarsi in condotte socialmente accettabili oppure generare comportamenti violenti finalizzati al produrre sofferenza negli altri. I meccanismi che presiedono alla sua genesi, le condizioni che la incrementano e le procedure che la cronicizzano sono tutt’ora oggetto di analisi nell’ambito delle scienze della mente.
Esistono diverse definizioni che esplicitano il costrutto di aggressività. Volendo sintetizzare, si può definire l’aggressività umana come un comportamento intenzionale che ha come obiettivo quello di procurare sofferenza ad un altro individuo della stessa specie, provocandogli delle lesioni psicologiche o materiali.
Nell’ambito della cronologia dell’aggressività si possono riconoscere vari momenti, fra i quali:
– la patogenesi;
– i meccanismi di implementazione.
La patogenesi dell’aggressività umana
Molto probabilmente l’origine dei comportamenti aggressivi risiede in alcune caratteristiche endemiche all’individuo, quali la provenienza da una famiglia in cui l’aggressività è uno stile relazionale diffuso o da un gruppo sociale in cui le modalità interattive sono estremamente violente.
Le cose però non sembrano essere così semplici e questo è dimostrato dalle varie ipotesi, che in campo filosofico sono state avanzate nel corso della storia dell’umanità, e dalle teorizzazioni psicologiche, che nell’ambito dell’ultimo secolo sono andate coagulandosi.
Che l’aggressività sia sempre stata un nodo concettuale dibattuto è confermato dalle speculazioni che hanno attraversato le ideologie dei vari filosofi nella successione del tempo (Martina, 1994).
Nel pensiero greco antico, per esempio, all’aggressività era ascritta una valenza positiva, allorquando obbediva alla razionalità, divenendo sinonimo di coraggio in battaglia.
Per il pensiero latino, nello specifico nelle teorizzazioni di Seneca, l’aggressività è considerata un equivalente della follia.
Nelle concettualizzazioni medievali l’aggressività diviene sinonimo di ira. A questo riguardo San Tommaso distingue l’ira in:
– ira biliosa;
– iracondia;
– furore.
L’ira biliosa è quella che si attiva subito dopo aver subito un torto e che si spegne altrettanto rapidamente. L’iracondia è quell’aggressività di lunga data che si acutizza ogniqualvolta si pensa all’episodio che l’ha scatenata. Il furore è quell’emozione che si esplicita nel momento della vendetta.
Un grande teorico dell’aggressività umana è stato il filosofo Hobbes. Secondo il suo pensiero, la rabbia si attiva allorquando una persona sente di essere stata disprezzata da un suo simile e diventa condotta aggressiva nel momento in cui il denigrato è mosso dal desiderio di vendetta nei confronti dell’individuo che lo ha svilito. Il far del male all’altro è una peculiarità dell’essere umano riassunta nel famoso costrutto homo homini lupus .
Per Cartesio l’aggressività corrisponde alla collera che si scatena quando qualcuno subisce del male, provocato da un altro individuo. Si distinguono due varianti della collera:
– la collera subitanea, meno nociva dal punto di vista della violenza;
– la collera tardiva, che è esplosiva e particolarmente violenta.
Per Schopenhauer l’aggressività è endemica all’essere umano ed è sintonica con quello che avviene in natura, ovvero è presente in tutte le specie animali.
Anche per Nietzsche l’aggressività è un qualcosa di connaturato all’uomo e deriva dal condizionamento del Cristianesimo. L’individuo sovente la dirige verso se stesso, generando una forma di autoconflittualità. Solo il superuomo, secondo il filosofo tedesco, ha imparato a dirigerla fuori di sé, esplicitandola nelle azioni di guerra.
Nel corso del ventesimo secolo varie ipotesi sono state fatte in ambito psicologico riguardo alla genesi dell’aggressività (Palmonari, Cavazza e Rubini, 2012).
Secondo la teoria etologica, espressa da Lorenz, l’aggressività nasce da un istinto endemico all’essere umano, ovvero una pulsione interiore che genera e dirige i suoi comportamenti aggressivi.
Tale forza interna è attivata da elementi ben precisi quali:
– la difesa di quello che si possiede a livello materiale, emotivo e affettivo;
– la lotta per il potere;
– il bisogno di rendere organizzato il proprio ambiente di vita.
Tutto questo si realizza con una finalità ben precisa che è quella di assicurare un futuro per sé e per coloro che condividono lo stesso patrimonio genetico.
La stessa linea di tendenza pulsionale si trova nelle teorizzazioni freudiane. Per Freud l’aggressività ha un’origine istintuale, legata all’istinto di morte che insieme all’istinto di vita coabita nello stesso individuo. Perché la persona possa conservare la propria integrità, l’aggressività deve essere indirizzata verso l’esterno, preferibilmente canalizzandola in attività socialmente accettate, come quelle che caratterizzano le rivalità fra i gruppi all’interno di un’organizzazione sociale, egemone in un contesto geografico.
Nell’ambito dell’aggressività umana, secondo Fromm, si possono distinguere una forma benigna, necessaria alla sopravvivenza dell’individuo in quanto permette di difendere la propria personalità e il proprio mondo, e una forma maligna, che determina la distruttività nell’ambito delle relazioni fra le alterità.
Secondo la teoria della frustrazione, elaborata da Dollard e Miller, alla base dell’aggressività c’è un meccanismo di frustrazione. In ragione di ciò, l’individuo prova questa emozione allorquando trova degli ostacoli sul suo cammino che impediscono il raggiungimento degli obiettivi che si è fissato. L’aggressività subisce un incremento esponenziale in funzione dell’avvicinamento alla meta. In altre parole, quanto più l’individuo sta per raggiungere il suo obiettivo e viene interrotto in tale proposito, tanto più aumenta la sua aggressività.
Solitamente questo stato emotivo viene orientato non verso le persone che hanno determinato la frustrazione, ma in direzione degli individui che per caratteristiche personali (maggiore debolezza e minore potere) si prestano facilmente a divenire oggetto dei comportamenti aggressivi. Secondo questo costrutto, inoltre, perché l’individuo possa accedere alle condotte violente deve essere vissuto in un ambiente estremamente tipizzato in tal senso.
Questa teoria è stata successivamente meglio delineata da Berkowitz, secondo cui la frustrazione determina una predisposizione all’aggressività, che si palesa in condotte violente laddove trova le condizioni favorevoli, che sono rappresentate da alcune variabili, quali:
– un contesto di vita in cui predominano gli atteggiamenti aggressivi nelle interazioni sociali;
– una disposizione personale derivante dall’essere vissuto in un ambiente familiare, caratterizzato da stili relazionali aggressivi.
Per Berkowitz, oltre che dalla frustrazione, l’aggressività può essere elicitata anche dalle condizioni croniche di dolore e sofferenza.
Nell’ambito comportamentista l’aggressività è teorizzata come frutto del condizionamento operante. In altre parole, il soggetto nel corso della sua storia apprende e consolida i comportamenti aggressivi nella misura in cui le conseguenze prodotte da tali condotte creano dei vantaggi. Quindi, laddove le conseguenze positive sono di gran lunga maggiori rispetto a quelle negative l’aggressività tende a rinforzarsi e a consolidarsi.
Secondo l’ottica cognitivista il comportamento aggressivo si attiva ogni volta che l’individuo attribuisce determinati significati alle situazioni che vive. Tale significazione è frutto dei processi di apprendimento che si sono verificati nel corso del ciclo di vita e che concorrono a costituire la sua mappa cognitiva. Questa processualità di conoscenza può avvenire direttamente o indirettamente attraverso l’osservazione del comportamento di modelli di riferimento (apprendimento sociale).
Un’altra concettualizzazione proposta nell’ambito della genesi dell’aggressività è la teoria dell’obbedienza (Patrizi e De Gregorio, 2009). In pratica, un individuo si comporta in maniera aggressiva e violenta, allorquando subisce l’influenza di una persona particolarmente aggressiva, a cui attribuisce alcune peculiarità, come il carisma, l’autorevolezza e la superiorità sociale.
Complementare a questo costrutto è la teoria della deindividuazione. In questo caso più che una singola persona è un intero gruppo sociale, a cui l’individuo appartiene, che esercita una forma di influenza negativa. È l’appartenenza al gruppo che determina la deindividuazione, la quale consente al singolo di allentare l’autocontrollo, che altrimenti avrebbe esercitato se fosse stato da solo.
Per un certo lasso di tempo nella genesi dell’aggressività si è dato un peso rilevante alle caratteristiche innate che, dal punto di vista temperamentale, stigmatizzano l’individuo, predisponendolo a condotte violente. A questo riguardo Lombroso, alla fine dell Ottocento, vedeva in alcune peculiarità somatiche dell’individuo la predisposizione ai comportamenti delinquenziali, connotati dall’aggressività e dalla violenza nei confronti dell’alterità.
Secondo le sue teorizzazioni esiste una personalità delinquenziale facilmente riconoscibile da alcune fattezze del capo quali:
un cranio di dimensioni inferiori rispetto a quelle osservabili nella maggior parte degli individui;
– gli zigomi sporgenti;
– una fronte poco pronunciata;
– le sopracciglia molto folte e particolarmente evidenti;
– delle deformità a carico del naso;
– il labbro superiore quasi inesistente;
– le orecchie particolarmente sviluppate e a sventola;
– una massa di capelli ricci e informi;
– la barba rada o completamente inesistente nei soggetti di sesso maschile (Gibson, 2004).
La fenomenologia dei comportamenti aggressivi
I comportamenti aggressivi possono essere suddivisi, dal punto di vista fenomenologico, in diverse tipologie (Attanasio, 2012):
1. l’aggressività attiva che si verifica allorquando un individuo cerca di far del male ad un suo simile, utilizzando la forza;
2. l’aggressività passiva che si esplicita nel non prestare soccorso a chi si trova in uno stato di bisogno;
3. l’aggressività diretta nella quale una persona arreca danno ad un’altra, utilizzando una modalità mirata, che si concretizza nell’utilizzazione del proprio corpo per cagionare sofferenza;
4. l’aggressività indiretta che si realizza nel momento in cui si mettono in giro delle calunnie gratuite sul conto di un altro individuo;
5. l’aggressività autodiretta nella quale si provoca disagio a se stessi;
6. l’aggressività eterodiretta in cui l’oggetto della violenza diviene l’alterità;
7. l’aggressività reattiva che è provocata dall’aver subito un torto ed è alimentata dal desiderio di vendetta (Price e Dodge, citati in Berti e Bombi, 2005);
8. l’aggressività proattiva nella quale la violenza fisica o psicologica viene pianificata ed obbedisce ad una specifica strategia di distruzione dell’altro (Price e Dodge, op. cit.).
I meccanismi di implementazione delle condotte aggressive
I meccanismi di implementazione sono rappresentati da quelle procedure che incrementano la fenomenologia dell’aggressività negli individui. A questo riguardo si possono citare le distorsioni cognitive che hanno come focus concettuale centrale l’idea che i conflitti interpersonali possano essere risolti e vinti da chi mostra maggiore aggressività.
Un altro elemento che potenzia le manifestazioni aggressive è la suscettibilità neurofisiologica individuale. In altre parole, ci sono alcuni individui che accedono più facilmente a comportamenti aggressivi di maggiore intensità, per fattori neurofisiologici connaturati alla loro persona. In tale direzione vanno le ricerche di Bruner, citate in Gargione (2000), che hanno ipotizzato che l’incremento dell’aggressività può essere messo in relazione con modificazioni del cromosoma X, che alterano la formazione di alcuni neurotrasmettitori, come la dopamina e la serotonina.
Nell’espressione delle condotte aggressive, in ambito neurofisiologico, l’amigdala riveste un ruolo determinante. Essa è una struttura anatomica del sistema nervoso centrale, nello specifico del sistema limbico, che presiede alla regolazione delle condotte di rabbia, paura e ansia. La serotonina, inoltre, sembra esercitare un ruolo di contenimento dell’aggressività. Infatti, persone che presentano delle quantità esigue di serotonina manifestano un incremento delle condotte aggressive e antisociali .
Dal punto di vista ormonale il testosterone occupa una posizione preminente: infatti è in grado di incrementare la cosiddetta aggressività offensiva. A tal proposito alti livelli di testosterone conducono ad un incremento delle condotte aggressive nei confronti dell’altro.
Ci sono inoltre delle variabili situazionali che presumibilmente implementano l’aggressività. Si suppone che il caldo eccessivo, un’umidità particolarmente alta, un ambiente caratterizzato da un inquinamento atmosferico estremamente accentuato, con odori e rumori essenzialmente sgradevoli determinino un aumento dei comportamenti aggressivi (Aronson, Wilson e Akert, 2010).
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Vincere… Scatena l’aggressività
BIBLIOGRAFIA:



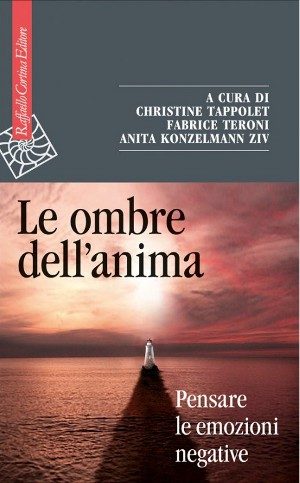 La risposta a questa e altre domande inerenti le emozioni complesse, ambivalenti, miste si può trovare in questa bella raccolta di saggi scritti da filosofi di area francofona (Francia, Canada, Svizzera), che vanno ad indagare quei territori emotivi solitamente non molto battuti dai manuali di psicologia e psicoterapia (in particolare cognitiva).
La risposta a questa e altre domande inerenti le emozioni complesse, ambivalenti, miste si può trovare in questa bella raccolta di saggi scritti da filosofi di area francofona (Francia, Canada, Svizzera), che vanno ad indagare quei territori emotivi solitamente non molto battuti dai manuali di psicologia e psicoterapia (in particolare cognitiva).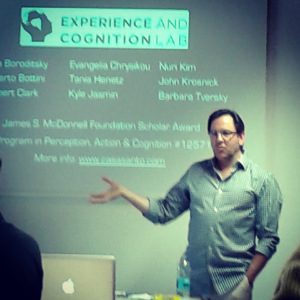
 In conclusione Casasanto afferma che pensare attraverso metafore è una capacità che abbiamo acquisito grazie all’evoluzione, cooptando vecchie espressioni legate al concreto, adattandole a concetti astratti.
In conclusione Casasanto afferma che pensare attraverso metafore è una capacità che abbiamo acquisito grazie all’evoluzione, cooptando vecchie espressioni legate al concreto, adattandole a concetti astratti.