La complessità dei percorsi traumatici nei rifugiati – Report dal seminario
Report dal seminario
“Mio fratello che guardi il mare…”
Complessità dei percorsi traumatici nei richiedenti asilo:
dalle torture al trauma della fuga e dell’esilio e al trauma sociale nel contesto d’arrivo
Milano, Sabato 21 Giugno 2014
Il tema dei rifugiati e richiedenti asilo sopravvissuti a tortura è di assoluta attualità e pone difficoltà e sfide peculiari per operatori, psicologi, psichiatri e in generale per tutte le figure che a vario titolo sono chiamate ad occuparsi di situazioni così al limite. E’ necessario fornire ai professionisti del settore strumenti adeguati per far fronte alle specifiche vulnerabilità create da violenze e torture subite nel paese d’origine, durante il viaggio e dal trauma migratorio.
L’incontro con la sofferenza di pazienti che provengono da storie costellate di traumi precoci, estremi e continuativi è una grande sfida per i clinici di ogni orientamento e negli ultimi anni molto spazio è stato dato alle specifiche difficoltà che queste persone portano in terapia sia dal punto di vista diagnostico sia dal punto di vista squisitamente terapeutico.
Rispondendo alla crescente urgenza di risposte a tale proposito il Servizio di Diagnosi e Terapia del Trauma Psicologico dello studio A.R.P. di Milano organizza un ciclo di incontri clinici “anti-impotenza”, volti a individuare, nel confronto con esperti che operano in vari campi della psicotraumatologia, soluzioni che permettano di orientarsi e definire via di cura per quadri psicopatologici complessi.
Quello di sabato 21 Giugno con Massimo Germani, in continuità con la giornata mondiale del rifugiato celebrata il giorno precedente, è stato il seminario inaugurale di questo ciclo di incontri.
Il tema dei rifugiati e richiedenti asilo sopravvissuti a tortura è di assoluta attualità e pone difficoltà e sfide peculiari per operatori, psicologi, psichiatri e in generale per tutte le figure che a vario titolo sono chiamate ad occuparsi di situazioni così al limite. E’ necessario fornire ai professionisti del settore strumenti adeguati per far fronte alle specifiche vulnerabilità create da violenze e torture subite nel paese d’origine, durante il viaggio e dal trauma migratorio.
Nella prima parte del suo interessantissimo intervento Massimo Germani delinea gli elementi che costituiscono la tortura, i fattori caratterizzanti i vari tipi di tortura e le proporzioni impressionanti del fenomeno a livello mondiale: la tortura è attualmente praticata da 102 Paesi, Italia compresa; tra il 20% e il 25% dei richiedenti asilo ha subito torture e in Europa attualmente vivono circa 600.000 di rifugiati sopravvissuti a torture, di cui solo 30.000 hanno potuto avvalersi di cure specialistiche adeguate.
Sono dati allarmanti.
Sappiamo che l’essere esposti a traumi complessi, estremi e cumulativi è un fattore di rischio importante per lo sviluppo di psicopatologia. In questo senso tutti i richiedenti asilo sono potenzialmente vulnerabili, ma certamente ci sono categorie che diventano effettivamente vulnerabili (anziani, disabili, donne in gravidanza, minori) o altamente vulnerabili (vittime di tortura, stupro, traumi estremi) che devono essere identificati per poter fornire loro cure adeguate. In quest’ultimo gruppo di persone, infatti, la presenza di psicopatologia è quasi costante, anche se a volte latente, e tende a peggiorare e cronicizzarsi se non trattata, rendendo difficile il processo integrativo nel nuovo contesto e il percorso verso l’autonomia, con costi umani, sociali ed economici enormi.
All’interno di questa categoria, inoltre, c’è un sottogruppo definito ad alto rischio che comprende persone sopravvissute a torture, stupro e violenza estrema con pre-esistenti disturbi psichici latenti o conclamati. In questa categoria si ritrovano quadri di psicopatologia conclamata anche severa, rapida progressione in senso peggiorativo del quadro clinico e impossibilità (non solo difficoltà) del processo integrativo e del percorso verso l’autonomia.
Aspetto di cardinale importanza è la necessità di considerare i fattori che concorrono a determinare la gravità del quadro clinico lungo un arco temporale: fattori pre-traumatici, peri-traumatici e post-traumatici. E’ fondamentale che operatori e pazienti abbiano la consapevolezza che c’è un prima e un dopo e che tutto quello che succede in questi momenti è rilevante per l’esito psicopatologico.
Riconoscere precocemente i segnali che indicano la presenza di fattori di rischio è di cruciale importanza per una presa in carico adeguata che consenta l’integrazione nel nuovo contesto e l’uscita verso una nuova autonomia. Per rispondere a questa esigenza Massimo Germani presenta l’E.T.S.I. “Extreme Trauma and Torture Survivors Identification Interview”, strumento messo a punto dal suo gruppo per facilitare, nei CARA o nei centri di prima accoglienza, l’individuazione di situazioni di vari gradi di vulnerabilità al fine di indirizzare le persone a rischio nei centri specialistici. Non è uno strumento di diagnosi, ma di screening, che si è rivelato affidabile per un’accurata identificazione precoce anche da parte di clinici non specialisti.
Altro elemento cruciale sottolineato da Massimo Germani è che il trauma non è sempre patogeno. Il trauma è un’esperienza che dipende dall’incontro tra evento oggettivo e vissuto soggettivo, tra fattori di rischio e fattori di protezione. Non è l’esito di una causalità lineare, ma di una multifattorialità complessa.
Il tipo di trauma è certamente un elemento sostanziale: circa il 20-30% di traumi singoli/non interpersonali e il 33-75% di traumi ripetuti, continuativi e interpersonali evolvono fino a quadri psicopatologici conclamati.
L’esperienza traumatica, tuttavia, è una condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo di una patologia post-traumatica. E’ necessario un modello patogenetico complesso delle patologie post-traumatiche basato su un processo di causalità reciproca, che ristabilisca la centralità dell’individuo e del contesto di cui egli è partecipe, inteso anche come contesto di arrivo. La vulnerabilità al trauma non è una qualità statica e acquisita una volta per tutte, ma varia nello stesso individuo in funzione del tempo e delle circostanze ambientali e personali.
La terza parte dell’intervento si focalizza sulla definizione di Disturbo Post-Traumatico Complesso, distinguendolo dal PTSD semplice. I traumi estremi, interpersonali e continuativi hanno un impatto particolarmente dirompente, frammentante e annichilente e provocano alterazioni profonde delle funzioni associative della psiche.
Di fronte ad esperienze così estreme le normali difese della persona non sono più in grado di funzionare ed entrano in gioco difese primitive, dissociative. I frammenti inelaborabili del trauma restano confinati all’interno di una o più parti di personalità che acquista caratteristiche dissociative. Le parti dissociative sono psichicamente attive, se pure frammentate e tendono a riapparire automaticamente in situazioni stressanti, condizionando pesantemente il funzionamento dell’Io che si impoverisce.
Oltre a ciò il Disturbo Post-Traumatico Complesso è caratterizzato da alterazioni nell’identità e nelle relazioni, sintomi cognitivi e alterazioni della memoria, sintomi depressivi e alterazioni della sfera affettiva, sintomi da iper o ipo-arousal, sintomi ansiosi e sintomi somatici. La dissociazione, tuttavia, è il nucleo centrale e specifico della traumatizzazione e tende ad aggravarsi con la sequenzialità dei traumi, come dimostra anche una ricerca su rifugiati del Camerun e del Ciad presentata da Germani.
Questa ricerca mette in evidenza anche l’importanza del periodo post-traumatico che inizia con la fuga dal paese d’origine, non solo in termini di traumatizzazione secondaria così frequente durate la fuga ma anche intesa come situazioni e contesti destabilizzanti nei paesi di arrivo.
La specificità dei rifugiati sopravvissuti a tortura deve essere considerata nel momento in cui si delineano progetti di accoglienza e trattamento. Oltre a presentare quadri sindromici connessi a traumi estremi, infatti, queste persone devono fare i conti con la precarietà e la marginalità sociale, il deserto affettivo, l’eclissi del senso d’identità e l’incertezza assoluta riguardo al futuro che caratterizza la loro condizione di profughi.
Il trattamento deve essere individualizzato in base alle caratteristiche del paziente, alla situazione psicopatologica di base e attuale, alle condizioni sociali attuali, ai sintomi emergenti e al grado di rischio.
Quanto emerso da questa intensa giornata rende evidente come la presa in carico di questi pazienti debba essere integrata, comprendente assistenza medica, psicologica, sociale e legale, e debba fornire una forte componente di supporto e protezione per ridare loro una dignità di vita, tenendo conto delle risorse e capacità disponibili.
Il lavoro deve essere centrato sulla persona e non sul trauma, per evitare ulteriori traumatizzazioni e grande attenzione deve essere dedicata alle prime fasi di alleanza terapeutica e stabilizzazione, basilari e molto delicate in questo tipo di pazienti.
A fare da esemplificazione ci ha accompagnati, nel corso della giornata, un caso clinico presentato dal Servizio di Etnopsichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano, che bene ha mostrato le difficoltà di diagnosi, i nodi critici, la delicata scelta del trattamento e la sinergia dell’operato delle molteplici figure professionali coinvolte nella presa in carico del paziente.
La giornata si è conclusa con la proiezione di un bel video sul Laboratorio Teatrale del Progetto Vi.To. del Consiglio Italiano per i Rifugiati, che si occupa di accoglienza e cura delle vittime di tortura e tiene incontri presso un barcone ormeggiato sul Tevere, in cui si dà voce e spazio alla condivisione e all’elaborazione (implicita: è teatro, non teatro-terapia) delle difficili esperienze vissute dai rifugiati attraverso l’esperienza teatrale.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Nuove frontiere nelle cura del trauma – Report dal congresso di Venezia



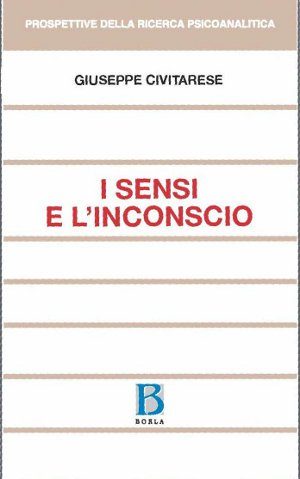 Nel suo percorso di rinnovamento della psicoanalisi, fortemente radicato nelle teorie post-bioniane e particolarmente nel modello del campo intersoggettivo, l’Autore sceglie di occuparsi di un concetto centrale della nostra disciplina, l’inconscio, così a lungo dibattuto e ridefinito da risultare a volte indefinito e sfuggente, quasi diluito nella sua pregnanza.
Nel suo percorso di rinnovamento della psicoanalisi, fortemente radicato nelle teorie post-bioniane e particolarmente nel modello del campo intersoggettivo, l’Autore sceglie di occuparsi di un concetto centrale della nostra disciplina, l’inconscio, così a lungo dibattuto e ridefinito da risultare a volte indefinito e sfuggente, quasi diluito nella sua pregnanza.