Patologizzare è gergalizzare – LGBT
Daniel De Lucia
Patologizzare è gergalizzare
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Il gergo queer nell’italiano novecentesco e contemporaneo – Sociolinguistica – LBGT
Daniel De Lucia
Patologizzare è gergalizzare
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Il gergo queer nell’italiano novecentesco e contemporaneo – Sociolinguistica – LBGT
Secondo i due autori (1966) l’intelligenza fluida rappresenta la capacità biologica di base dell’apprendimento (inclusa la capacità di acquisire nuove abilità) e l’intelligenza cristallizzata si riferisce invece ai prodotti dell’istruzione o della conoscenza acquisita (Kausler, 1991; Gardner & Clark, 1992).
Prove a sostegno di questa suddivisione provengono da studi trasversali in cui sono stati utilizzati i tradizionali test d’intelligenza (LaRue, 1992; Lindenberger & Baltes, 1997), come le scale Wechsler, costituite da più prove. In particolare subtest come Completamento di Figure, Riordinamento di Storie Figurate, Disegno con i Cubi, Ricostruzione di Figure ed Associazione di Simboli a Numeri misurano le abilità fluide; mentre Informazione, Vocabolario, Analogie e Comprensione sono considerate misure delle abilità cristallizzate (Kausler, 1991; LaRue, 1992).
I subtest per le capacità fluide premiano la velocità di risposta corretta e i test che danno maggior enfasi alla correttezza delle risposte, valutano le capacità cristallizzate.
Altri studi longitudinali (ad esempio: Schaie & Strother, 1968; Schaie & Hertzog, 1986), invece, hanno criticato in parte la veridicità di tale teoria, evidenziando come alcune capacità fluide rimangano stabili nella giovinezza, in alcuni casi anche fino ai 50 anni per poi diminuire in età molto avanzata (Schaie & Willis, 1991). Ulteriori ricerche hanno dimostrato, inoltre, che anche nella vecchiaia potrebbe esistere un declino delle capacità cristallizzate (ad esempio: Giambra et al., 1995; Bäckman & Nilsson, 1996).
L’effetto coorte è stato confermato anche da altri studi (ad esempio: Schaie & Willis, 1991; Nilsson et al., 1997) e sembra essere particolarmente influente in condizioni di studi di ricerca trasversali, poiché confrontando soggetti di età diversa e appartenenti quindi a coorti differenti, risulta difficile stabilire quanto le differenze riscontrate siano dovute all’età e quanto invece alle mutate condizioni storiche, sociali ed educative in cui sono cresciuti gli individui. L’esistenza dell’effetto coorte è a favore di una maggiore cautela nel trarre conclusioni da studi trasversali dai quali emerge un declino nelle abilità fluide nella prima età adulta.
Dal momento che il declino, presente in particolare dopo i 60 anni, è fortemente legato ad una ridotta capacità di apprendimento, l’insegnamento di nuove abilità cognitive potrebbe essere inutile.
Il calo della capacità di apprendimento non può essere attribuito unicamente ad un rallentamento nell’elaborazione, infatti in letteratura sono presenti evidenze a favore del fatto che un maggior tempo di studio per gli anziani non garantisce un livello di prestazione simile ai giovani (LaRue, 1992). Esistono, però, studi in cui è stato dimostrato un miglioramento nelle capacità fluide dopo un training (ad esempio: Plemons, Willis & Baltes, 1978; Willis, Blieszner & Baltes, 1981); tuttavia è spesso difficile valutare cosa provochi un miglioramento nella prestazione: una strategia per mettere in atto l’abilità, un aumento di motivazione o un effettivo perfezionamento della capacità stessa.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
BIBLIOGRAFIA:
Morena Peggi
Negli ultimi anni si è assistito ad un invecchiamento progressivo della popolazione correlato ad un aumento delle malattie neurodegenerative. La Stimolazione Cognitiva si configura come un intervento finalizzato al benessere complessivo della persona in modo da incrementarne il coinvolgimento in compiti finalizzati alla riattivazione delle competenze residue e al rallentamento della perdita funzionale causata dalla patologia dementigena.
Negli ultimi cinquant’anni si è assistito ad un significativo incremento demografico della popolazione mondiale e con esso ad un incremento dell’età media e della popolazione anziana. In Italia, il numero di anziani di età compresa tra i 65 e i 74 anni è otto volte maggiore rispetto all’inizio del secolo scorso, mentre gli anziani di età superiore agli 85 anni sono aumentati di oltre 24 volte.
Proprio a causa di questa maggiore longevità sono aumentate alcune patologie come quelle cardiovascolari, quelle metaboliche e soprattutto le malattie neurodegenerative come la Demenza. Il tutto conduce ad aumento indiscusso anche della popolazione anziana malata e non autosufficiente, in sostanza ad un vero e proprio allarme socio- sanitario.
La Demenza è considerata una sindrome che provoca un decadimento cognitivo (memoria, linguaggio, orientamento spazio temporale,attenzione e programmazione) e una compromissione della persona in molti campi come quello della vita quotidiana, delle relazioni sociali e familiari, del comportamento e della personalità.
Recenti scoperte da parte delle neuroscienze e della neurobiologia hanno tuttavia sottolineato come nel cervello esista una sorta di plasticità per cui l’apprendimento di una determinata attività si associa a modificazioni delle aree corticali coinvolte in quell’apprendimento.
Ciò significa che vi è la possibilità di ricompensare quelli che sono determinati deficit in alcune aree cerebrali compromesse attraverso una ri-organizzazzione dell’area coinvolta. Il tutto avverrebbe attraverso un aumento delle dimensioni dei neuroni, un maggior numero di contatti sinaptici e un maggior numero di ramificazioni dendritiche ed è di tutta evidenza come, delle stimolazioni specifiche e mirate possano contribuire all’attivazione di determinate connessioni.
Questo effetto neuroprotettivo delle strutture del cervello elicita un vero e proprio processo di accumulazione, una riserva se così si può definire, strutturale e funzionale, grazie al quale le strutture cerebrali superiori riescono a lavorare adeguatamente nonostante il progredire dell’azione nociva neurodegenerativa correlata all’invecchiamento patologico o fisiologico.
Tra gli interventi proposti le stimolazioni cognitive regolari e protratte nel tempo, facendo leva sul processo di neuroplasticità, rinforzerebbero le capacità cognitive residue e compenserebbero quelle meno attive perchè poco utilizzate o perchè fisiologicamente deteriorate. A ciò si aggiunge che, come effetto secondario, potenziare l’efficienza cognitiva potrebbe condurre anche a miglioramenti significativi dell’umore e della motivazione individuale.
Che cosa si intende quando si parla di stimolazione cognitiva? Possiamo definirlo come un intervento specifico per ogni singolo soggetto che utilizza tecniche ed interventi mirati e differenziati con l’obiettivo di massimizzare le funzioni residue dell’individuo con l’utilizzo di tutte le risorse interne ed esterne disponibili per mantenere il più possibile l’autonomia individuale.
Tra gli interventi possibili si collocano la ROT o Terapia di ri-orientamento nella realtà finalizzata a modificare i comportamenti scorretti, ridurre l’isolamento del soggetto e rinforzare le informazioni del paziente rispetto alla propria identità, al contesto e alla propria storia.
Il Metodo Validation, ad impronta psicoanalitica che punta l’attenzione sull’affettività del soggetto: la verbalizzazione e condivisione dei propri sentimenti in un ambiente contenuto quale il gruppo di terapia, favorisce l’interazione e incentiva la comunicazione verbale e offre ai pazienti l’occasione per sentirsi riconosciuti, per sperimentarsi in un ruolo sociale e per aumentare la consapevolezza di sè e delle proprie storie personali.
Accanto a questi interventi si inserisce un terzo programma di Stimolazione Cognitiva definito Our Time; il suo focus è diretto alla persona piuttosto che alla patologia, la scelta delle attività sono adeguate alle persone o al gruppo, incentiva il gioco e il divertimento delle attività presentate, utilizza la reminescenza dell’anziano e la stimolazione multisensoriale, inoltre pone in relazione tutte le persone all’interno del gruppo.
Nell’ambito della riabilitazione funzionale rientra invece la Terapia Occupazionale o Ergoterapia, finalizzata al recupero delle competenze cognitive, funzionali e sociali, attraverso l’inserimento in attivita ludiche, ricreative, lavorative, artistiche e domestiche che
siano anche socializzanti.
Per quanto riguarda gli interventi specifici vi sono una serie di interventi mirati a stimolare la Memoria Esplicita come lo Space Retrivial che consiste nella rievocazione di informazioni ad intervalli di tempo crescenti, l’Errorrless Learning (modalità di apprendimento senza errori), il Vanishing Cues o suggerimenti decrescenti.
In definitiva la Stimolazione Cognitiva si configura come un intervento finalizzato al benessere complessivo della persona in modo da incrementarne il coinvolgimento in compiti orientati alla riattivazione delle competenze residue e al rallentamento della perdita funzionale causata dalla patologia dementigena.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Demenza, Alzheimer e Stimolazione Cognitiva: Use it or Lose it
BIBLIOGRAFIA:
Ma psicologi e neuroscienziati dicono che è troppo presto considerare la scrittura a mano al pari di una reliquia del passato. Nuovi studi suggeriscono infatti un legame profondo tra scrittura a mano e un più ampio sviluppo educativo.
Sembra infatti che i bambini imparino non solo a leggere più velocemente una volta che imparano a scrivere a mano, ma anche che siano più capaci di generare idee e conservare le informazioni. In altre parole, non è solo quello che scriviamo che conta, ma come lo facciamo.
Karin James, psicologa all’Indiana University, ha utilizzato uno scanner per vedere come la scrittura a mano influenzi l’attività cerebrale dei bambini. La ricercatrice ha mostrato a bambini, che non avevano ancora imparato a leggere e scrivere, una lettera o una forma e gli ha chiesto di riprodurla in uno di questi modi: tracciare l’immagine su una pagina in cui era riprodotta con un contorno tratteggiato, disegnarla su un foglio bianco, oppure digitarla su un computer. Poi, mentre erano sottoposti a scanner cerebrale, gli veniva riproposta l’immagine.
I ricercatori hanno scoperto che il tipo di processo di duplicazione iniziale contava molto. Quando i bambini avevano disegnato una lettera a mano libera, esibivano una maggiore attività nelle tre aree del cervello che si attivano negli adulti quando leggono e scrivono: il giro fusiforme sinistro, il giro frontale inferiore e la corteccia parietale posteriore.
Al contrario, i bambini che avevano digitato o tracciato la lettera o la forma non hanno mostrato alcun effetto del genere e l’attivazione era significativamente più debole.
La dott.ssa James attribuisce queste differenze al disordine insito nella forma libera scrittura: quando scriviamo a mano libera non solo dobbiamo pianificare ed eseguire l’azione in un modo che non è richiesto quando abbiamo un contorno da tracciare, ma siamo anche in grado di produrre un risultato che è altamente variabile. E tale variabilità può essere di per sé uno strumento di apprendimento: quando un bambino produce una lettera disordinata, proprio questa può aiutarlo a imparare.
Il nostro cervello deve capire che ogni possibile variazione nella scrittura di una certa lettera rappresenta comunque la stessa, non importa come la vediamo scritta. Essere in grado di decifrare la variabilità di ogni lettera è più utile a costruirne una rappresentazione che vedere lo stesso identico segno ripetutamente.
In un altro studio, la dott.ssa James ha messo a confronto bambini che scrivono fisicamente lettere con coloro che guardano solo gli altri farlo. Le sue osservazioni suggeriscono che è solo lo sforzo effettivo che impegna vie motorie del cervello e offre i vantaggi di apprendimento della scrittura.
L’effetto però va ben oltre il riconoscimento di una lettera. In uno studio condotto su bambini, Virginia Berninger, psicologa presso l’Università di Washington, ha dimostrato che scrivere in stampatello, scrivere in corsivo, e digitare su una tastiera sono modalità associate con schemi cerebrali distinti e separati – e ognuno si traduce in un prodotto finale diverso. Quando i bambini scrivono a mano libera, non solo producono più parole e più rapidamente di quanto facciano su una tastiera, ma esprimono anche più idee. Inoltre quando gli è stato chiesto di trovare idee per sviluppare un tema, quelli con una migliore grafia hanno anche mostrato maggiore attivazione neurale nelle aree associate con la memoria di lavoro e un aumento di attivazione globale nelle reti di lettura e scrittura.
Inoltre, in alcune situazioni, la differenza tra lo stampatello e il corsivo è di grande importanza: nella disgrafia, per esempio, in alcune persone, la scrittura in corsivo rimane relativamente intatta, mentre in altri lo è quella in stampatello.
Nell’alessia, difficoltà nella lettura di parole scritte, alcuni individui che non sono in grado di scrivere in stampatello possono ancora leggere il corsivo, e viceversa; questo suggerisce che le due modalità di scrittura attivano reti del cervello separate e impegnano più risorse cognitive di quanto farebbero se il canale fosse unico.
La dott.ssa Berninger si spinge fino a suggerire che la scrittura corsiva può allenare la capacità di autocontrollo in un modo che altre modalità di scrittura non fanno, e alcuni ricercatori sostengono che potrebbe anche essere uno strumento per trattare la dislessia. Una revisione del 2012 suggerisce che il corsivo può essere particolarmente efficace per le persone disgrafiche e che può aiutare a prevenire l’inversione di lettere.
Corsivo o no, i benefici della scrittura a mano si estendono oltre l’infanzia. Per gli adulti, digitare può essere una alternativa al corsivo rapida ed efficace, ma ma tanta efficenza può diminuire la nostra capacità di elaborare nuove informazioni.
Due psicologi, Pam A. Mueller di Princeton e Daniel M. Oppenheimer della University of California, Los Angeles, hanno riferito che sia nella condizione di laboratorio che in classe, gli studenti imparano meglio quando prendono appunti a mano rispetto a quando digitano su una tastiera. Contrariamente a studi precedenti che attribuiscono la differenza agli effetti di distrazione dei computer, questa nuova ricerca suggerisce che la scrittura a mano permetta allo studente di elaborare i contenuti e riformularli: un processo di riflessione e di manipolazione che può portare a una migliore comprensione e codifica in memoria.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
BIBLIOGRAFIA:
CONSIGLIATO DALLA REDAZIONE:

Le nostre idee sulla mente e sul pensiero possono influenzare la prospettiva con cui guardiamo il mondo e conseguentemente il modo in cui ci sentiamo rispetto al rapporto con gli altri e con noi stessi. Queste idee sono le cosiddette metacognizioni. Diversi studi stanno mostrando quanto intervenire sul modo in cui le persone pensano e sulle loro metacognizioni possa favorire la riduzione di sintomi ansiosi e depressivi e forse anche sintomi psicotici.
Both perceived stress and negative recurrent thinking (rumination and worry) have been associated with depressive symptoms. However, no research to date has investigated the association between perceived stress and negative recurrent thinking. In the present study we aimed to explore whether perceived stress and negative recurrent thinking are associated and whether negative recurrent thinking moderates the relationship between perceived stress and depressive symptoms. A convenience sample of 273 undergraduate students completed the Perceived Stress Scale, the Ruminative Responses Scale-10, the Penn State Worry Questionnaire and the Hospital Anxiety and Depression Scale 2 weeks prior to sitting mid-year examinations. Correlation analyses showed that perceived stress, rumination and worry were positively and significantly associated with depressive symptoms and that perceived stress was positively and significantly associated with rumination and worry. A moderation analysis confirmed that negative recurrent thinking moderated the relationship between perceived stress and depressive symptoms. The implications of these findings are discussed.
VAI ALL’ARTICOLO: Negative Recurrent Thinking as a Moderator of the Relationship Between Perceived Stress and Depressive Symptoms – Online First – Springer.






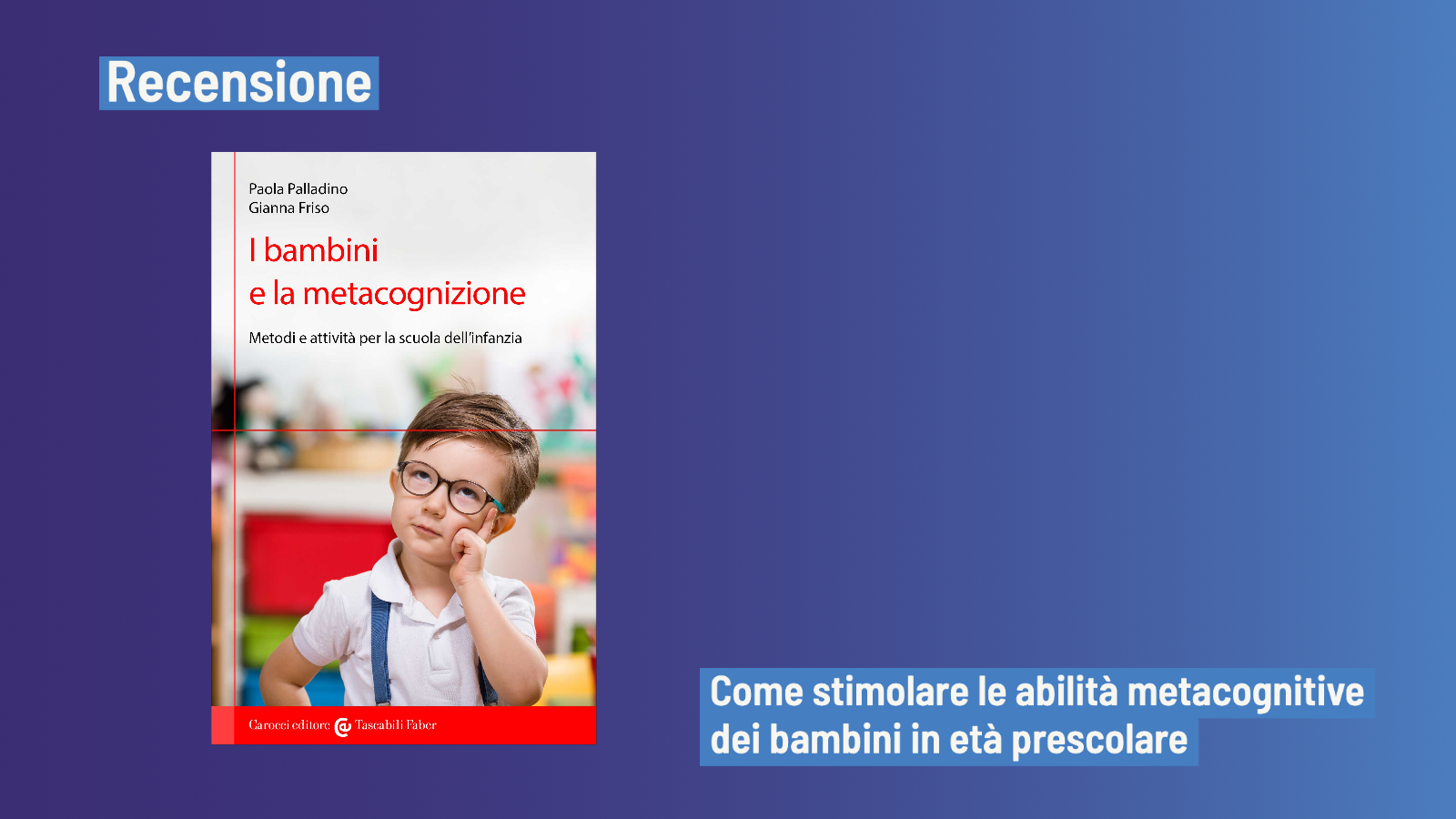
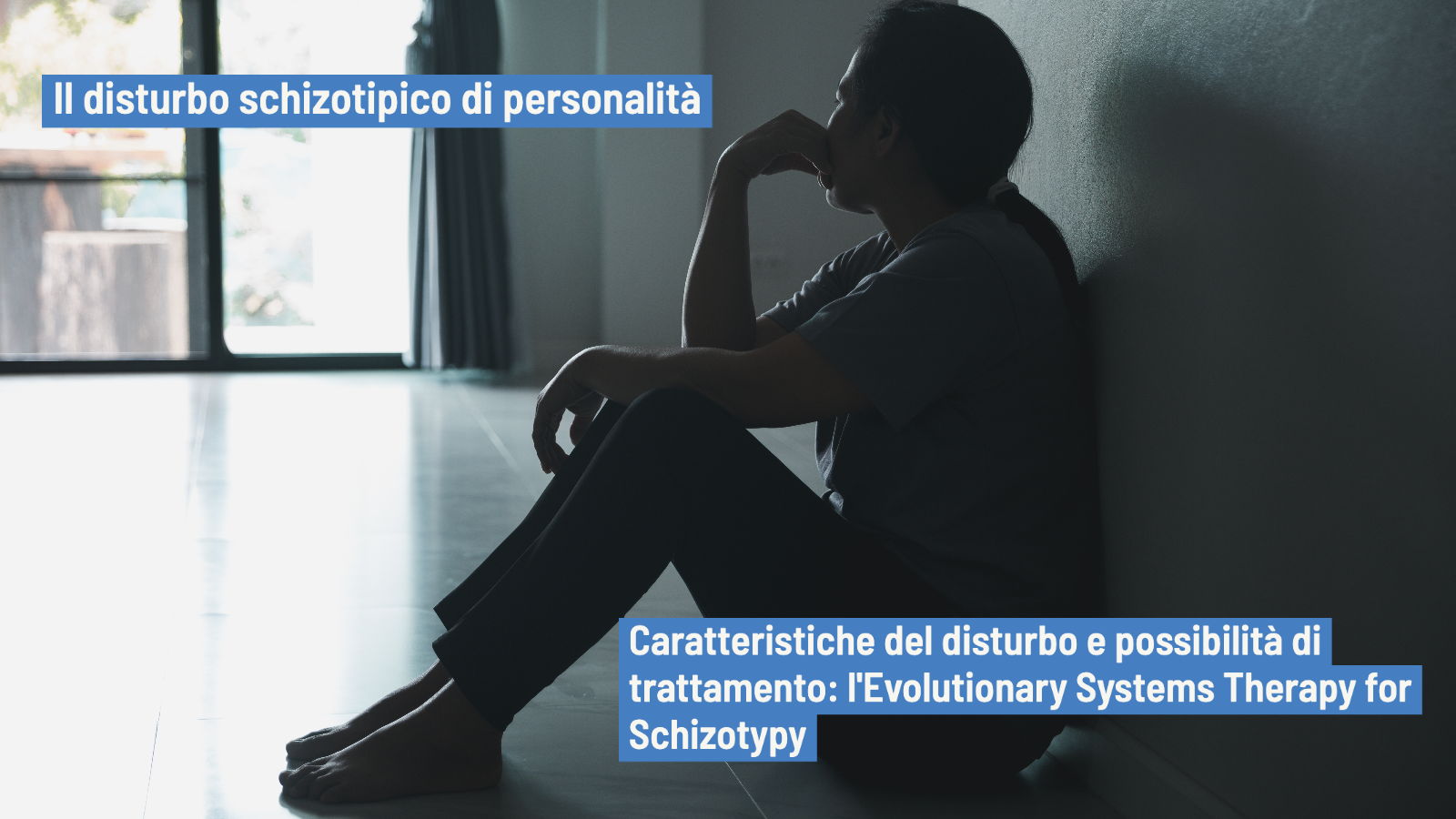












Il dubbio è un’esperienza universalmente mal sopportata. È curiosa l’esperienza del dubbio, una voce nella mente che ricorda che altri scenari sono possibili. Genera fastidio ed è considerata il cuore di alcuni disturbi psicologici.
Per esempio il disturbo ossessivo-compulsivo o il disturbo d’ansia generalizzata sono fondati, tra le altre cose, sull’intolleranza dell’incertezza (Dugas et al., 1998), definita come la difficoltà di accettare il fatto che sia completamente impossibile prevenire l’accadimento di un evento negativo, per quanto poco probabile.
Anche la società non veste il dubbio con abiti pregiati, tutt’altro. Il dubbio è sintomo di insicurezza, fragilità, anche un po’ scarso valore. Colui che vince è colui che convince, e convince se prima di tutto è convinto delle proprie idee, vale a dire: privo di dubbi.
Tempo ed energie sono consumati per togliersi ogni dubbio dalla mente. A tale scopo le persone cercano rassicurazioni o provano ad autoconvincersi con la forza di pensieri positivi. Si tratta di tentativi spesso fallimentari ed esposti a un paradosso: cercare residui dubbi nella mente da eliminare non può che condurre a trovarne di nuovi. Il dubbio è un’Idra di Lerna, ogni tentativo di eliminare una testa porta a farne crescere altre due.
Si dice che il dubbio è qualcosa che si insinua o viene insinuato, infilato per crescere e far germogliare malessere, avversione, conflitto. Il dubbio è quindi anche una serpe, o un seme velenoso capace di bruciare tutto il raccolto. E un’esperienza se così pericolosa merita attenzione.
Ci sono tre considerazioni che mi hanno incuriosito sul dubbio.
Il primo: come mai la nostra mente si è evoluta per produrre dubbi?
Una possibile risposta è che il dubbio sia una proprietà emergente dell’essere dotati di coscienza. Chissà, forse un difetto di fabbrica, oppure una componente fondamentale della nostra scalata alla vetta della piramide alimentare. In un mondo di scelte la presenza di una coscienza dotata dell’esperienza del dubbio permette di costruire scenari alternativi, di moltiplicare le possibili scelte oltre quelle determinate da temperamento (genetica) e da educazione (apprendimento). D’altronde abbiamo facoltà di scegliere se seguire un dubbio o meno. Più dubbi abbiamo, più aumentano le scelte, più il nostro moto è fluido, con maggiori gradi di libertà. Lo scorrere fluido meglio si adatta ad attraversare i mutamenti dell’ambiente. Questo perché offre molteplici occasioni di flessibilità e di modulazione della prudenza, del controllo e dell’impulsività.
Da qui ne deriva un’interessante prospettiva: chi non presta mai alcuna attenzione ai propri dubbi potrebbe irrigidirsi e seguire una traiettoria molto netta, senza rendersene conto.
Il secondo punto: quando il dubbio diventa un problema?
Qui da psicologo clinico e psicoterapeuta mi sento più a mio agio. La letteratura scientifica cognitiva ci offre un paio di appigli in questo senso. Innanzitutto il dubbio produce malessere quando viene considerato pericoloso e viene considerato pericoloso quando è mal-interpretato (Myers et al., 2009). Piuttosto che un impulso neurochimico che assume la forma di una rappresentazione ipotetica, viene considerato un plausibile se non probabile dato di realtà (es. se lo penso devo fare qualcosa altrimenti accadrà) o dato capace di influenzare la realtà (es. i dubbi sono l’anticamera di un fallimento scritto). Si parla in questo senso di fusione del pensiero. L’individuo osserva il mondo attraverso i propri dubbi e preoccupazioni considerandoli come indici affidabili di ciò che potrebbe accadere, piuttosto che ipotesi.
Ma quante volte abbiamo avuto un pensiero negativo sul futuro? Quante volte si è concretamente realizzato? Il risultato, veggenti esclusi, mostrerà verosimilmente che i pensieri sono un pessimo metro di giudizio per prevedere il futuro o leggere la realtà, anche meno affidabile del lancio di un dado. Ne deriva che il mondo dei pensieri è una cosa, il mondo dei dati sensibili, un’altra.
Strettamente connesso alla confusione tra pensiero e realtà c’è la tendenza ad assumere una posizione di assoluto controllo verso le proprie esperienze interne. Se il dubbio è pericoloso allora posso sentirmi sicuro solo se lo elimino quindi cerco rassicurazioni, cerco di distrarmi, cerco di convincermi del contrario, metto in atto un rituale fino a quando il dubbio è scomparso, cerco un modo di staccare la mente (es. bevo alcolici) oppure evito tutte le situazioni che generano dubbi nella mia mente (Wenzlaff & Wegner, 2000). Tutto questo ha un costo che supera la semplice fatica della sua attuazione. Posso eliminare i dubbi dalla mia mente? Purtroppo no, anche perché per eliminarli devo esplorare la mia mente per vedere se ce ne sono ancora. Quando siamo cacciatori di dubbi rischiamo di perdere il dono della fluidità, siamo bloccati nel caos della nostra mente.
Punto terzo: come possiamo concederci il beneficio del dubbio? Si tratta solo di ipotesi.
Però se il dubbio ha una sua utilità, paradossalmente la condizione d’esser ‘privi di dubbi’ potrebbe renderci vulnerabili all’estinzione improvvisa. Incapaci di cogliere potenziali mutamenti del mondo che ci circonda. Guardare il dubbio per quello che è significa (1) riconoscerlo come un oggetto della mente, (2) valutare quando e per quanto ci interessa occuparcene, (3) non attuare strategie per eliminarlo dalla nostra mente, (4) considerarlo una informazione che proviene dalle libere associazioni della mente, non la guida delle nostre scelte ma nemmeno la prova tangibile che le scelte vanno modificate.
Allo stesso modo il dubbio può essere un innocuo segnale che non ce la stiamo raccontando, che non stiamo costruendo una semplice visione della realtà per nostro uso illusorio. Anche uno stato di assoluta convinzione in se stessi può mostrare i suoi lati oscuri: “Era talmente convinto della tenacia delle sue membra, corpo che scelse di non curarsi e morì”.
Insomma, può esistere un danno nell’assenza del dubbio, l’estrema sicurezza non è più anormale dell’estrema dubitosità. Può essere una buona prassi concedere anche a noi stessi il beneficio del dubbio.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Psicoterapia: accertare e ristrutturare le credenze centrali
BIBLIOGRAFIA:
I ricercatori del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano -Bicocca, dopo uno studio condotto su circa 600 bambini di seconda e terza elementare, hanno dimostrato che la convinzione di saper gestire bene le attività scolastiche e le relazioni con i compagni di classe contrastano la depressione. Nessuna altra ricerca, fino ad ora, ha considerato fattori sia negativi che positivi nello studio dei sintomi depressivi su bambini di questa età.
Infatti, a parità di competenze, è la convinzione del saper far qualcosa, a fare la differenza. Lo studio condotto in collaborazione con alcune Università statunitensi, è stato pubblicato sul Journal of Abnormal Child Psychology.
Tra gli elementi di novità della ricerca, la giovane età dei partecipanti e lo studio delle convinzioni di autoefficacia quali fattori di protezione tra i bambini in età scolare.
Alla ricerca hanno partecipato 554 bambini (51,4 per cento maschi, 44,2 per cento di seconda elementare) di 11 scuole elementari del Nord Italia (Lombardia e Piemonte) ai quali è stato richiesto di rispondere ad una serie di questionari.
Un ricercatore leggeva e spiegava le domande ai bambini e chiedeva loro di rispondere singolarmente alla propria batteria di domande, secondo la specifica scala di risposta del questionario.
Gli psicologi hanno così potuto valutare gli stili cognitivi, le convinzioni di autoefficacia scolastica e sociale, i livelli di stress e i sintomi depressivi dei bambini.
Tramite sofisticate analisi statistiche è stato possibile riscontrare come sia fondamentale lavorare sull’autoefficacia e sugli stili cognitivi; entrambi questi indicatori giocano infatti un ruolo chiave sulla depressione.
Chi tende a catastrofizzare le conseguenze degli eventi negativi, riporta livelli più alti di sintomi depressivi. E contemporaneamente, i bambini che si sentono più capaci di far fronte ai compiti scolastici riportato minori sintomi depressivi.
Inoltre, le convinzioni di autoefficacia sociale giocano un importante ruolo nella relazione fra innalzamento dei livelli di stress e concomitante innalzamento dei livelli di depressione: i bambini che si sentono più incapaci nella relazione con i loro compagni mostrano più elevati livelli di stress che portano a maggiori livelli di depressione, rispetto ai bambini che invece si sentono capaci.
Conclusioni
Questi risultati, dicono gli autori, sottolineano l’importanza e la centralità della scuola come contesto primario nel quale i bambini vengono chiamati fin da piccoli ad affrontare compiti, richieste e rapporti sociali molto impegnativi; uno scarso senso di autoefficacia nella gestione di queste situazioni può produrre scoraggiamento e stati d’animo negativi che rischiano di condurre a vissuti depressivi veri e propri.
È necessario quindi lavorare in questo senso per rafforzare nei bambini le loro convinzioni di essere efficaci, fortificare la loro autostima, in un’ottica che sia realmente positiva e preventiva.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Autoefficacia: quanto conta nello sport?
BIBLIOGRAFIA:
LEGGI ANCHE: La guida in curva grazie ai movimenti oculari optocinetici
Gli scienziati sono in disaccordo : alcuni sostengono che il cervello umano calcoli il percorso verso una destinazione, altri che calcoli in linea d’aria. I ricercatori della University College di Londra sostengono invece che entrambi questi metodi sono al lavoro quando gli esseri umani navigano, ma in modi molto diversi.
Per scoprirlo, i ricercatori hanno chiesto a dei volontari di memorizzare le mappe del quartiere londinese Soho. Poi hanno trascorso una giornata a piedi a Soho, tra negozi, ristoranti e pub nelle sue tortuose stradine. (Le persone che hanno ammesso di non avere senso dell’orientamento sono state escluse dalla sperimentazione.)
Il giorno successivo, i partecipanti sono stati sottoposti a fMRI mentre guardavano i video di diverse navigazioni attraverso Soho. Nei primi cinque video, i volontari dovevano decidere dove svoltare per raggiungere una certa destinazione, in poche parole erano loro a navigare. Negli altri cinque, hanno avuto modo di sedersi, rilassarsi e lasciare che il GPS scegliesse il percorso.
Tutti i partecipanti hanno fatto un buon lavoro, scegliendo i percorsi appropriati per più di tre quarti del tempo. Ma la cosa più interessante è come il loro cervello lo ha fatto.
Quando dovevano pianificare come arrivare in un posto, hanno usato una parte del cervello chiamata corteccia entorinale, cioè la stessa che lavora quando pensiamo a come andare da un posto all’altro. Ma durante il viaggio, quando i soggetti dovevano fare attenzione a dove si trovavano e decidere da che parte andare agli incroci, hanno usato una parte del cervello chiamata ippocampo posteriore.
Non è noto cosa accada quando ci muoviamo su un percorso che conosciamo bene, in questo caso potremmo non avere bisogno di calcolarlo perchè lo conosciamo già, e il nostro ippocampo potrebbe essere a riposo.
Inoltre probabilmente quando accendiamo il GPS della macchina il cervello di navigazione si spegne, proprio come è accaduto ai volontari che durante l’esperimento dovevano solo rilassarsi e osservare la navigazione impostata dal GPS: il loro cervello di navigazione seguiva il percorso solo a brevi tratti, per poi disconnettersi affidandosi al sistema di navigazione del GPS esterno.
Entrambe le parti del cervello sono note per svolgere un ruolo nella navigazione e nella memoria, ma questo esperimento è forse il primo a mostrare come ciascuna sia specializzata in un diverso aspetto della navigazione spaziale.
La metà dei partecipanti era di sesso femminile e la metà erano maschi. E non vi era alcuna differenza significativa tra i sessi nelle loro capacità di navigazione.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
BIBLIOGRAFIA:
Duccio Canestrini con questo libro ha sviluppato un modo di studiare il futuro delle persone e delle culture: L’AntroPop.
[blockquote style=”1″]Le cose sono in continuo cambiamento. Molte cose sono cambiate nella nostra cultura. Il mondo è diventato un frittatone planetario. Niente e nessuno è libero da influenze. Stiamo vivendo un inedito, colossale merge, una fusione. In poche parole siamo fusi. Da questa fusione magmatica salgono tante bolle colorate che scoppiettano. E il rumore che fanno, disordinatamente, è pop.[/blockquote]
Duccio Canestrini con questo libro ha sviluppato un modo di studiare il futuro delle persone e delle culture: L’AntroPop.
Ma andiamo con ordine il testo si compone di quattro parti, Antropop entra prima nel vivo della vita quotidiana, leggendo fatti e fenomeni diversi.
Forse non lo sapevate ma Ken ha lasciato Barbie per colpa di Greenpeace; il parabrezza dell’auto è il monitor attraverso cui vediamo il mondo, l’oggettistica da abitacolo è quindi cultura; Martina, che si dichiara lesbica, adora il crushing; ragazzi e ragazze si scattano la foto che diventerà l’immagine del loro profilo online; liberare le mani dalla deambulazione ci ha permesso di passare molte ore a testa bassa scrutando uno schermo (we never look up); le <tradizioni di merda>, con licenza accademica, andrebbero abbandonate senza indugi.
Questo per dire che tutto sommato i temi sono più grandi di quello che sembrano.
In Stupidi indigeni, stupidi antropologi l’autore definisce che è leggendo i fumetti di Flash Gordon che ci si appassiona all’antropologia, sul pianeta Mongo era impossibile non appassionarsi alla diversità delle persone e delle culture; Rihanna assomiglia troppo alla Venere ottentotta; inganni, abbagli e truffe costellano la storia dell’antropologia e dell’etnografia con finti indigeni, finiti antropologi, finte relazioni di viaggio (tutto il mondo è paese mi verrebbe da aggiungere); le teorie affascinanti e assurde di Lombroso vengono contrapposte in Django di Tarantino; passano secoli e decenni ma i razzismi no.
La vecchia antropologia qui a fatica ne esce viva.
Homo turisticus siamo tutti noi che quando viaggiamo ci mettiamo in scena ma forse poi ci capiamo qualcosa. Anche gli antropologi nei loro viaggi possono essere ingannati.
Margaret Mead riassumeva così: “Lo psicologo ha problemi con la propria personalità, il sociologo è in disaccordo con la comunità, l’antropologo è quello che ha problemi sia con se stesso, si con la società di cui fa parte”.
Corporama è la sezione dedicata al corpo. Il corpo, spiega l’autore, è quel luogo autentico che ci racconta, lo sguardo, il saluto, il sorriso. Per quanto riguarda i giovani è l’era della “fusion” tra tatuaggi e piercing ma nessuno ne approfondisce il significato. È la ricerca ostinata di segni particolari, del lookdiversità. È l’epoca dello spettacolo della nudità umana. Dici cultura ma è un magnamagna, non c’è più manifestazione culturale senza assaggino del prodotto tipico.
Insomma Antropop è il punto di vista di un androide specializzato in operazioni intellettuali di emergenza.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
BIBLIOGRAFIA:
BOOKTRAILER:
Nell’epoca dei social network, in cui una cosa non succede davvero se non se ne lascia traccia sui vari facebook o twitter, in una società in cui i tratti narcisistici e estroversi vengono senza dubbio premiati, la scelta migliore per un compito difficile come la conquista di un nuovo pianeta sembra cadere sulle persone forti e silenziose, in una parola, introverse.
LEGGI ANCHE: Cosa significa essere timidi? – Report dalla lezione con il Prof. Carducci
La vecchia dicotomia che riassume l’incomunicabilità tra uomini e donne vede i primi venire da Marte e le seconde da Venere. Linguaggio diverso, impossibilità di comunicare.
C’è però chi su Marte non potrebbe proprio tornarci. Questo almeno sembra emergere da una ricerca condotta da Susan Bell della DePaul University (USA).
Mentre gli scienziati stanno pensando sempre più seriamente alla possibilità di esplorare Marte e la NASA sta lavorando su una navicella che possa sostenere questo viaggio di scoperta, il ricercatore olandese Bas Lansdorp ha fondato MarsOne, un progetto che mira a stabilire una colonia permanente su Marte, una sorta di conquista che attraverso esplorazioni preliminari manderebbe esseri umani sul pianeta rosso nel 2024, affinché ci rimangano e fondino una società parallela. Viaggio di sola andata per Marte, dunque, a cui si sono candidate duecentomila persone da tutto il mondo.
Oltre alle caratteristiche fisiche, anche l’assetto psicologico dei candidati sarà un importante aspetto da tenere in considerazione.
La psicologa e ricercatrice americana Suzanne Bell della DePaul University di Chicago ha presentato recentemente un poster in occasione della Association for Psychological Science a San Francisco in cui ha illustrato i risultati di una prima ricerca.
La ricercatrice ha indagato quale fosse, secondo diversi parametri, la personalità più adatta a intraprendere un’avventura come la “conquista” di Marte, analizzando diverse ricerche che indagavano la vita in ambienti isolati come le persone che lavorano in Antartide nelle stazioni di ricerca.
Nell’epoca dei social network, in cui una cosa non succede davvero se non se ne lascia traccia sui vari facebook o twitter, in una società in cui i tratti narcisistici e estroversi vengono senza dubbio premiati, la scelta migliore per un compito difficile come la conquista di un nuovo pianeta sembra cadere sulle persone forti e silenziose, in una parola, introverse.
La Bell ritiene infatti che nei contesti isolati gli estroversi potrebbero essere percepiti come intrusivi e con richieste di attenzione troppo alte, e visto il poco spazio disponibile la loro ricerca di vicinanza anche fisica potrebbe essere vissuta come invadenza.
Uno dei motivi principali che escludono la partecipazione degli estroversi è la loro tendenza a chiacchierare troppo, assieme alla facilità alla noia e al continuo bisogno di stimoli nuovi, che, va da sé, sarebbe difficile accontentare nello spazio ristretto di una navicella spaziale.
Da un punto di vista sociologico, invece, volendo fondare una nuova colonia e scegliendo solo persone estroverse, questo potrebbe essere un buon esperimento per vedere cosa succede in una socialità orientata al silenzio.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Il potere della timidezza: Introversione, Estroversione e Stili di pensiero
Il guidatore abile è quello che anche sulle strade piene di curve sa gestire con scioltezza il continuo movimento della ruota. Ma la capacità di gestire la ruota non è tutto nella navigazione in curva.
Lo psicologo ricercatore Otto Lappi dell’ Università di Helsinki, infatti, ha dimostrato che i nostri occhi svolgono un ruolo fondamentale quando guidiamo in curva: sarebbero proprio i piccoli movimenti oculari a permettere agli automobilisti di prevedere la traiettoria di un veicolo in una curva.
Lappi e il suo team hanno utilizzato metodi nuovi e innovativi per analizzare i piccoli e sottili movimenti oculari che i guidatori compiono quando guidano in curva. Questi movimenti oculari optocinetici durano solo frazioni di secondo e il conducente non ne ha alcuna consapevolezza. I risultati ottenuti dai ricercatori si basano su un metodo rivoluzionario di analisi del movimento oculare sviluppato dall’University of Helsinki’s Traffic Research Unit.
Seguire il movimento degli occhi in modo preciso e affidabile durante la guida normale è possibile già dal 1990. Tuttavia è solo negli ultimi anni che i metodi di modellizzazione computerizzata del comportamento in ambiente naturale si sono sviluppati ad un livello che consenta la verifica dei diversi modelli teorici di funzionamento cognitivo e neurale che sottendono i movimenti oculari e di guida in ambienti reali.
Anche se il comportamento e la fisiologia associati alla guida sono stati studiati per quasi un secolo, molte questioni fondamentali rimangono senza risposta. Il merito di questo studio è avere fornito nuove informazioni sul controllo visivo della guida in curva, e nuovi strumenti per analizzare i processi fondamentali alla base del controllo del movimento in ambienti naturali.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
BIBLIOGRAFIA:
Gli stati mentali immaginati da Costanza Prinetti

Relazione presentata a Roma il 29 Maggio 2014 in occasione dell’evento formativo:
LEGGI ANCHE: ARTICOLI SU: SESSUALITA’

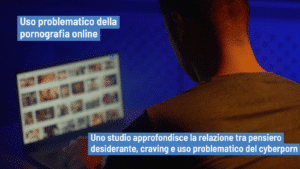




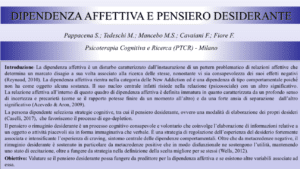













Probabilmente è l’effetto dell’onda lunga del seminario del prof. Stone sui serial killer organizzato un paio di mesi fa a Milano da Studi cognitivi, ma mi sembra (attenzione selettiva?) che in questi giorni la cronaca offra molti spunti al tema, sempre aperto, del rapporto tra malvagità e malattia mentale.
Il signore che uccide la moglie dopo averci fatto l’amore (a cosa sarà stato utile poi la diffusione di questo particolare?) sgozza i due figli di 2 e 5 anni e poi va al pub a condividere con gli amici le emozioni per l’esordio mondiale degli azzurri. Confesserà di essersi invaghito non ricambiato di una collega di lavoro. L’arresto del presunto seviziatore e omicida di Yara. La scarcerazione della madre di Cogne che anni fa si macchiò del delitto per il quale in italiano non esiste neppure il nome l’omicidio del figlio.
Per fortuna a rendere meno pesante la riflessione su questi temi ci ha pensato il bel Renè. Renato Vallanzasca mitico bandito della Milano degli anni 70, cui è stato dedicato un bellissimo film con Kim Rossi Stuart. Vallanzasca in permesso premio dai 4 ergastoli che sta scontando si è fatto arrestare per un furto di mutande ad un supermarket. Viene da pensare che la libertà faccia ad alcuni davvero paura e torna in mente l’altro caso del mitico bandito Graziano Mesina. Anche Grazianeddu graziato dopo 40 anni effettivamente scontati in galera (un record assoluto per l’Italia cattolica sempre pronta al perdono) è tornato subito dietro le sbarre. Ma questo è un altro tema.
Il problema ha implicazioni anche giuridiche molto rilevanti. Infatti a fronte di una diagnosi psichiatrica, soprattutto se grave, scatta la presunzione di non imputabilità (la famosa incapacità di intendere e di volere). Considerato poi che una diagnosi di disturbo di personalità non si nega a nessuno, il rischio di un assoluzione complessiva del genere umano e di tutte le nefandezze di cui è capace, è evidente. Temo un ecumenico tana libera tutti che riconoscendoci strumenti inconsapevoli del nostro patrimonio genetico impegnato nella dura battaglia per la sopravvivenza ci privi ad un tempo della libertà e della responsabilità.
LEGGI ANCHE LA RUBRICA: PSICHE & LEGGE
L’unico sul banco degli imputati resterebbe Dio o il suo facente funzione, l’impietoso ambiente selettivo che costringe a non guardare tanto per il sottile pur di cavarsela e riprodursi copiosamente. Dunque: matti o delinquenti? La presunta imprevedibilità del matto lo ha fatto per secoli percepire come pericoloso per sé e per gli altri (definizione ancora presente nella legislazione di quasi tutti i paesi, fuorchè l’italia!!, per giustificare trattamenti coatti a suo carico) e dunque destinatario di provvedimenti allo stesso tempo di cura e custodia.
Se nell’immaginario collettivo il folle è cattivo e pericoloso, gli operatori della salute mentale hanno enfatizzato, per contrasto, la polarità opposta. E’ visto come una vittima della famiglia e della società. Come cantava De Andrè ne “La città vecchia”:
Se non sono gigli son pur sempre figli, vittime di questo mondo
Tornando alla domanda iniziale che si pone di fronte a crimini orribili, se i loro autori siano matti o semplici delinquenti ce la si può, in prima battuta, cavare sostenendo che si tratta di due dimensioni distinte e che la congiunzione tra i due termini non debba essere una o esclusiva ma una e intendendo che trattasi di due insiemi diversi con alcune sovrapposizioni. In altre parole, si può essere completamente matti e assolutamente non delinquenti (anzi questa è, per nostra fortuna, la norma) e, di contro, totalmente delinquenti senza nessuna traccia di follia (anche questa è la norma se si pensa alle varie mafie diffuse nel mondo).
Anzi se si è troppo matti non si riesce ad essere dei buoni delinquenti perchè il disagio mentale grave danneggia l’adattamento, anche criminale, all’ambiente sociale e lavorativo, quale che sia il lavoro in questione. Poi ovviamente esistono tutti i diversi livelli di sovrapposizione tra le due dimensioni. Credo ci sia lo stesso rapporto che sussiste tra follia e creatività artistica. Non si implicano necessariamente, talvolta la follia la danneggia, talaltra la esalta. Probabilmente è spesso una questione di dosaggio (la posologia).
Infatti la perizia di fronte a tali reati non chiede se il soggetto sia folle o delinquente, non si vuole valutare l’autore nella sua complessità ma il gesto criminale. Si tratta di stabilire se l’atto fosse, nel momento in cui è stato compiuto, un vero e proprio sintomo o comunque una conseguenza diretta ed inevitabile dei sintomi. Ad esempio uno schizofrenico può non essere imputabile per aver mangiato il cuore della madre se erano le voci ad ordinarglielo e finire in carcere per un furto al supermercato non potendo rispondere al poliziotto che lo ha fermato come il bel Renè, nella migliore tradizione italiana celebrata dai film di Alberto Sordi lei non sa chi sono io!
La difficoltà nel mettere a fuoco il problema sta nel fatto che non sono ben definiti proprio i termini che si vogliono confrontare. Ad esempio delinquenza è sinonimo di cattiveria? A mio avviso no. Il delinquente è una forma estrema di egoista per cui in nome del proprio interesse non guarda in faccia a nessuno, che siano leggi o vissuti degli altri che considera come meri strumenti al suo servizio (come non vedere in questo i tratti del disturbo antisociale e narcisistico di personalità). Il cattivo invece ha come scopo il danneggiamento e la sofferenza dell’altro senza ricavarne altro vantaggio (ma non potrebbe ciò essere considerato un disturbo sadico di personalità?).
Per l’altro termine non stiamo meglio. Dopo oltre trent’anni di lavoro nel campo della salute mentale mi riesce impervio tentare una definizione sintetica e unitaria di follia che colga un minimo comune denominatore nelle molteplici malattie mentali se non, forse, proprio una sofferenza estrema e personalissima a stare nel mondo che ai più appare inspiegabile non sussistendone, per il buon senso comune, motivi sufficienti. Tornando al nostro quesito da cena estiva ritengo che il problema vada mantenuto distinto nei due versanti.
La legge deve sanzionare tutti i comportamenti contrari ad essa quale che ne sia la causa e la pena, ha sempre un doppio scopo di deterrenza e di recupero. Non dunque manicomi criminali separati dalle carceri, ma carceri o soluzioni alternative alla detenzione che abbiano lo scopo di recuperare il reo alla vita di comunità. Gli operatori della salute mentale coltivano invece la curiosità ed il compito di spiegare i singoli comportamenti individuali, dai più normali a quelli bizzarri o efferati partendo da una analisi minuziosa del soggetto, della sua storia e del suo apparato di scopi e credenze. Le teorie generali sono anche, molto spesso, terribilmente generiche. Chi di noi non ha provato imbarazzo per l’appartenenza alla categoria dinnanzi a esternazioni di fronte a telecamere e microfoni di esimi colleghi che semplificano la complessità delle determinanti del comportamento umano avvalendosi di luoghi comuni che sarebbero parsi tali anche a mio nonno nato prima de L’interpretazione dei sogni? Non si tema di restare in silenzio di fronte al mistero. Soltanto una autopsia dello specifico gesto dopo un approfondimento con il suo autore, teso a ricostruirne la personalità può condurci ad una comprensione che deve rimanere ad esso circoscritta.
Nel primo ci si chiede perchè il soggetto sia arrivato per la prima volta a compiere un crimine orrendo. Qui si intrecciano come sempre cause genetiche, di apprendimento e ambientali accidentali. Nel secondo ci si interroga sul perchè il soggetto torni a commettere reati analoghi. Nella ripetizione credo non vada sottovalutato il ruolo dell’addiction alla scarica adrenalinica che un comportamento estremo comporta. Insomma un conto è perchè iniziano, altro perchè continuano. Non vale forse la stessa cosa per l’uso di sostanze?
In conclusione mi sembra che se ogni deviazione del comportamento dalla norma statistica o ideale è considerata effetto di una patologia che limita la libertà e dunque la responsabilità individuale, tutti saremo sempre assolti perchè non abbiamo fatto altro che ciò che il nostro patrimonio genetico nell’incontro con l’ambiente ci ha consentito di fare. Non potendo rispondere del genotipo e rispondendo in solido con tutta l’umanità dell’ambiente in cui viviamo non si può che essere compassionevoli verso qualsiasi fenotipo e cantare con Shell dei Rokes Ma che colpa abbiamo noi?
E’ evidente che il tema potrebbe essere interessante e anche che necessita di strumenti filosofici che mi sono estranei.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
REPORT DAL 45esimo MEETING ANNUALE DELLA SOCIETY FOR PSYCHOTHERAPY RESEARCH
Dopo una giornata di workshop pre-congressuali, il convegno è entrato nel vivo e ha visto alternarsi simposi di argomento affine, presentazioni libere, discussioni su un tema specifico e sessioni plenarie.
Un’apertura che sembra di buon auspicio, con una plenaria che ha raccolto quasi tutti i past president di SPR e una linea di ampio respiro, pronta a integrare approcci differenti e a porsi interrogativi a tratti scomodi.
Così, per esempio, abbiamo potuto assistere a un’intera sessione che approfondiva la difficile domanda: In tutti questi studi di esito e di processo, dove li mettiamo i pazienti che non solo non rispondono al trattamento, ma addirittura peggiorano?. Ora, ovviamente una risposta univoca non esiste, e sono stati mostrati risultati preliminari su studi piccoli e in divenire, ma è interessante già la volontà di puntare i riflettori non solo su quello che conferma quanto la psicoterapia sia efficace (più, meno, meglio, peggio del farmaco), ma anche sulle situazioni in cui il terapeuta può sperimentare un senso di impotenza o può addirittura peggiorare il quadro. In qualche modo, un passo scomodo ma necessario per richiamare anche alla mente tutti i limiti che gli interventi psicologici portano con sé.
Proseguendo nel programma, sono stati toccati molti argomenti, suddivisi sulla base del target di osservazione (terapia con bambini piuttosto che terapia di coppia), dell’approccio di riferimento (cognitivo, psicodinamico, neurobiologico), della sintomatologia interessata oppure dei processi osservati.
Il gruppo di Santiago, che fa capo al Dr. Botto, ha presentato due revisioni sistematiche della letteratura, che approfondivano il ruolo della componente genetica nei disturbi dell’umore. Intanto, hanno sottolineato come spesso negli studi, davanti a questa dicotomia mente/cervello (che purtroppo cerchiamo di combattere ma contemporaneamente portiamo nel nostro bagaglio e nel nostro modo di vedere alle cose) ci sia la tendenza a sottolineare, quando si parla di ambiente, solo quelle caratteristiche che rendono difficoltoso uno sviluppo sano (genitori dismissing, un ambiente sociale stigmatizzante, difficoltà economiche), tralasciando il ruolo che un ambiente positivo può avere, fino a ostacolare l’espressione di un corredo biologico sfortunato.
Purtroppo, il gruppo cileno sottolinea come in questi studi manchi la considerazione degli eventi di vita recenti, e come questi valutino il modo in cui l’ambiente viene percepito, e non quello che oggettivamente è. Infine, si sente la mancanza di studi cross-culturali, che possano confrontare fra loro ambienti massivamente diversi, non solo con riferimento al livello sociale o famigliare, ma anche culturale in un senso più ampio (religioso, etico, morale, etc.).
Allora, nello studio della depressione e dei geni, si sottolinea come questa sia una patologia tendenzialmente ricorrente e cronica e con una prevalenza dell’8-12% nella popolazione generale (Andrade et al., 2003). Per quanto riguarda la biologia, il genoma e l’ambiente sono in relazione e i geni sembrano moderare l’effetto dell’ambiente sulla salute mentale. A quanto pare, due esseri umani condividono più del 99% del DNA. Che significa che tutte le differenze fenotipiche che possiamo osservare guardandoci attorno stanno in meno di un 1% di DNA, assieme a caratteristiche ambientali e esperienze di vita diverse.
In particolare, la letteratura ha finora approfondito il ruolo che nei disturbi depressivi hanno la serotonina, la dopamina e l’ossitocina. Mentre la prima ha a che fare con i sintomi depressivi tout-court (ed è stata indagata, appunto, in associazione a eventi di vita negativi), la seconda ha a che fare con i comportamenti e la terza sia con l’umore depresso che con la cognizione sociale,
intervenendo anche nella risposta allo stress.
Ci sono diverse teorie che associano biologia e depressione. Mentre secondo la teoria aminergica la depressione sarebbe causata da una diminuzione di serotonina o norepinefrina, studi più recenti sostengono che i circuiti serotoninergici includerebbero strutture che controllano i sintomi depressivi, nonostante questa associazione biologia-depressione non abbia i criteri perché si possa parlare di causalità.
Per quanto riguarda infine la plasticità neurale, si sottolinea come un trattamento antidepressivo cronico produca un adattamento nel modo in cui le cellule comunicano, il che facilita l’espressione di determinati geni. In particolare, il BDNF (Brain-derived neurotrophic factor, fattore neurotrofico cerebrale) è un gene associato alla plasticità neurale il cui livello viene alterato anche da altre patologie, non solo dalla depressione. Secondo altri autori, la causa biologica della depressione sarebbe un aumento degli agenti infiammatori che possono portare a un cambiamento nella struttura cerebrale.
Tuttavia, altri autori hanno osservato come la depressione predica i futuri livelli di citochine (molecole proteiche che permettono alle cellule di comunicare), ma i livelli di citochine non predicano i futuri sintomi depressivi.
In più, molti studi hanno trovato un’associazione tra depressione e disregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Il gruppo cileno allora ha utilizzato una procedura longitudinale misurando i livelli di cortisolo, l’ansia e i sintomi depressivi prima e dopo uno stress sociale. Quello che emerge è una correlazione significativa tra cortisolo e ansia, ma non tra cortisolo e depressione.
Va comunque specificato che, utilizzando un campione non clinico, si corre il rischio di appiattire i dati riferiti all’umore depresso (gli studenti universitari, in altre parole, erano troppo poco depressi per poter trarre conclusioni affidabili su questo dato). Per ricavare dati più chiari, l’intenzione è di fare uno studio in cui misureranno il cortisolo in un dato momento (T1) e il cortisolo, il BDNF, e i sintomi depressivi 6 mesi dopo (T2), per valutare se i livelli di cortisolo al T1 possono predire gli altri livelli e la depressione al T2.
Potrebbe essere insomma un altro passo, più pratico e meno ipotizzato solo in teoria, della voglia di considerare mente e cervello una sola entità. Fill the gap between mind and brain più che uno slogan sta diventando una necessità.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
I ricercatori dell’Università di Medicina di Stanford hanno reclutato per il presente studio 76 bambini tra i 7 e i 9 anni d’età, periodo in cui tratti e sintomi ansiogeni possono essere già identificati e considerati attendibili. Uno strumento, appositamente costruito e validato dagli sperimentatori, è stato utilizzato per misurare i livelli d’ansia nei bambini partecipanti allo studio. Questo strumento utilizza come parametri diagnostici il volume e l’estensione delle connessioni funzionali dell’amigdala, rilevate tramite Imaging a risonanza magnetica (MRI).
è cruciale approfondire gli attuali risultati conducendo delle ricerche longitudinali in grado determinare se l’aumento del volume e la maggiore connettività funzionale dell’amigdala sono da considerare fattori di rischio o conseguenze dell’ansia infantile.
Tuttavia, il presente studio rappresenta un passo importante per individuare i sistemi cerebrali alterati ed i possibili biomarker per l’identificazione dei giovani ad alto rischio di disturbi d’ansia. Inoltre, comprendere già dall’infanzia come l’ansia influenza gli specifici circuiti dell’amigdala potrebbe fornire nuovi ed importanti spunti teorici sulle origini dello sviluppo neurologico dell’ansia negli esseri umani.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
BIBLIOGRAFIA:
Per comprendere le dinamiche della timidezza, gli studenti di Studi Cognitivi hanno avuto la grande possibilità di partecipare alla lezione di uno dei più importanti studiosi del tema: Bernardo J. Carducci, professore presso l`Indiana University Southeast.
Guarda l’INTERVISTA AL PROF. CARDUCCI al Congresso APA 2013 di Honolulu (HAWAII)
Nel corso della lezione numerosi punti chiave del tema sono stati affrontati, primo tra tutti: cos’ è la timidezza? Nonostante la tendenza a medicalizzare la timidezza, essa non è né un disturbo, né un tratto di personalità, può essere invece intesa come un fallimento nell’affrontare situazioni sociali, caratterizzata da componenti affettive, cognitive e comportamentali.
La timidezza non va confusa con introversione né con bassa autostima: mentre nell’ introversione vi è un volontario rifiuto nel rapportarsi agli altri, il timido cerca la loro vicinanza ma non riesce ad approcciarsi. L’autostima invece può essere alta a livello globale nel timido (pensiamo alle numerose star o persone di potere timide) ma bassa solo in specifici domini, primo tra tutti il dominio delle competenze sociali.
Nonostante una serie di auto strategie, emerse da numerosi studi, che i timidi mettono in atto per combattere il loro disagio (ad es. estroversione forzata, pensare positivo, consultare libri di auto- aiuto, bere o relazionarsi tramite internet), queste si mostrano quasi sempre insufficienti ad affrontare la propria timidezza.
Solo in tal modo si può vivere meglio e diventare dei timidi di successo!
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Prof. Carducci: Shyness – Is being introverted the same of being shy?
Prof. Carducci: Distinction between shyness and social anxiety
Report dal seminario
“Mio fratello che guardi il mare…”
Milano, Sabato 21 Giugno 2014
Il tema dei rifugiati e richiedenti asilo sopravvissuti a tortura è di assoluta attualità e pone difficoltà e sfide peculiari per operatori, psicologi, psichiatri e in generale per tutte le figure che a vario titolo sono chiamate ad occuparsi di situazioni così al limite. E’ necessario fornire ai professionisti del settore strumenti adeguati per far fronte alle specifiche vulnerabilità create da violenze e torture subite nel paese d’origine, durante il viaggio e dal trauma migratorio.
L’incontro con la sofferenza di pazienti che provengono da storie costellate di traumi precoci, estremi e continuativi è una grande sfida per i clinici di ogni orientamento e negli ultimi anni molto spazio è stato dato alle specifiche difficoltà che queste persone portano in terapia sia dal punto di vista diagnostico sia dal punto di vista squisitamente terapeutico.
Rispondendo alla crescente urgenza di risposte a tale proposito il Servizio di Diagnosi e Terapia del Trauma Psicologico dello studio A.R.P. di Milano organizza un ciclo di incontri clinici “anti-impotenza”, volti a individuare, nel confronto con esperti che operano in vari campi della psicotraumatologia, soluzioni che permettano di orientarsi e definire via di cura per quadri psicopatologici complessi.
Quello di sabato 21 Giugno con Massimo Germani, in continuità con la giornata mondiale del rifugiato celebrata il giorno precedente, è stato il seminario inaugurale di questo ciclo di incontri.
Il tema dei rifugiati e richiedenti asilo sopravvissuti a tortura è di assoluta attualità e pone difficoltà e sfide peculiari per operatori, psicologi, psichiatri e in generale per tutte le figure che a vario titolo sono chiamate ad occuparsi di situazioni così al limite. E’ necessario fornire ai professionisti del settore strumenti adeguati per far fronte alle specifiche vulnerabilità create da violenze e torture subite nel paese d’origine, durante il viaggio e dal trauma migratorio.
Nella prima parte del suo interessantissimo intervento Massimo Germani delinea gli elementi che costituiscono la tortura, i fattori caratterizzanti i vari tipi di tortura e le proporzioni impressionanti del fenomeno a livello mondiale: la tortura è attualmente praticata da 102 Paesi, Italia compresa; tra il 20% e il 25% dei richiedenti asilo ha subito torture e in Europa attualmente vivono circa 600.000 di rifugiati sopravvissuti a torture, di cui solo 30.000 hanno potuto avvalersi di cure specialistiche adeguate.
Sono dati allarmanti.
Sappiamo che l’essere esposti a traumi complessi, estremi e cumulativi è un fattore di rischio importante per lo sviluppo di psicopatologia. In questo senso tutti i richiedenti asilo sono potenzialmente vulnerabili, ma certamente ci sono categorie che diventano effettivamente vulnerabili (anziani, disabili, donne in gravidanza, minori) o altamente vulnerabili (vittime di tortura, stupro, traumi estremi) che devono essere identificati per poter fornire loro cure adeguate. In quest’ultimo gruppo di persone, infatti, la presenza di psicopatologia è quasi costante, anche se a volte latente, e tende a peggiorare e cronicizzarsi se non trattata, rendendo difficile il processo integrativo nel nuovo contesto e il percorso verso l’autonomia, con costi umani, sociali ed economici enormi.
All’interno di questa categoria, inoltre, c’è un sottogruppo definito ad alto rischio che comprende persone sopravvissute a torture, stupro e violenza estrema con pre-esistenti disturbi psichici latenti o conclamati. In questa categoria si ritrovano quadri di psicopatologia conclamata anche severa, rapida progressione in senso peggiorativo del quadro clinico e impossibilità (non solo difficoltà) del processo integrativo e del percorso verso l’autonomia.
Aspetto di cardinale importanza è la necessità di considerare i fattori che concorrono a determinare la gravità del quadro clinico lungo un arco temporale: fattori pre-traumatici, peri-traumatici e post-traumatici. E’ fondamentale che operatori e pazienti abbiano la consapevolezza che c’è un prima e un dopo e che tutto quello che succede in questi momenti è rilevante per l’esito psicopatologico.
Riconoscere precocemente i segnali che indicano la presenza di fattori di rischio è di cruciale importanza per una presa in carico adeguata che consenta l’integrazione nel nuovo contesto e l’uscita verso una nuova autonomia. Per rispondere a questa esigenza Massimo Germani presenta l’E.T.S.I. “Extreme Trauma and Torture Survivors Identification Interview”, strumento messo a punto dal suo gruppo per facilitare, nei CARA o nei centri di prima accoglienza, l’individuazione di situazioni di vari gradi di vulnerabilità al fine di indirizzare le persone a rischio nei centri specialistici. Non è uno strumento di diagnosi, ma di screening, che si è rivelato affidabile per un’accurata identificazione precoce anche da parte di clinici non specialisti.
Altro elemento cruciale sottolineato da Massimo Germani è che il trauma non è sempre patogeno. Il trauma è un’esperienza che dipende dall’incontro tra evento oggettivo e vissuto soggettivo, tra fattori di rischio e fattori di protezione. Non è l’esito di una causalità lineare, ma di una multifattorialità complessa.
Il tipo di trauma è certamente un elemento sostanziale: circa il 20-30% di traumi singoli/non interpersonali e il 33-75% di traumi ripetuti, continuativi e interpersonali evolvono fino a quadri psicopatologici conclamati.
L’esperienza traumatica, tuttavia, è una condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo di una patologia post-traumatica. E’ necessario un modello patogenetico complesso delle patologie post-traumatiche basato su un processo di causalità reciproca, che ristabilisca la centralità dell’individuo e del contesto di cui egli è partecipe, inteso anche come contesto di arrivo. La vulnerabilità al trauma non è una qualità statica e acquisita una volta per tutte, ma varia nello stesso individuo in funzione del tempo e delle circostanze ambientali e personali.
La terza parte dell’intervento si focalizza sulla definizione di Disturbo Post-Traumatico Complesso, distinguendolo dal PTSD semplice. I traumi estremi, interpersonali e continuativi hanno un impatto particolarmente dirompente, frammentante e annichilente e provocano alterazioni profonde delle funzioni associative della psiche.
Di fronte ad esperienze così estreme le normali difese della persona non sono più in grado di funzionare ed entrano in gioco difese primitive, dissociative. I frammenti inelaborabili del trauma restano confinati all’interno di una o più parti di personalità che acquista caratteristiche dissociative. Le parti dissociative sono psichicamente attive, se pure frammentate e tendono a riapparire automaticamente in situazioni stressanti, condizionando pesantemente il funzionamento dell’Io che si impoverisce.
Oltre a ciò il Disturbo Post-Traumatico Complesso è caratterizzato da alterazioni nell’identità e nelle relazioni, sintomi cognitivi e alterazioni della memoria, sintomi depressivi e alterazioni della sfera affettiva, sintomi da iper o ipo-arousal, sintomi ansiosi e sintomi somatici. La dissociazione, tuttavia, è il nucleo centrale e specifico della traumatizzazione e tende ad aggravarsi con la sequenzialità dei traumi, come dimostra anche una ricerca su rifugiati del Camerun e del Ciad presentata da Germani.
Questa ricerca mette in evidenza anche l’importanza del periodo post-traumatico che inizia con la fuga dal paese d’origine, non solo in termini di traumatizzazione secondaria così frequente durate la fuga ma anche intesa come situazioni e contesti destabilizzanti nei paesi di arrivo.
La specificità dei rifugiati sopravvissuti a tortura deve essere considerata nel momento in cui si delineano progetti di accoglienza e trattamento. Oltre a presentare quadri sindromici connessi a traumi estremi, infatti, queste persone devono fare i conti con la precarietà e la marginalità sociale, il deserto affettivo, l’eclissi del senso d’identità e l’incertezza assoluta riguardo al futuro che caratterizza la loro condizione di profughi.
Il trattamento deve essere individualizzato in base alle caratteristiche del paziente, alla situazione psicopatologica di base e attuale, alle condizioni sociali attuali, ai sintomi emergenti e al grado di rischio.
Quanto emerso da questa intensa giornata rende evidente come la presa in carico di questi pazienti debba essere integrata, comprendente assistenza medica, psicologica, sociale e legale, e debba fornire una forte componente di supporto e protezione per ridare loro una dignità di vita, tenendo conto delle risorse e capacità disponibili.
Il lavoro deve essere centrato sulla persona e non sul trauma, per evitare ulteriori traumatizzazioni e grande attenzione deve essere dedicata alle prime fasi di alleanza terapeutica e stabilizzazione, basilari e molto delicate in questo tipo di pazienti.
A fare da esemplificazione ci ha accompagnati, nel corso della giornata, un caso clinico presentato dal Servizio di Etnopsichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano, che bene ha mostrato le difficoltà di diagnosi, i nodi critici, la delicata scelta del trattamento e la sinergia dell’operato delle molteplici figure professionali coinvolte nella presa in carico del paziente.
La giornata si è conclusa con la proiezione di un bel video sul Laboratorio Teatrale del Progetto Vi.To. del Consiglio Italiano per i Rifugiati, che si occupa di accoglienza e cura delle vittime di tortura e tiene incontri presso un barcone ormeggiato sul Tevere, in cui si dà voce e spazio alla condivisione e all’elaborazione (implicita: è teatro, non teatro-terapia) delle difficili esperienze vissute dai rifugiati attraverso l’esperienza teatrale.
ARTICOLO CONSIGLIATO:
Nuove frontiere nelle cura del trauma – Report dal congresso di Venezia