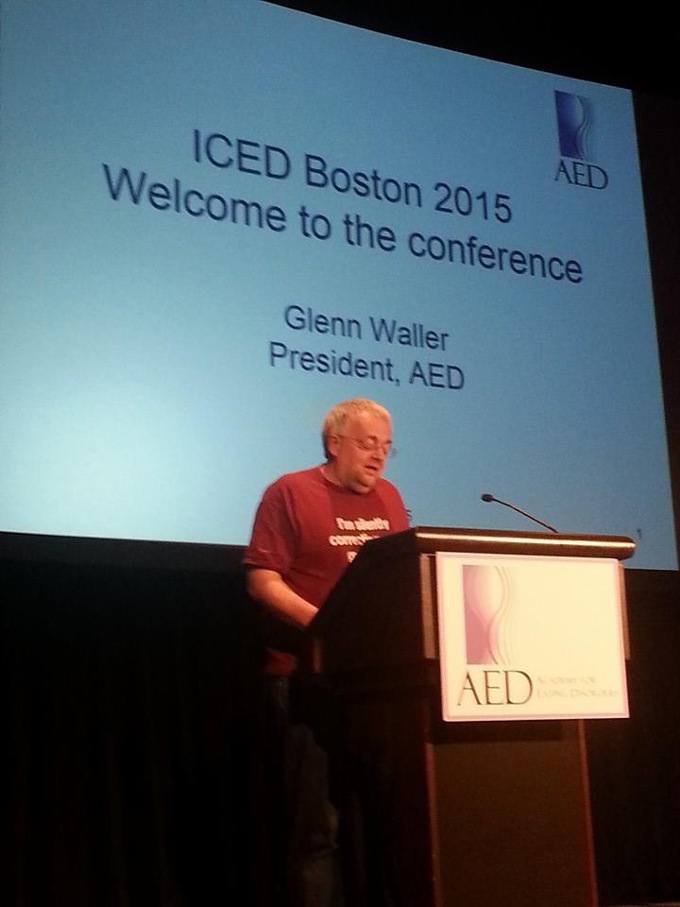La Doppia Diagnosi: ad ogni disturbo le sue sostanze
Giada Costantini, OPEN SCHOOL Studi Cognitivi
Le ricerche esistenti sul rapporto causale tra disturbi psichiatrici e disturbi derivanti da sostanze stupefacenti sottolineano come i sintomi dei disturbi mentali e dei problemi legati alla tossicodipendenza interagiscono l’uno con l’altro e si influenzano vicendevolmente.
La comorbilità, o doppia diagnosi, è definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come la coesistenza nel medesimo individuo di un disturbo dovuto al consumo di sostanze psicoattive e di un altro disturbo psichiatrico.
Le ricerche esistenti sul rapporto causale tra disturbi psichiatrici e disturbi derivanti da sostanze stupefacenti sottolineano come i sintomi dei disturbi mentali e dei problemi legati alla tossicodipendenza interagiscono l’uno con l’altro e si influenzano vicendevolmente: in alcune ricerche emerge che i disturbi psichiatrici e della personalità di solito si manifestano prima dei disturbi derivanti dall’uso di sostanze, accentuando la suscettibilità individuale a tali problemi (Kessler et al., 2001; Bakken, Landheim, e Vaglum, 2003); tuttavia, i disturbi psichiatrici possono essere anche aggravati dal consumo di sostanze stupefacenti (ad esempio in McIntosh, e Ritson, 2001) oppure possono manifestarsi in parallelo.
In linea generale, la relazione che lega tossicodipendenza e disturbo psichiatrico può essere di vario tipo.
In un primo caso, la tossicodipendenza può essere conseguenza di una problematica psichiatrica (autoterapia). In questo senso molti pazienti tentano di curare il loro disturbo mentale da soli e l’uso della sostanza subentra in un secondo momento. In una seconda condizione le sostanze possono precedere, causare o slatentizzare una sintomatologia psichiatrica indotta da un’intossicazione, da una crisi d’astinenza o dagli effetti persistenti del consumo prolungato della sostanza. L’intensità e la durata dei sintomi psichici sono determinate dal tipo di sostanza usata, dalla sua quantità e dalla durata del consumo. Infine, il disturbo mentale e la tossicodipendenza possono essere paralleli e la causalità del tutto indipendente; in genere poi interagiscono aggravandosi a vicenda.
Per quanto riguarda i disturbi dell’umore, sono il tipo di disturbo psichiatrico più spesso in comorbidità con i DUS (disturbo da uso di sostanze): la depressione può indurre abuso di sostanze come tentativo di automedicazione, o può a sua volta causare depressione, disforia, ansia e la così detta sindrome amotivazionale; il disturbo bipolare è presente soprattutto con quadri clinici caratterizzati da tratti più marcatamente ansiosi e da spiccata impulsività. Le evidenze della letteratura indicano che circa 2 pazienti bipolari su 3 (60-65%) incontreranno una sostanza durante il proprio decorso clinico (Clerici et al., 2006).
Anche i disturbi d’ansia hanno una buona comorbilità con l’uso di sostanze: come dimostrato in diversi studi (Ogborne et al., 2000; Gandhi et al., 2003; Tournier et al., 2003) i pazienti che presentano un disturbo d’ansia tendono ad assumere principalmente sostanze ad azione sedativa con giustificazioni auto-terapiche improprie.
In letteratura è riportata una stretta relazione tra DAP (disturbo da attacchi di panico) e uso/ abuso di cannabis con aumento, rispetto alla popolazione generale, sia del numero degli attacchi di panico che della durata della malattia.
Tale relazione viene spesso sottostimata e misconosciuta dagli assuntori che attribuiscono erroneamente proprietà ansiolitiche ai cannabinoidi (Zvolensky, Cougle, Johnson, Bonn-Miller, e Bernstein, 2010).
La relazione di tipo causale che unisce il disturbo d’ansia generalizzata e la fobia sociale con il DUS appare essere biunivoca e può essere immaginata come un circuito chiuso: l’ansia spinge alla sperimentazione delle sostanze e si ripresenta, essa stessa, come sintomo caratteristico delle fasi astinenziali, divenendo così il principale fattore di mantenimento del comportamento d’abuso, potenziando anche la sintomatologia ansiosa che si voleva medicare (Buckner, Heimberg, Ecker, e Vinci, 2013).
La presenza del disturbo ossessivo compulsivo (DOC) non è certo infrequente nei nostri pazienti, poiché i meccanismi di base, comuni sia ai comportamenti di dipendenza da sostanze che alle patologie dello spettro impulsivo/compulsivo, si sovrappongono. Infatti il DOC, il discontrollo degli impulsi (ICD) e il DUS convergono a vari livelli: fenomenologico, neurochimico, neurocognitivo, a livello dei neurocircuiti cerebrali e della comorbidità. I comportamenti DUS e ICD correlati dovuti ad un aumento della compulsività, chiamano in causa i circuiti dello striato dorsale. Si ritiene quindi che, con la progressione e la cronicizzazione dei disturbi, gli uni prendano le caratteristiche degli altri, aggravandosi a vicenda e rendendo più difficili i trattamenti (Fontenelle, Oostermeijer, Harrison, Pantelis, e Yucel, 2011).
Tuttavia, a complicare la cura dei pazienti con sintomi ansiosi sono i trattamenti farmacologici con benzodiazepine, delle quali i pazienti tendono rapidamente a fare un uso improprio, a volte associando altre sostanze psicoattive ad azione sinergica. Anche in questo caso le sospensioni delle terapie amplificano l’ansia rendendo ancora di più il paziente vulnerabile a ricadere nelle assunzioni.
Tra i pazienti dei servizi psichiatrici con molta frequenza si rileva la presenza di casi di comorbilità DUS e disturbi schizofrenici (Asher, e Gask, 2010). Tra i pazienti psichiatrici le sostanze maggiormente utilizzate sono l’alcol ed i cannabinoidi (Garofano, Barretta, Falco, e Auriemma, 2014).
L’alcol, inducendo una disinibizione comportamentale e quindi facilitando la perdita del controllo degli impulsi, porta al peggioramento del quadro clinico. L’utilizzo viene sostenuto da un desiderio di automedicazione soprattutto per alleviare ansia, tensione, depressione (Evren, e Evren B, 2003). L’associazione tra disturbi psicotici e derivati della cannabis è ormai ben supportata da numerosi studi epidemiologici e neurofisiologici: l’uso dei cannabinoidi è un fattore di rischio per lo sviluppo di psicosi ed un elemento aggravante della sintomatologia psicotica già in atto. Anche in questo caso vi è il tentativo improprio di risolvere l’ipoforia e l’apatia che accompagnano la sintomatologia negativa correlata alla condizione psicotica in atto (Zammit et al., 2008).
Le stesse motivazioni autoterapiche si riscontrano nella scelta dell’uso di sostanze psicostimolanti, come la cocaina e le amfetamine, probabilmente compensatoria rispetto ad una condizione di ipodopaminergia presente a livello del sistema mesocorticale, che sembra essere fondamentale nella patogenesi della schizofrenia. L’abuso compulsivo viene così giustificato dalla necessità di mantenere un normale tono dopaminergico. Tuttavia, al sollievo iniziale della sintomatologia negativa, segue il potenziamento dell’espressione psicopatologica legata ai sintomi positivi, con alterazioni comportamentali fortemente disadattivi (De Quadro, Carpenter, e Tandor, 2000).
Anche alcune sostanze psicostimolanti ed allucinogene possono indurre quadri psicopatologici indistinguibili da episodi psicotici acuti: le psicosi acute indotte da sostanze stupefacenti caratterizzano in particolare i consumatori di cocaina, anfetamine ed allucinogeni, le quali, di solito, si attenuano relativamente in fretta una volta sospeso l’uso.
L’uso cronico di cocaina è in grado di generare una sindrome paranoidea di gravità variabile, a volte difficilmente differenziabile da forme schizofreniche paranoidi primarie. Di pari gravità sono le psicosi croniche indotte dagli allucinogeni (LSD e Fenciclidina, PCP) i cui sintomi, caratterizzati da comportamenti bizzarri e a volte violenti, possono perdurare per mesi o ricomparire anche ad un anno dalla sospensione. Altre sindromi psichiatriche possono essere indotte dall’uso di ecstasy (MDMA) come la psicosi paranoidea, il disturbo schizoaffettivo e il disturbo ossessivo compulsivo. Inoltre i poliabusatori hanno un maggiore rischio di disturbi psichiatrici legati all’assunzione di ogni singola sostanza.
All’espressione di sintomi di natura psicopatologica concorrono diversi altri fattori come la personalità premorbosa, la presenza di una patologia psichiatrica sottosoglia, la predisposizione genetico-biologica e la storia familiare, i fattori socioambientali, nonché le spinte motivazionali (Paparelli, Di Forti, Morrison, e Murray, 2011).
Può essere però molto difficile operare una distinzione tra i sintomi che sono dovuti all’intossicazione da stupefacenti ed episodi psicotici non indotti dall’uso di sostanze.
Altri studi hanno dimostrato un’alta prevalenza di DUS nei Disturbi di Personalità (Van Den Bosch, Verheul, e Van Den, 2001). Siever e Kenneth (cit in Guareschi Cazzullo, Lenti, Musetti, e Musetti, 1995) definiscono la personalità come
costituita da quella distinta e persistente costellazione di comportamenti o tratti che caratterizzano il funzionamento sociale-relazionale ed occupazionale. Quando questi tratti o comportamenti o strategie sono maladattativi ciò costituisce un disturbo di personalità.
Da questa definizione si potrebbe intendere l’uso delle sostanze come una strategia di fronteggiamento: è costante il rilievo, nella raccolta accurata della storia dei nostri pazienti, di un uso di droghe a scopo adattativo.
Alcune ricerche si sono soffermate sulla relazione tra il disturbo borderline di personalità e il DUS: alcune impostazioni teoriche hanno sottolineato come l’utilizzo di sostanze serva a far fronte a un vuoto incolmabile che questi pazienti portano con sé (Correale, Alonzi, Carnevali, Di Giuseppe, e Giacchetti, 2001), altre come l’utilizzo di sostanze serve per placare un caos nelle emozioni e nella condotta divenuto ormai insopportabile (Linehan, 1993 (a), 1993 (b); Liotti, 2001).
Altri studi hanno accertato la forte correlazione tra il DUS e il disturbo antisociale di personalità. Tra le caratteristiche psicopatologiche nucleari del disturbo antisociale vi sono l’impulsività, l’irritabilità, l’aggressività. Un crescente numero di valutazioni retrospettive e di studi prospettici suggeriscono che la comparsa dei sintomi della personalità antisociale o della iperattività con deficit di attenzione (ADHD) avvenga in età antecedente all’inizio dell’impiego di sostanze (Luthar, Anton, Merikangas, e Rounsaville, 1992; Klein, e Manuzza, 1991) e potrebbe esse una fattore predisponente allo sviluppo del DUS. Infatti, alcune dimensioni psicopatologiche della personalità antisociale sono condivise dai soggetti abusatori di sostanze e determinano l’adozione di pattern comportamentali simili, quali l’avventatezza, l’irresponsabilità nelle azioni e nelle relazioni, l’incapacità di apprendere dall’esperienza, la tendenza ad ingannare, mentire, aggredire (Vassileva, Gonzalez, Bechara, e Martin, 2006). A questo si aggiunge anche la condivisione di altri fattori di rischio come il basso livello socioculturale, la storia familiare, spesso caratterizzata da abbandoni e abusi, e la provenienza, prevalentemente da aree urbane impoverite (Westermeyer, e Thuras, 2005).
ARTICOLO CONSIGLIATO:
La dipendenza da sostanze spiegata in un video
BIBLIOGRAFIA:
- Asher, C.J., e Gask, L. (2010). Reasons for illicit drug use in people with schizophrenia: Qualitative study. BMC Psychiatry, 10(94).
- Bakken, K., Landheim, S., e Vaglum, P. (2003). Primary and secondary substance misusers: do they differ in substance-induced and substance-independent mental disorders?. Alcohol and Alcoholism, 38, 54–59.
- Buckner, JD, Heimberg, RG, Ecker, AH, e Vinci C. (2013). A biopsychosocial model of social anxiety and substance use. Depress Anxiety, 30(3), 276-84.
- Clerici, M., Carrà, G., Segagni, G., Sciarini, P., Borrelli, P., Popa, I., et al. (2006). Studio epidemiologico sulla comorbilità tra disturbi mentali e disturbi correlati all’uso di sostanze (droghe e/o alcol) nei DSM italiani. Stato di aggiornamento della ricerca PADDI (Psychiatric and Addictive Dual Disorders in Italy Study, PADDI Study). Quaderni Italiani di Psichiatria, 25, 161-164. DOWNLOAD
- Correale, A., Alonzi, A.M., Carnevali, A., Di Giuseppe, P., e Giacchetti, N. (2001). Borderline: lo sfondo psichico naturale. Roma: Borla.
- De Quadro, J.R., Carpenter, C.F., e Tandor R. (2000). Patters of substance abuse in schizophrenia. Journal of Psychiatic Research, 28, 267-275.
- Evren, E.C., e Evren, B. (2003). Comorbidity of alcohol-substance use disorders in schizophrenia: a review. Turkish, 14(3), 213-24.
- Fontenelle, L.F., Oostermeijer, S., Harrison, B.J., Pantelis, C., e Yücel M. (2011). Obsessive-compulsive disorder, impulse control disorders and drug addiction: common features and potential treatments. Drugs, 7, 71(7), 827-40.
- Gandhi, D.H., Bogrov, M.U., Osher, F.C., e Myers, C.P. (2003). A comparison of the patterns of drug use among patients with and without severe mental illness. The American Journal on Addictions, 12, 424-431.
- Garofano, R., Barretta, V., Falco, P., e Auriemma, F. (2014). Rilevazione naturalistica delle patologie psichiatriche in un gruppo di soggetti afferenti ad un servizio per le dipendenze. Italian Journal on Addiction, 4(2).
- Guareschi Cazzullo, A., Lenti, C., Musetti, C., e Musetti, L., (1995). Processi mentali in età evolutiva. Modelli neuropsicologici e clinici, Milano: Francoangeli.
- Kessler, R.C., Aguilar-Gaxiola, S., Andrade, L., Bijl, R., Borges, G., Caraveo-Anduaga, J.J., Dewit, D.J, Kolody, B., Merikangas, K.R., Molnar, B.E., Vega, W.A., Walters, E.E., Wittchen, H.U., e Ustun, T.B. (2001). Mental-substance comorbidities in the ICPE surveys. Psychiatria Fennica, 32(2), 62-79.
- Klein, R.G., e Manuzza, S. (1991). Long-term outcome of hyperactive children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 30, 383-7.
- Linehan, M.M. (1993a). Cognitive- Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. New York: Guildford (trad. it. Trattamento cognitivo-comportamentale del disturbo borderline, Raffaello Cortina, Milano, 2001).
- Linehan, M.M. (1993b). Skills Training Manual for Treating Borderline Personality Disorder. New York.
- Liotti, G. (2001). Le opere della coscienza: Psicopatologia e Psicoterapia nella prospettiva cognitivo evoluzionista. Milano: Raffaello Cortina.
- Luthar, S.S., Anton, S.F., Merikangas, K.R., e Rounsaville, B.J. (1992). Vulnerability to substnce abuse and psychopathology among siblings of opioid abusers. The Journal of Nervous and Mental Disorder, 180, 153-61.
- McIntosh, C., e Ritson, B. (2001), Treating depression complicated by substance misuse, Advances in Psychiatric Treatment, 7, 357–364.
- Ogborne, A.C., Smart, R.G., Weber, T, e Birchmore-Timney, C. (2000) Who is using cannabis as a medicine and why: an exploratory study. Journal of Psychoactive Drugs, 32, 435-443.
- OMS (1995), Lexicon of alcohol and drug terms, Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra.
- Paparelli, A., Di Forti, M., Morrison, P.D., e Murray R.M. (2011). Drug-induced psychosis: how to avoid stargazing in schizophrenia research by looking at more obvious sources of light. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 5,1.
- Tournier, M., Sorbara, F., Gindre, C., Swendsen, J. D., e Verdoux, H. (2003). Cannabis use and anxiety in daily life: a naturalistic investigation in a non-clinical population. Psychiatry research, 118(1), 1-8.
- Van Den Bosch, L.M., Verheul, R., e Van Den, B.W (2001). Substance abuse in borderline personality disorder: clinical and etiological correlates. Journal of Personal Disorder, 15, 416–424.
- Vassileva, J., Gonzalez, R., Bechara, A., e Martin, E.M. (2007). Are all drug addicts impulsive? Effects of antisociality and extent of multidrug use on cognitive and motor impulsivity. Addictive Behaviors, 32(12), 3071-6.
- Westermeyer, J., e Thuras P., (2005). Association of antisocial personality disorder and substance disorder morbidity in a clinical sample. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse,31(1), 93-110.
- Zammit, S., Moore, T.H., Lingford-Hughes, A., Barnes, T.R., Jones, P.B., Burke, M., e Lewis G. (2008). Effects of cannabis use on outcomes of psychotic disorders: systematic review. British Journal of Psychiatry, 193(5), 357-63.
- Zvolensky, M.J., Cougle, J.R., Johnson, K.A., Bonn-Miller, M.O., e Bernstein, A. (2010). Marijuana use and panic psychopathology among a representative sample of adults. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 18(2), 129-34