La Terapia Metacognitiva Interpersonale alle Olimpiadi – Psicologia dello Sport
Vittoria Galasso

Olimpiadi 2012: Molti atleti dei diversi team nazionali sono stati accompagnati dal proprio mental coach. Ed anche io ero tra questi.
LEGGI GLI ARTICOLI SULLA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Le Olimpiadi di Londra 2012 sono un’esperienza ormai compiuta, per i protagonisti e per gli spettatori. Un caleidoscopio di emozioni, colori e sensazioni che fanno parte dei ricordi di tutti coloro che in qualche modo vi hanno preso parte. Parliamo di Olimpiadi, ovviamente, di quell’imponente giostra carica di ritualità e di imprevisti che anima lo scenario sportivo internazionale ogni quattro anni. E gli psicologi? Come al solito non sono stati a guardare! Molti gli atleti dei diversi team nazionali sono stati accompagnati dal proprio mental coach. Ed anche io ero tra questi. Una grande opportunità giunta a coronamento di quella che ormai è una lunga collaborazione con il CONI.
Questa esperienza è stata l’occasione per sperimentare un protocollo di intervento nato dalla fusione tra la psicologia dello sport e la Terapia Metacognitiva Interpersonale.
Questo approccio è nato da una estemporanea esigenza: quali strumenti dell’agire psicologico utilizzare quando l’atleta è chiaramente portatore di una sofferenza soggettiva, riconducibile a specifiche caratteristiche di personalità che, pur riverberando nella prestazione, non ha in essa la sua sola origine o possibilità di risoluzione? È questo l’interrogativo che si è andato definendo nella mia mente all’incirca due anni fa all’inizio di questa avventura, quando mi sono trovata a dover intervenire su di un atleta che, pur provenendo da innumerevoli successi internazionali, sembrava, a seguito di una serie di eventi personali e sportivi, non riuscire più ad ingranare le marce per compiere delle scelte gratificanti.

“La prestazione prima di tutto!” È questo l’imperativo a cui mirare… ma questa volta era diverso. A non funzionare non era più solo la prestazione. L’Olimpiade non era poi così lontana e l’assessment iniziale aveva chiaramente lasciato emergere caratteristiche di personalità tali da non poter essere ignorate nella formulazione dell’intervento. Se infatti la prestazione sportiva è frutto dell’integrazione tra aspetti psicologici e fisiologici, tralasciare gli elementi di sofferenza soggettiva emersa, sarebbe equivalso ad invalidare la possibilità di accedere con successo, anche se solo in un secondo momento, al programma di allenamento mentale.
Perfezionismo, bassa autostima, alessitimia sono di fatto elementi ricorrenti nell’organizzazione di personalità degli atleti di alto livello e, di frequente , essi stessi attivatori dell’impegno agonistico. Quando però sopraggiungono fattori stressanti, come ad esempio l’esposizione protratta alla dinamica agonistica, questi stessi aspetti possono tradursi in elementi di rischio psicopatologico capace di determinare quadri sintomatologici che richiedono interventi terapeutici specifici, come quello TMI. L’atleta in questione presentava caratteristiche che motivavano un intervento di questo tipo.
LEGGI GLI ARTICOLI DI PSICOLOGIA DELLO SPORT
Emergevano nel colloquio emozioni intense e dolorose, unitamente ad una assoluta difficoltà di gestione delle stesse, con conseguente percezione di inefficacia personale. La vita di relazione risultava guidata da schemi impliciti che lo costringevano a reiterare dinamiche stereotipate.
Le capacità metacognitive erano fortemente sollecitate dall’impegno sportivo ma decisamente compromesse: gli veniva richiesto di organizzare il proprio comportamento in vista della meta (le olimpiadi), impegnando capacità di ragionamento finalizzate alla definizione di obiettivi, al compimento delle scelte, alla formulazione delle valutazioni. Il comportamento doveva essere costantemente monitorato ed adeguato all’andamento dell’allenamento e delle gare, gestendo nel contempo il proprio stato psicoemotivo e gli aspetti relazionali. Promuovere, attraverso gli interventi terapeutici, il processo di riflessione su di sé , avrebbe consentito di focalizzare l’attenzione sui fattori capaci di favorire il funzionamento, accrescendo anche la consapevolezza su quanto provoca disagio. Il lavoro sulle abilità metacognitive avrebbe poi consentito di intervenire sugli aspetti relazionali (particolarmente critici all’inizio dell’intervento), agevolando il potenziamento di quelle capacità che permettono di capire gli altri (compagni, avversari, allenatore, dirigenti sportivi), a tutto vantaggio dell’organizzazione strategica del proprio comportamento in gara e non solo (consapevolezza dei punti di forza e di debolezza di compagni e avversari).
Alla luce di queste riflessioni iniziali si è dunque proposto all’atleta di avvalersi di un intervento gerarchicamente organizzato e sdoppiato in due momenti diversi. Ottenuta la piena condivisione e in un clima di collaborazione, il programma ha avuto avvio, con sedute settimanali, compatibilmente con le disponibilità legate alle trasferte.
Settimana dopo settimana si è giunti a conclusione del primo anno con la piena convinzione che si fossero ormai definite le condizioni necessarie e sufficienti ad implementare il secondo modulo: il lavoro sul campo. L’atleta aveva sviluppato strategie efficaci per la gestione delle emozioni dolorose e andava acquisendo consapevolezza dei propri schemi. La psicoterapia andava avanti, mentre le tecniche di mental training cominciavano ad essere strutturate in un programma di allenamento sistematico affidato ad una collega.
LEGGI GLI ARTICOLI SU: ATTIVITA’ FISICA
Da lì a poco la qualifica olimpica. E poi una lunga cavalcata fino alla gara! A pochi giorni dall’evento la richiesta esplicita da parte dell’atleta: la presenza del nostro team di lavoro a Londra! L’obiettivo dichiarato e condiviso era quello di affrontare la gara con le condizioni mentali ottimali. I colloqui sarebbero serviti in quei giorni, oltre che a contenere l’ansia, ad agevolare il rapporto con l’allenatore (vera figura chiave di un pregara olimpico), attraverso interventi terapeutici che sostenessero l’atleta nel suo processo di lettura delle dinamiche relazionali. In questi frangenti di massima tensione, ogni particolare può diventare importante e una difficoltà con il proprio coach può essere cruciale … e poi a Londra ci si era arrivati tutti insieme e tutti insieme dovevamo gareggiare, così esclamò l’atleta nel fare la sua richiesta: e olimpiade fu!

Di sicuro, un’esperienza particolare nel suo genere, proprio perché il lavoro con gli atleti di alto livello pone agli psicologi interrogativi assolutamente peculiari, tra il bisogno di favorire le prestazioni e la consapevolezza di esistenze spesso schiacciate tra sacrifici da palestra e luci dei riflettori. In tale contesto l’intervento di Terapia Metacognitiva Interpersonale sembra riuscire ad incidere sia su un piano strettamente individuale (favorendo la consapevolezza e la capacità di descrizione del proprio mondo interiore) che su quello relazionale (agevolando la capacità di comprensione di ciò che gli altri pensano e sentono). Sul piano individuale, dunque, un atleta che necessiti di un simile intervento avrà modo di riscoprire scopi e desideri personali laddove questi risultano spesso celati da una motivazione agonistica frequentemente mediatrice di bisogni relazionali di altra natura. Il miglioramento sul piano relazionale riverbera subito nel rapporto con l’allenatore ed i compagni a tutto vantaggio della prestazione.
Il cantiere di Olimpia 2016 è ormai già aperto. Dopo qualche settimana di riposo il mondo dello sport si riorganizza silenziosamente in vista della nuova meta. Speriamo di esserci, e buon viaggio a tutti!
LEGGI GLI ARTICOLI SULLA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
LEGGI GLI ARTICOLI DI PSICOLOGIA DELLO SPORT
LEGGI GLI ARTICOLI SU: ATTIVITA’ FISICA
BIBLIOGRAFIA:
- Butler, R.J. (1998). Psicologia e Attività Sportiva. Guida pratica per migliorare la prestazione. Ed Italiana a cura di M. Pirritano. Il Pensiero Scientifico Editore.
- Cei, A. (1987). Mental training. Pozzi Editore.
- Dimaggio, G., & Semerari, A. (2003). I disturbi di Personalità. Modelli e trattamento. Editori Laterza.
- Dimaggio, G. & Lysaker, P.H. (2011). Metacognizione e psicologia. Valutazione e trattamento. Milano: Raffaello Cortina.




 Solo poche righe sull’orrenda storia del bambino trascinato via dalla scuola. Dove sicuramente non abbiamo tutti gli elementi per farci un’opinione, ma dove di certo sono stati commessi errori da parte delle forze dell’ordine.
Solo poche righe sull’orrenda storia del bambino trascinato via dalla scuola. Dove sicuramente non abbiamo tutti gli elementi per farci un’opinione, ma dove di certo sono stati commessi errori da parte delle forze dell’ordine.


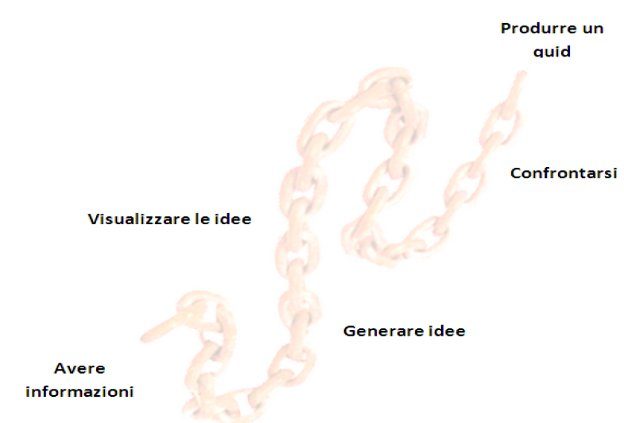

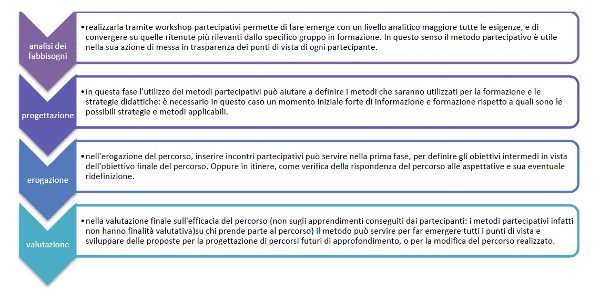


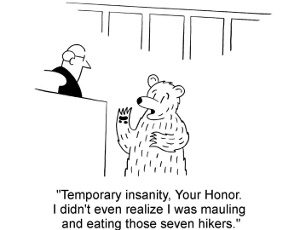 Cosa si intende per sanità mentale (sotto il profilo penale) e cosa accade al criminale, se viene dichiarato non imputabile?
Cosa si intende per sanità mentale (sotto il profilo penale) e cosa accade al criminale, se viene dichiarato non imputabile? 


 Direttamente dal XVI Congresso Nazionale SITCC, State of Mind intervista in esclusiva Bruno Bara.
Direttamente dal XVI Congresso Nazionale SITCC, State of Mind intervista in esclusiva Bruno Bara.
 Informare il paziente può nuocere gravemente alla salute.
Informare il paziente può nuocere gravemente alla salute.
