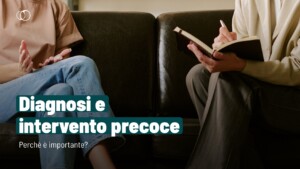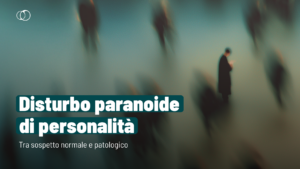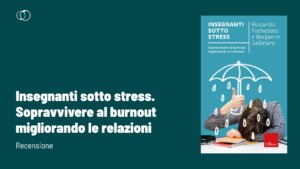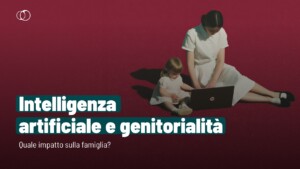L’utilizzo della mindfulness nel trattamento delle dipendenze patologiche
Francesca Mazzocco, Claudia Soldi, OPEN SCHOOL STUDI COGNITIVI
Questo lavoro mira ad integrare i due costrutti “Mindfulness” e “Addiction”, come chiave per comprendere i modelli neuropsicologici che si basano sull’addiction e gli interventi psicoterapeutici che derivano da essi.
A tal proposito l’apporto dei processi di mindfulness è cruciale sia da un punto di vista teorico e sia da un punto di vista applicativo in alcuni recenti approcci psicoterapeutici, tra cui ad esempio la Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), l’Acceptance and Commitment Therapy (ACT) e la Functional Analytic Psychotherapy (FAP).
Tutti i modelli terapeutici che includono i processi di mindfulness, hanno come scopo principale quello di portare la persona a modificare alla radice il rapporto con le proprie esperienze interne ed in generale.
L’obiettivo è quello di sviluppare l’abilità di ognuno di noi, di osservare la propria esperienza mentre accade e non solo quella di esserne il soggetto, il protagonista e l’attore.
Questa capacità del sé di osservarsi in azione in modo non giudicante e non orientato a modificare in alcun modo ciò che si sta osservando, crea quello spazio, quel decentramento necessari a perseverare nelle proprie scelte e nei propri comportamenti anche in presenza di esperienze di vita dolorose e spaventose. Da qui l’emergere di modelli psicologici che si fondano sulla constatazione dell’ubiquità della sofferenza umana e della conseguente impossibilità di liberarsene o di risolverla, stimolando lo sviluppo e l’applicazione in ambito terapeutico di principi e metodi profondamente radicati nella psicologia orientale, con l’esigenza di integrare diversi approcci valorizzando quelle componenti innate della natura umana, decisive nell’influenzare la lettura degli eventi, i comportamenti e gli stati emotivi dell’individuo.
Tali componenti possono essere individuate nell’accettazione dell’esperienza (Hann, 1998; Hayes, Strosahl, Wilson 1999), nell’atteggiamento compassionevole verso la propria e altrui sofferenza (Gilbert, 2005), nella capacità di auto-osservazione non giudicante (Kabat-Zinn, 1990), nell’idea che la mente può osservare se stessa e comprendere la propria natura (Dalai Lama, Benson, Thurman, Goleman e Gardner, 1991).
La capacità peculiare di tali componenti è quella di dirigere l’attenzione verso la sfera emotiva e verso il rapporto di interdipendenza e reciproca influenza tra mente e corpo (Goleman, 1991), e più in generale in un atteggiamento capace di armonizzare e normalizzare le variabili intra e interpersonali.
Tutte queste componenti possono essere riassunte nel concetto di mindfulness.
La mindfulness consiste quindi nella capacità di sviluppare e mantenere un’attenzione consapevole, non è una tecnica di rilassamento, bensì una pratica per sviluppare l’attenzione volontaria.
Secondo la definizione di Joan Kabat-Zinn (1990), mindfulness significa [blockquote style=”1″]Porre attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo non giudicante.[/blockquote] Si tratta quindi di stato mentale correlato a particolari qualità dell’attenzione e della consapevolezza, in cui la persona ascolta e osserva le proprie emozioni, le proprie sensazioni fisiche e i propri pensieri, accettandoli così come sono, senza giudicarli, senza cercare di modificarli, né bloccarli.
La pratica della mindfulness si propone quindi, di aiutare a sostituire nella vita quotidiana comportamenti reattivi, automatici e distruttivi con scelte consapevoli e appropriate al contesto.
La mindfulness, nella concezione più generale del termine, propone un modo di essere consapevoli, che può servire come via d’accesso a un modo più vitale di essere nel mondo; in pratica, imparando ad essere mindful, riusciremo a sintonizzarci con noi stessi: [blockquote style=”1″]Essere consapevoli della pienezza della nostra esperienza ci rende consapevoli del mondo interno della nostra mente e ci immerge completamente nella nostra vita[/blockquote] (Siegel, 2009).
La mindfulness non cambia i contenuti della nostra mente (pensieri) ma le nostre relazioni con essi e si presenta come uno strumento che può essere integrato ad una terapia.
Come afferma Kabat-Zinn (1990), infatti i pensieri sono solamente pensieri, non rappresentano la realtà; la consapevolezza che noi non siamo i nostri pensieri porta al distanziamento da essi e alla possibilità di entrarci in relazione per quello che in realtà sono: semplici eventi mentali, indipendentemente dal loro contenuto o dalla loro carica emotiva.
In ambito clinico, la mindfulness rientra negli orientamenti terapeutici della cosiddetta terza onda della terapia cognitivo-comportamentale ed è stata sviluppata in una serie di protocolli molto efficaci per affrontare e superare il dolore cronico e lo stress, le recidive depressive, le ricadute nella dipendenza da alcool e sostanze (in cui focalizzeremo l’attenzione), e nei disturbi alimentari (MBSR- MindfulnessBased Stress Reduction; MBCT- MindfulnessBased Cognitive Therapy: MBRP- MindfulnessBased Relapse Preention; MB-EAT- MinfulnessBasedEatingAwareness Training).
Le dipendenze (Addictions)
La dipendenza comporta l’uso di sostanze, che a loro volta creano uno stato alterato di coscienza, con una modalità compulsiva e distruttiva che induce a ricercare il piacere ed evitare il dolore (il paradigma della fuga).
Quindi, se la dipendenza implica mancanza di consapevolezza e fuga, di conseguenza l’essenza della cura è un approccio che mira ad aiutare la persona a ricordare, ad aumentare la consapevolezza e la capacità di sperimentare la vita con lucidità senza evadere. La mindfulness è proprio questo genere di pratica, è l’essere aperti all’esperienza momento per momento in modo non giudicante, e il ruolo del terapeuta è proprio quello di favorire un cambiamento nella consapevolezza e di rendere più evidenti le conseguenze negative dell’uso di sostanze. Il tipo di consapevolezza richiesta varia a seconda delle fasi di cambiamento.
Prochaska e Di Clemente (1986) hanno svolto un’analisi dei fattori riguardanti le fasi attraverso le quali si passa per cambiare un comportamento che crea dipendenza e successive ricerche hanno scoperto che è possibile tracciare queste fasi non solo nelle dipendenze, ma in ogni genere di cambiamento nel comportamento umano. Nel modello completo a sei fattori le fasi sono: pre-contemplazione (significa non-consapevolezza, in questa fase la persona semplicemente non sa che c’è un problema, non si tratta di negazione, poiché quest’ultima indica che il problema esiste ma che l’individuo si rifiuta di riconoscerlo); contemplazione (la persona è impegnata in un dialogo interiore per scoprire se il problema è reale o meno); determinazione (in questa fase la persona è pronta per il cambiamento, e per passare alla fase successiva, deve percepire che ci sono possibilità che rendono possibile il cambiamento); azione (in cui la persona compie i passi concreti richiesti dal cambiamento); mantenimento (rappresenta la fase più difficile e significativa, prevedere situazioni difficili che possono emergere, es. una festa di nozze in cui si possono trovare alcolici); ricaduta (quando le persone non riescono a modificare al primo tentativo i comportamenti che creano dipendenza). Per questo è importante che il terapeuta conosca bene le fasi in cui il paziente si trova in modo da offrirgli le terapie appropriate.
Volkow, (2007) definisce la tossicodipendenza una malattia complessa ma curabile, che colpisce le funzioni cerebrali e modifica il comportamento. L’uso di droghe altera la struttura e le funzioni cerebrali provocando cambiamenti che persistono nel tempo, anche dopo l’interruzione dell’uso, oltre ad esporre le persone al rischio di sviluppare numerosi altri disturbi fisici e mentali legati agli effetti tossici della droga stessa.
Proprio perché la tossicodipendenza coinvolge così tanti aspetti della vita personale di un individuo, non esiste un unico trattamento efficace in assoluto. Le nuove scoperte scientifiche nel campo del neuroimaging ci mostrano l’efficacia di nuove terapie farmacologiche e comportamentali, per la dipendenza.
I pazienti che abusano di sostanze ricevono generalmente un trattamento psicoterapico al fine di:
• ottenere una modifica comportamentale nei confronti dell’uso di sostanze;
• affrontare le patologie correlate all’uso di sostanze, come depressione, ansia, disturbi post-traumatici da stress (PTSD) e disturbi di personalità.
Sebbene, ad oggi, molte ricerche si siano focalizzate sul trattamento farmacologico (Koob GF, 2000), recenti studi hanno scoperto che mirare a specifiche disfunzioni neurobiologiche, utilizzando tecniche di trattamento cognitive e comportamentali, può rivelarsi importante anche nella prevenzione delle ricadute (DeVito EE et al., 2012; FeldsteinEwing SW et al., 2011; Goldstein RZ et al., 2009; Naqvi NH &Bechara A, 2010; Potenza MN et al., 2011; Volkow ND et al., 2010).
Potenza e colleghi (2011), nella loro revisione dei meccanismi neurali che potrebbero essere alla base dei trattamenti per la dipendenza, suggeriscono che i trattamenti comportamentali potrebbero essere più efficaci nel cambiamento della corteccia prefrontale e del funzionamento esecutivo (ad esempio, i processi top-down), mentre gli interventi farmacologici sembrano essere più efficaci nel cambiamento dei circuiti striatali della ricompensa (ad esempio, i processi bottom-up). Coerentemente con queste ipotesi, Volkow e colleghi (2010) hanno addestrato delle persone con dipendenza da cocaina ad inibire intenzionalmente le risposte al craving per la cocaina, e utilizzando la PET, hanno trovato che l’inibizione cognitiva attiva del craving per la droga era associato con diminuita attività metabolica nel nucleo accumbens e nella corteccia orbitofrontale mediale destra, rispetto ad un gruppo che non doveva cercare di inibire il craving per la sostanza.
Secondo questi autori, interventi cognitivi progettati per rafforzare il controllo inibitorio e diminuire l’impulsiva ricerca della droga in risposta a stimoli correlati ad essa, possono essere utili nel trattamento della dipendenza.
In un altro studio, Janes e colleghi (2010) hanno utilizzato la fMRI per esaminare le risposte di 21 donne fumatrici ad immagini legate al fumo rispetto a immagini neutre. Successivamente hanno condotto sondaggi di follow-up durante 8 settimane di un intervento comportamentale e farmacologico per smettere di fumare. Coloro che hanno continuato a fumare sigarette durante le 8 settimane di trattamento, hanno mostrato un aumento della risposta BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) agli stimoli legati al fumo, al momento della valutazione iniziale, nell’insula, nell’amigdala, nell’ACC, nella corteccia prefrontale e in numerose altre aree. Le analisi della connettività funzionale inoltre, hanno rivelato una diminuita connettività funzionale tra le regioni della corteccia prefrontale e l’ACC e l’insula, suggerendo che chi fumava una sigaretta avrebbe potuto mostrare un minor controllo top-down ed una maggior consapevolezza enterocettiva bottom-up degli stimoli fumo-correlati.
Questo pensiero si allinea con quello di Goldstein e colleghi (2009), i quali hanno proposto che un training cognitivo per migliorare la consapevolezza di sé e ridurre i bias attenzionali verso gli stimoli della droga possa aiutare a prevenire le ricadute. Witkiewitz e colleghi (2012) ipotizzano che un trattamento basato sulla mindfulness, una nuova tecnica cognitivo-comportamentale basata sulla consapevolezza, possa essere ideale per mirare a ciascuna di queste aree. La Mindfulness-based Relapse Prevention (MBRP) è una tecnica cognitivo-comportamentale per la prevenzione delle ricadute nei pazienti tossicodipendenti (Witkiewitz K et al., 2012).
Un gruppo di ricercatori della Washington State University ha da poco pubblicato una revisione della letteratura sugli studi che hanno utilizzato questa tecnica nella fase post-terapeutica del percorso di disintossicazione, per indagarne i possibili meccanismi neurobiologici sottostanti. I più forti predittori di recidiva nei pazienti tossicodipendenti sono il craving e l’affettività negativa. Il primo è definito come spinta e desiderio soggettivo di consumare sostanze stupefacenti, la seconda rappresenta la disposizione individuale a sperimentare stati emotivi avversi, che si accentua nei periodi particolarmente stressanti. È per questo che la maggior parte dei trattamenti contro la dipendenza da sostanze stupefacenti si concentra sulla riduzione del desiderio di assumere sostanze e sulla gestione dello stress. Si ritiene che il motivo delle ricadute possa essere collegato ad un deficit funzionale nel sistema prefrontale di controllo esecutivo (top-down), nel circuito della gratificazione striatale ventrale (bottom-up) oppure nel circuito di apprendimento delle abitudini dello striato dorsale.
Secondo gli autori, le evidenze che emergono dalla metanalisi suggeriscono che la MBRP influenza e modifica in maniera efficace i processi automatici (bottom-up): il sistema di risposta allo stress, il sistema di reattività emozionale (compresi l’insula, la corteccia cingolata anteriore e l’amigdala) ed il comportamento di ricerca automatica della droga (che coinvolge lo striato). In sinergia con interventi comportamentali mirati, la pratica della mindfulness è associata anche al potenziamento dei processi top-down (funzionamento esecutivo, controllo cognitivo, regolazione dell’attenzione e delle emozioni, controllo inibitorio, motivazione e decision-making) attraverso cambiamenti nella corteccia prefrontale dorsolaterale, ventromediale, nella corteccia orbitofrontale, nell’ippocampo e nell’insula. Sebbene, ad oggi molte ricerche si siano focalizzate sul trattamento farmacologico (Koob GF, 2000), tali studi hanno mostrato che mirare a specifiche disfunzioni neurobiologiche, utilizzando tecniche di trattamento cognitive e comportamentali, può rivelarsi importante anche nella prevenzione delle ricadute (De Vito EE et al.,2012; Feldstein Ewing SW et al., 2011; Goldstein RZ et al., 2009; Naqvi NH & Bechara A, 2010; Potenza MN et al., 2011; Volkow ND et al., 2010).
Mindfulness & Dipendenze, la prevenzione delle ricadute: Mindfulness Based Relapse Prevention
Il programma MBPRP (Mindfulness Based Relapse Prevention) basato sulla mindfulness si sviluppa per la prevenzione delle ricadute nella tossicodipendenza. I Disturbi da uso di sostanze sono condizioni croniche recidivanti dove quindi la ricaduta ne caratterizza il decorso. In particolare si manifesta il craving cioè un desiderio intenso di assumere una sostanza psicotropa i cui effetti sono già stati sperimentati in precedenza, dove generalmente si intrecciano ricerca del piacere ed evitamento del dolore. In tutti i differenti interventi la ricaduta rimane un problema cruciale presente in più della metà dei soggetti. La prevenzione alla ricaduta è quindi la sfida più importante nei trattamenti per le tossicodipendenze.
La peculiarità di questo programma terapeutico risulta quindi essere la combinazione fra pratica meditativa e modello RP (Relapse Prevention) cioè un intervento cognitivo-comportamentale volto a prevenire e gestire le ricadute.
Come riportato precedentemente i modelli di trattamento basati sulla mindfulness condividono l’obiettivo principale di modificare alla radice il rapporto con la propria esperienza, in particolare con quella interna, sviluppando le abilità di osservarla proprio mentre accade. Questo dovrebbe aiutare a trovare uno spazio per mentalizzare i propri bisogni e stati di sofferenza. La mindfulness vuole aiutare a sviluppare la possibilità di non reagire automaticamente o inconsapevolmente, essa può essere considerata la via d’uscita dal nostro stato di trance quotidiano dove siamo in balia di condizionamenti consci ed inconsci, abituali ed automatici.
Il programma MBRP si svolge in gruppo ed è mirato sull’esperienza diretta al fine di riflettere lo scopo centrale della mindfulness: osservare quello che sta succedendo nel momento invece che perdersi in interpretazioni e storie raccontate. Nelle diverse sessioni viene dato rilievo alle sensazioni corporee, ai pensieri ed alle emozioni e per questo i partecipanti vengono spesso spronati a tornare all’esperienza immediata. Con la mindfulness si tenta di gestire craving ed impulsi osservandoli e senza farsi travolgere dentro. La mindfulness, infatti, vuole aiutare questi pazienti a vedere le cose per come sono: riconoscere, sentire e accettare il disagio quando si manifesta e cercare di comprenderlo invece che rifuggirlo. Si mira inoltre a fornire strumenti su come far fronte alle ricadute: se l’individuo acquisisce nuove strategie di coping nelle situazioni stressanti, il senso di autoefficacia viene potenziato e le probabilità di ricaduta si riducono.
Nel programma i partecipanti si mettono in gioco in prima persona riportando situazioni di potenziale difficoltà e rischio, da questi racconti si identificano quindi stimoli e situazioni che rendono particolarmente vulnerabili i partecipanti e si identificano successivamente insieme abilità concrete da usare in queste occasioni.
La mindfulness aiuta in quanto favorisce un più ampio senso di scelta, compassione e libertà. L’obiettivo di queste pratiche è incrementare la consapevolezza dei segnali e delle reazioni automatiche, sviluppare una nuova relazione con queste esperienze e favorire l’apprendimento di strategie pratiche da utilizzare in situazioni ad alto rischio. Riprendendo una metafora del programma si mira ad imparare a “cavalcare l’onda del craving senza esserne travolti”. Qui è quindi utile accettare craving e desideri in modo da poterli esplorare, osservare e successivamente gestire in modo da incrementare il senso di autoefficacia.
La ricaduta viene quindi vista come un evento comune e considerata come un’opportunità di apprendimento piuttosto che un fallimento. Il fallimento viene infatti visto come autoaccusa e senso di colpa esponendo il soggetto ad un rischio maggiore di ricaduta.
Tramite gli esercizi di mindfulness si vuole aiutare il paziente affetto da dipendenza da sostanze a prendere coscienza del ventaglio di scelte a sua disposizione uscendo quindi dalla “trappola mentale” della dipendenza. Questo permette di uscire dagli schemi mentali e dalle reazioni automatiche.
Il programma è rivolto a soggetti già in astinenza dalle sostanze, in particolare si tratta di un programma ambulatoriale di aftercar per consolidare i risultati ottenuti. Prima del gruppo si svolgono brevi colloqui individuali coi partecipanti per conoscenza e per sviluppare l’alleanza terapeutica, viene spiegato il protocollo ed indagata la motivazione.
Il programma viene svolto in gruppi di circa 6-12 partecipanti e consiste in un gruppo chiuso. Esso consiste in otto sessioni a cadenza settimanale della durata di circa due ore l’una. Il setting ideale deve avere tappetini, cuscini e pouff in modo da permettere di sedersi sul pavimento comodamente.
Il clinico che conduce il protocollo deve avere esperienze di mindfulness, questo perché la propria esperienza personale rende maggiormente in grado di supportare le altre persone nella pratica.
Ogni incontro inizia con un momento di meditazione per promuovere maggiore consapevolezza e presenza e termina distribuendo le schede dei compiti. Ogni settimana vengono infatti dati dei compiti da svolgere a casa i quali vengono poi usati come materiale nelle sessioni successive. Durante le sessioni è molto importante rivedere i compiti svolti a casa e chiarire eventuali dubbi e difficoltà. Spesso capita infatti che aver vissuto sentimenti di malessere durante la pratica venga letto come un aver svolto male la pratica perché in automatico viene vista come qualcosa che deve essere piacevole e rilassante. La mindfulness invece vuole creare consapevolezza ed uno spazio per ogni esperienza incluso malessere e stress e spesso la fatica è più nel tentativo di controllare questi aspetti che viverli.
Le otto sessioni sono così suddivise:
Nelle prime tre sessioni si lavora sulla pratica della consapevolezza e sulla sua integrazione nella quotidianità.
Nelle tre sessioni centrali si mira all’accettazione dell’esperienza presente e all’applicazione nella prevenzione della ricaduta.
Nelle ultime due sessioni si estende la pratica a questioni legate alla cura del sé, alla rete di supporto ed a uno stile di vita equilibrato.
Dal punto di vista della ricerca l’approccio è di tipo evidence-based. Studi sottolineano che soggetti che svolgono questo programma hanno livelli inferiori di craving o abuso di sostanze in risposta a stati affettivi negativi (Witkiewitz, lustyk, Bowen 2012). Risultati di uno studio indicano una significativa diminuzione del craving, incremento dell’accettazione e tendenza ad agire con consapevolezza (Bowen, Chawla, Collins, 2009).
Le sessioni del programma Mindfulness Based Relapse Prevention
SESSIONE 1 – PILOTA AUTOMATICO E RICADUTA
Nella prima sessione si affronta il tema del “pilota automatico”: l’azione senza consapevolezza. Si vuole infatti introdurre ai soggetti il concetto che quotidianamente agiamo con il “pilota automatico”, tuttavia è possibile imparare a discriminare fra modalità automatica e consapevolezza per giungere ad osservare cosa accade nella mente e nel corpo senza reagire in modo automatico. Successivamente si discute il nesso tra pilota automatico e ricaduta in quanto davanti a craving ed impulsi la reazione è spesso da “pilota automatico”. Il primo esercizio viene quindi definito “esercizio dell’uvetta” e consiste nell’osservare e poi mangiare consapevolmente un singolo acino d’uva al fine di introdurre il coinvolgimento consapevole ed osservarne tutti i pensieri e sensazioni che spesso trascuriamo. Il conduttore deve mostrarsi abile nel riportare costantemente l’attenzione sull’esperienza presente in quanto frequentemente vi saranno deviazioni su altri pensieri o reazioni. Questo continuo riportare all’esperienza diretta deve anche essere utilizzato per favorire l’attenzione sulla tendenza della mente a vagare altrove e sulla necessità di riportarla al momento presente. Dopo questo esercizio si invitano i partecipanti a presentare altre situazioni della loro vita in cui hanno agito con il pilota automatico.
Successivamente il conduttore porta l’esercizio nel contesto della ricaduta: “Perché stiamo facendo questo esercizio nell’ambito di un programma di prevenzione alla ricaduta?”. Qui uno degli strumenti proposti per lavorare nel gruppo e a casa è il Body-scan tramite il quale si prende consapevolezza di tutte le sensazioni che proviamo nel corpo. Fondamentale risulta quindi poi il concetto che il craving e gli impulsi spesso si manifestano anche attraverso correlati fisici.
Alla fine della prima sessione bisogna rimandare l’importanza della pratica a casa in quanto il cuore della pratica è l’esercizio quotidiano. Dopo questa prima sessione un compito a casa può essere applicare la stessa attenzione e consapevolezza che abbiamo applicato all’esercizio dell’uvetta su un’altra azione che generalmente svolgiamo in modo automatico e praticare con costanza il body scan. Può essere utile suggerire la compilazione di un diario.
SESSIONE 2 – CONSAPEVOLEZZA DEGLI EVENTI SCATENANTI E DEL CRAVING
In questa sessione si lavora sul riconoscimento degli eventi scatenanti. Gli eventi scatenanti spesso portano infatti ad una concatenazione automatica di pensieri ed azioni dove la mindfulness dovrebbe creare uno spazio di pausa in questa concatenazione automatica. A tal fine viene proposto l’”Esercizio della passeggiata in strada” dove lo scopo è permettere ai partecipanti di osservare la risposta iniziale della mente ad uno stimolo ambiguo e riconoscere la cascata di pensieri, emozioni e sensazioni fisiche prodotte da questo. Nello scenario si rivive una situazione di una persona in lontananza che ci sembra di conoscere e vorremmo salutare ma la persona non ricambia il saluto. In seguito a questo scenario presentato con poche parole ed in modo vago i partecipanti descrivono ogni pensiero o emozione che attraversi la loro mente. Facendo l’esercizio i partecipanti diventano consapevoli delle proprie reazioni e delle diverse reazioni di ognuno, di come gli eventi siano spesso interpretati e della concatenazione di reazioni che scatenano. Da questo esercizio dovrebbero apprendere come le interpretazioni non sempre coincidono con la verità e come possono causare un comportamento reattivo dovuto a pensieri ed emozioni.
Come secondo esercizio viene proposto “l’Esercizio del surf dell’impulso”: vivere il craving non più con timore ma con curiosità e gentilezza. A fronte di un episodio di forte craving del soggetto nel raccontarlo lo si invita a rivedere la concatenazione scatenata. Nel ripercorrere questo episodio di craving i partecipanti vengono invitati ad usare la stessa attenzione usata nell’esercizio dell’uvetta o in quello del body scan.
Questo è un esercizio cruciale del protocollo, riuscire a fermarsi senza farsi travolgere dal craving ed osservare cosa accade. “Cavalcare il craving” viene proposto in questo esercizio come un modo per restare presenti all’intensità del craving senza rimanerne sopraffatti o comportarsi reattivamente. Ai partecipanti viene chiesto di immaginare l’impulso come un’onda dell’oceano e se stessi mentre praticano il surf, usando il respiro come una tavola da surf per cavalcare l’onda. Vengono successivamente discusse sensazioni fisiche spesso descritte come intollerabili ed intenso desiderio di mascherare uno stato emotivo. Viene poi spiegato che il craving non è una linea che sale sempre di più di intensità ma come un’onda raggiunge l’apice per poi scendere.
SESSIONE 3 – MINDFULNESS NELLA VITA QUOTIDIANA
Durante la sessione, a seguito di una fase di apertura, viene svolto un compito di consapevolezza dell’ascolto: imparare ad uscire dal pilota automatico per focalizzarsi con attenzione sull’attività che stiamo svolgendo. Il compito viene svolto prevalentemente da seduti, bisogna stare nel momento presente anche se la mente tenderà a divagare, accettare ed osservare la cosa per poi riportare con gentilezza al momento presente.
La vera pratica tuttavia consiste nel riuscire a portare questa conoscenza nella vita quotidiana e per questo nell’esercizio successivo viene proposta la tecnica della respirazione SOBER (Stop, Observe, Breath, Expand, Respond). È una delle pratiche quotidiane più utili in situazioni di alto rischio o stressanti. In queste situazioni tendiamo ad adottare il pilota automatico e comportarci in modo contrario al nostro interesse, serve quindi maggiore consapevolezza delle nostre reazioni.
La tecnica SOBER si sviluppa in questo modo:
Stop: fermarsi e sganciare il pilota automatico
Observe: osservare mente e corpo in questo momento
Breath: spostare l’attenzione concentrandosi sul respiro
Expand: espandere quello che viviamo con il respiro alle sensazioni di tutto il corpo
Respond: rispondere con consapevolezza
SESSIONE 4 – MINDFULNESS NELLE SITUAZIONI AD ALTO RISCHIO
Nei precedenti esercizi ci si è preparati a portare la mindfulness nella vita di tutti giorni e questo diventa l’aspetto centrale di questa sessione: in particolare si vuole inserire la mindfulness all’interno delle aree o delle situazioni più difficili che tendono a elicitare comportamenti reattivi.Il passaggio che caratterizza la quarta sessione è riuscire a gestire con consapevolezza situazioni che in passato sono state associate all’uso di sostanze o altre componenti reattive. Per fare ciò i partecipanti lavorano sul riconoscere e stare con emozioni di disagio che possono nascere invece che evitarle. In questa fase si usano esercizi della consapevolezza integrati con lo spazio di respiro Sober. Con la tecnica SOBER i partecipanti possono poi passare all’esperienza diretta non per cambiarla ma per porvi maggior attenzione e scegliere con più consapevolezza.
In questa sessione l’esplorazione di aree soggettivamente mette anche in rilievo schemi di reazione più comuni alle persone. Per elicitare i rischi di ricaduta ogni partecipante viene invitato a condividere un tipico evento scatenante o situazione di rischio, può essere utile riportare questo su una lavagna in quanto in un secondo momento potrà essere utile far notare come spesso vi siano categorie comuni e riferirsi agli studi degli stimoli comuni che scatenano la ricaduta (stati emotivi negativi, pressioni sociali, conflitti interpersonali). Risulta utile dopo la pratica in gruppo parlare di quelle che potrebbero essere ulteriori difficoltà nella vita reale.
SESSIONE 5 – ACCETTAZIONE E AZIONE EFFICACE
Fra gli obiettivi di questa sessione vi è introdurre e coltivare una diversa relazione nei confronti delle esperienze sfidanti, quali sensazioni, emozioni o situazioni spiacevoli. In particolare si riporta il tema di non poter avere il controllo su alcuni aspetti della nostra vita e delle conseguenti frustrazione e rabbia che possono derivarne e portare all’uso di sostanze. Il messaggio che viene trasmesso è che cominciando a smettere di lottare con il momento presente, andandogli piuttosto incontro con compassione ed accettazione, smettiamo di opporci alla realtà diventando quindi più liberi di rispondere invece che reagire.
La sessione si svolge utilizzando la tecnica SOBER con la peculiarità di applicarla in coppie. Le coppie vengono invitate a riportare una situazione problematica di quelle comuni e mentre parlano il conduttore suona la campana e le invita a fermarsi ed applicare il SOBER. Questo esercizio aiuta a simulare la tecnica in situazioni quotidiane.
Il problema di lavorare con la rabbia spesso si presenta in questa fase. Si lavora quindi sul concetto di portare consapevolezza e curiosità sull’esperienza della rabbia piuttosto che reagire ad essa immediatamente e cercare di sopprimerla.
In questa fase viene anche introdotto il movimento consapevole cioè portare attenzione alle sensazioni del corpo durante il movimento o stretching.
SESSIONE 6 – VEDERE I PENSIERI COME PENSIERI
In questa sessione si lavora sui pensieri considerati come parole o immagini della mente ai quali possiamo scegliere di credere o meno. In particolare viene trattato il ruolo che hanno i pensieri e il credere ai pensieri nel ciclo della ricaduta.
Tramite meditazione in seduta i partecipanti vengono invitati a considerare i pensieri osservandone la natura stessa. Possiamo imparare a osservare i pensieri così come si presentano e come poi scompaiono, restando in contatto con il momento presente. Vengono presentate delle metafore per rendere l’idea di come un pensiero arriva e poi scompare (es. il pensiero è come nuvole che si muovono nel cielo limpido), inoltre può essere utile esortare a classificare i pensieri (ricordo, valutazione, fantasia..) per favorire il riconoscimento dei pensieri quali oggetti passeggeri.
La discussione poi sfocia sul ruolo dei pensieri nella ricaduta. Per mostrare la relazione fra pensieri e ricaduta, si sceglie in gruppo un esempio di una situazione che potrebbe portare a ricaduta. L’esempio viene illustrato usando lo schema base del ciclo di ricaduta. Si identificano quindi i pensieri iniziali e tutte le reazioni emotive. Si segue tutta la catena fino alla ricaduta cercando di identificare il punto in cui sarebbe stato possibile fare un passo indietro. La discussione vuole mostrare che anche nel ciclo che conduce alla ricaduta c’è ancora la possibilità di scegliere.
SESSIONE 7 – CURA DI SE’ E STILE DI VITA EQUILIBRATO
In questa sessione viene fornito uno sguardo più ampio alla nostra vita identificando aspetti che sostengono un’esistenza sana e vitale e quelli che portano a maggior rischio.
Viene proposta poi una meditazione seduta di amorevole gentilezza dove si utilizzano per esempio pensieri di buon augurio.
Viene poi proposta la scheda di annotazione delle attività quotidiane per portare la consapevolezza su attività quotidiane ordinarie e su come queste tendono a condizionare complessivamente umore, equilibrio e salute. In particolare si analizza se le attività che svolgiamo sono positive (Nourishing) o negative (Depleting) per noi. Questo esercizio ci mostra quindi come trascorriamo le nostre giornate e come per esempio aggiungere attività positive.
In questo capitolo si approfondiscono quindi le scelte dello stile di vita che predispongono maggiormente alla ricaduta. Spesso si usa l’acronimo HALT (Hungry, Angry, Lonely, Tired) come esempio di fattori che influenzano la vulnerabilità e che si saranno sempre nella nostra vita ma possiamo imparare a prendercene cura in modo nuovo.
SESSIONE 8 – SUPPORTO SOCIALE E PROSEGUIMENTO DELLA PRATICA
L’obiettivo è sottolineare l’importanza delle reti di sostegno come modo per ridurre il rischio e supportare recupero, continuare a praticare la mindfulness. Parlare dell’importanza di una rete di supporto e di cosa li potrebbe portare a sentirsi in difficoltà nel chiedere aiuto.
Durante questa sessione risulta utile inoltre discutere dei vari strumenti a disposizione, concentrandosi su quelli che i partecipanti ritengono per loro più o meno utili da utilizzare nella vita quotidiana.
Discussione
I risultati della maggior parte degli studi precedentemente riportati, concordano sul fatto che alcuni interventi psicoterapeutici modulano l’attività cerebrale soprattutto a livello di aree specifiche, quali la corteccia prefrontale, il cingolo anteriore e l’amigdala, e sul fatto che le modificazioni a carico di queste aree corrispondono al miglioramento clinico (Frewen PA et al., 2008).
Purtroppo, gli studi pubblicati ad oggi sono stati condotti quasi tutti su pazienti con patologie psichiatriche specifiche e selezionati mediante valutazioni diagnostiche che si riferiscono a categorie descrittive che trascurano alcuni aspetti importanti del quadro clinico, quali per esempio, il funzionamento cognitivo o le caratteristiche personologiche e psicodinamiche. Questi aspetti, sui quali ci si attende che un intervento psicoterapico abbia un effetto specifico e diverso da quello indotto da una terapia farmacologica, spesso non vengono considerati nella selezione dei campioni per gli studi clinici controllati.
Il programma MBSR utilizza la pratica di mindfulness come elemento centrale del programma di intervento e si differenzia da altri programmi clinici, in quanto questi ultimi si focalizzano su componenti specifiche di insegnamento della mindfulness come un insieme di abilità, come un modo per affrontare la sofferenza che affianca l’utilizzo di terapie occidentali. La MBSR offre invece un’esplorazione sistematica degli effetti dello stress, esplorazione che si rivela una componente importante per la guarigione e la salute.
L’implicazione psicoterapeutica più importante della mindfulness, non consiste tanto in tecniche, seppur preziose, da insegnare ai clienti, quanto piuttosto nella capacità del terapeuta di essere davvero presente (Bien, 2006). A tal proposito Segal, Williams e Teasdale (2002), contrariamente alle aspettative iniziali, hanno scoperto che non è davvero possibile insegnare la mindfulness ai clienti senza praticarla. Lambert e Simon (2008), ad esempio, riferiscono che il 30% della variazione negli esiti della terapia è attribuibile a fattori comuni, quali la relazione terapeutica, mentre solo il 15% è attribuibile a specifiche tecniche terapeutiche. Miller, Taylor e West (1980) hanno scoperto che uno dei fattori più importanti nella relazione terapeutica, è rappresentato dai livelli di empatia del terapeuta, ed è strettamente correlata con i risultati terapeutici, migliorando anche la qualità dell’alleanza terapeutica (Wexler, 2006), anche se sono necessarie ulteriori ricerche in questo campo.
Questo dato, può rivelarsi particolarmente importante nei confronti di un disturbo stigmatizzato come la dipendenza, nel quale la qualità della relazione interpersonale con il terapeuta può determinare la reazione del cliente rispetto a ogni ipotetico tratto di negazione da parte del cliente (Miller e Rollnick, 1991). Proprio per questi motivi, risulta importante che un terapeuta che pratica mindfulness, possa essere in grado di seguire meglio le tracce dei cambiamenti dello stato emotivo del cliente momento per momento, di essere consapevole della fase di cambiamento nella quale si trova il cliente e di accettare qualsiasi cosa il cliente presenti come naturale e comprensibile, compresa la tendenza umana di resistere al cambiamento.
Dunque la mindfulness, non è da considerarsi come un’alternativa alla psicoterapia, ma come una sua possibile e utile integrazione di cui possono beneficiare sia il paziente che il terapeuta, in quanto, la mindfulness è un lavoro prettamente di osservazione, mentre la psicoterapia lavora prevalentemente sui contenuti.
Inoltre è di grande importanza sottolineare come nei casi di intensa sofferenza sia opportuno iniziare per primo un percorso psicoterapeutico che permetta di ristabilire il disequilibrio emotivo e solo successivamente può essere più appropriato invitare il paziente a praticare la mindfulness.