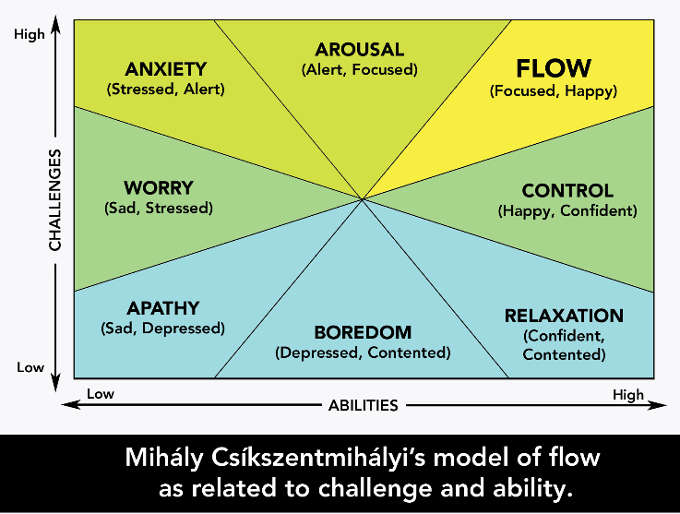Un braccialetto ci salverà dalla depressione: la ricerca della Fondazione BRF ONLUS
Fondazione BRF – Comunicato Stampa
Un semplice braccialetto per il monitoraggio dell’attività fisica potrà difenderci dalla depressione, annunciandola in anticipo e consentendoci di ricorrere a una terapia precauzionale.
Un po’come accade per le previsioni del tempo, potremo accorgerci del nostro imminente cambio di umore ed evitare la perturbazione.
È questo lo scopo della sperimentazione che sta per essere avviata dalla Fondazione BRF Onlus -Istituto per la ricerca scientifica in psichiatria e neuroscienze nata da pochi mesi che sarà presentata a Lucca, a Palazzo Bernardini, il prossimo 28 novembre dalle 15.30.
La Fondazione BRF Onlus, presieduta da Armando Piccinni, psichiatra e docente dell’Università di Pisa, ha messo a punto lo studio e si appresta a iniziare la sperimentazione che durerà sei mesi. Dai risultati potranno emergere i dati necessari a prevenire gli episodi di malattia. Si potrà così anticipare l’insorgenza della depressione ed evitare che i pazienti possano essere colpiti dalle conseguenze della patologia.
Il disturbo che verrà studiato sarà quello bipolare. Ne soffre ogni anno una fetta di popolazione che varia dall’1 al 2 per cento. Per quattro individui su cinque, il disturbo è destinato a ripetersi periodicamente. L’identikit del paziente affetto da disturbo bipolare è ricco di sfumature, ma nella maggior parte dei casi la patologia si caratterizza per l’alternanza ciclica di episodi depressivi e maniacali, ovvero fasi di eccitamento.
L’idea della Fondazione BRF Onlus – spiega il presidente, il prof. Armando Piccinni – è quella di identificare i marcatori biologici di questi up and down del tono dell’umore. Attraverso dei braccialetti elettronici, come quelli che usano gli sportivi, i pazienti saranno monitorati 24 ore al giorno per sei mesi. Terremo traccia delle variazioni dei battiti cardiaci, dell’alternanza sonno-veglia, dell’attività fisica e, in parte minore, delle abitudini alimentari dei pazienti. I dati saranno analizzati statisticamente per stabilire il rapporto causa-effetto tra le condizioni fisiche e il momento in cui si presenta la fase acuta del disturbo bipolare.
Il fine della ricerca è trasformare il braccialetto, dopo la sperimentazione, in un mezzo in grado di analizzare con un fine ben specifico il nostro stato fisico. In questo modo per gli specialisti, ma anche per i pazienti stessi, sarà più facile interpretare le variazioni che coincidono con le prime avvisaglie di malessere e agire con rapidità per evitare episodi depressivi o maniacali.
La Fondazione BRF ONLUS, infatti, rilascerà un’app per smartphone in grado di dialogare con il braccialetto elettronico. In questo modo una semplice notifica potrà bastare per comprendere il proprio stato di salute e gli elementi da considerare.
Si tratta del primo passo del nostro Istituto Onlus – commenta il prof. Armando Piccinni – La ricerca nell’ambito della psichiatria e delle neuroscienze ha sempre bisogno di nuove energie, umane ed economiche. Con la Fondazione BRF Onlus abbiamo deciso di metterci in gioco perché siamo certi di poter apportare contenuti innovativi per contribuire a combattere i mali del nostro tempo.
NELLA PROSSIMA PAGINA:
Nasce la Fondazione BRF Onlus Istituto per la ricerca scientifica in Psichiatria e Neuroscienze (COMUNICATO STAMPA)
Nasce la Fondazione BRF Onlus Istituto per la ricerca scientifica in Psichiatria e Neuroscienze
Rendere meno soli i pazienti psichiatrici e le persone a loro vicine. E’questa la missione della neonata Fondazione BRF Onlus – Istituto per la ricerca scientifica in Psichiatria e Neuroscienze che verrà presentata il 28 novembre 2015 a Lucca (Palazzo Bernardini, dalle 15.30) in un pomeriggio di scienza.
Nata dall’iniziativa di alcuni clinici e ricercatori dell’Università di Pisa, la Fondazione BRF Onlus è un ente privato e senza fini di lucro, che ha come Presidente il Prof. Armando Piccinni (Università di Pisa) e come responsabile ricerche la Prof.ssa Donatella Marazziti (Università di Pisa) e annovera nel suo comitato scientifico personalità internazionali come Marc Potenza (Yale University), Dan J. Stein (University of Cape Town), ma anche Stephen W. Porges (University of Carolina) e Sue Carter (Indiana University). Fra gli italiani spiccano il Prof. Umberto Galimberti e il Prof. Eugenio Picano (CNR).
Vogliamo creare un polo scientifico – spiega il Presidente Armando Piccinni – che punti a sviluppare e finanziare nuovi progetti di ricerca, affinare le conoscenze di tutti i professionisti del settore medico, ma anche dare un risvolto applicativo alle ricerche per il miglioramento delle condizioni di vita dei malati psichiatrici e in generale dell’uomo. Spesso il paziente psichiatrico soffre per una doppia condizione: quella che gli viene consegnata dalla sua malattia, e quella che invece gli impone con l’isolamento e l’incomprensione la società. Il nostro desiderio è quello di tendere una mano, anche attraverso la divulgazione scientifica, a queste persone e alle loro famiglie.
Il pomeriggio di scienza del 28 novembre vedrà la presenza di tre luminari di chiara fama, che si avvicenderanno con altrettante lezioni. A cominciare sarà il Prof. Enrico Alleva con ‘Ruolo delle neurotrofine nel controllo dello stress e delle emozioni nell’animale e nell’uomo‘, a seguire il Prof. Patrick Pageat con ‘La comunicazione chimica dall’animale all’uomo: l’affascinante storia dei feromoni‘, l’incontro terminerà con il Prof. Fortunato Tito Arecchi e la sua lezione ‘Dal caos al linguaggio: la creatività cognitiva‘.
L’occasione sarà utile anche per illustrare le future ricerche della Fondazione BRF Onlus.
Attualmente – spiega Donatella Marazziti, responsabile ricerche – stiamo portando avanti numerosi studi. Il più importante è forse quello sui pazienti bipolari che sarà condotto in un modo innovativo: per monitorare il disturbo utilizzeremo un braccialetto elettronico che verrà presentato proprio nel corso dell’incontro del 28 novembre e che ci aiuterà nello studiare il comportamento dei pazienti e, attraverso una app, ad anticiparne le crisi.
Importanti sono anche gli studi sulle dipendenze comportamentali, nello specifico sulla food addiction e sulla dipendenza dalle nuove tecnologie supportato anche dall’accordo recentemente siglato con ENPAB (Ente Nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei biologi), che ha portato alla nascita di una rete che mira a promuovere indagini sul comportamento alimentare e a favorire l’aggiornamento professionale rispetto alle dipendenze alimentari.
Ulteriori studi in corso – continua il Presidente Armando Piccinni – hanno come focus il temperamento e un approccio teorico ad un nuovo modello di struttura temperamentale, l’utilizzo di nuovi trattamenti nei disturbi d’ansia di sostanze naturali in collaborazione con l’istituto internazionale di ricerca IRSEA –France, lo studio sull’influenza della radiazione luminosa nella cronobiologia dei disturbi dell’umore.
In corso è anche una collaborazione con un’azienda leader mondiale di videogiochi per il riconoscimento precoce dei giocatori patologici; l’incidenza della patologia depressiva nel mondo dello sport agonistico; l’incidenza della food addiction in popolazioni giovanili; la dipendenza da Internet all’interno di popolazioni scolastiche.
Gli interventi in programma il 28 novembre:
- Ruolo delle neurotrofine nel controllo dello stress e delle emozioni nell’animale e nell’uomo
Prof. Enrico Alleva, Director, Section of Behavioural Neurosciences – Dipartimento di Biologia cellulare e Neuroscienze. Istituto Superiore di Sanità. Presidente, Federazione Italiana di Scienze della Natura e dell’Ambiente –FISNA
- La comunicazione chimica dall’animale all’uomo: l’affascinante storia dei feromoni
Patrick Pageat, DMV, MSc, PhD, Dipl ECVBM-CA, HDR, Professeur Associéd’Ethologie Appliquée etBien-Etre Animal àl’EI Purpan –INP Toulouse (France). Doyen de la Direction Recherche et En-seignement IRSEA – Institut de Recherche en Semiochimie et Ethologie Appliquée
- Dal caos al linguaggio: la creatività cognitiva
Fortunato Tito Arecchi. Professor Emeritus of Physics. University of Florence – INO. (Istituto Nazionale di Ottica) – CNR
Comitato Scientifico
- Presidente della Fondazione BRF è Armando Piccinni.
- Responsabile delle ricerche è Donatella Marazziti.
- Fanno parte del Comitato Scientifico illustri scienziati ed esperti di livello nazionale e internazionale. Fra questi Joseph Zohar (Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv, Israel), Marc Potenza (University of Yale, USA), Eric Hollander (Montefiore Medical Center, New York, USA), Stephen Stahl (University of California, San Diego, USA), Stephen W. Porges (Kinsey Institute, Indiana, USA), Sue Carter (Kinsey Institute, Indiana, USA), Konstantin Loganovsky (National Academy of Medicine Sciences of Ukraine), Hans-Jürgen Möller (Ludwig-Maximilians University, Monaco), Dan J. Stein (Universy of Cape Town, South Africa), Patrick Pageat (IRSEA, Apt, France), Siegfried Kasper (Università di Vienna, Austria), Alessandro Cozzi (IRSEA, Apt, France), Umberto Galimberti (Università Ca Foscari, Venezia), Eugenio Picano (NR), Filippo Muratori (IRCSS Stella Maris, Università di Pisa), Luciano Domenici (Università di L’Aquila), Tiziana Stallone (Comitato direttivo ENPAB), Enzo Pasquale Scilingo (Facoltà di Ingegneria, Università di Pisa), Leonardo Romei (ISIA, Urbino), Ilse Melotte (La Quercia, Italy), Laura Bazzichi (Università di Pisa), Antonio Latanà (Università di Pisa), Antonello Veltri (Università di Pisa), Rosa Scaramuzzo (Università di Pisa), Mario Campanella (Giornalista scientifico, Italy).