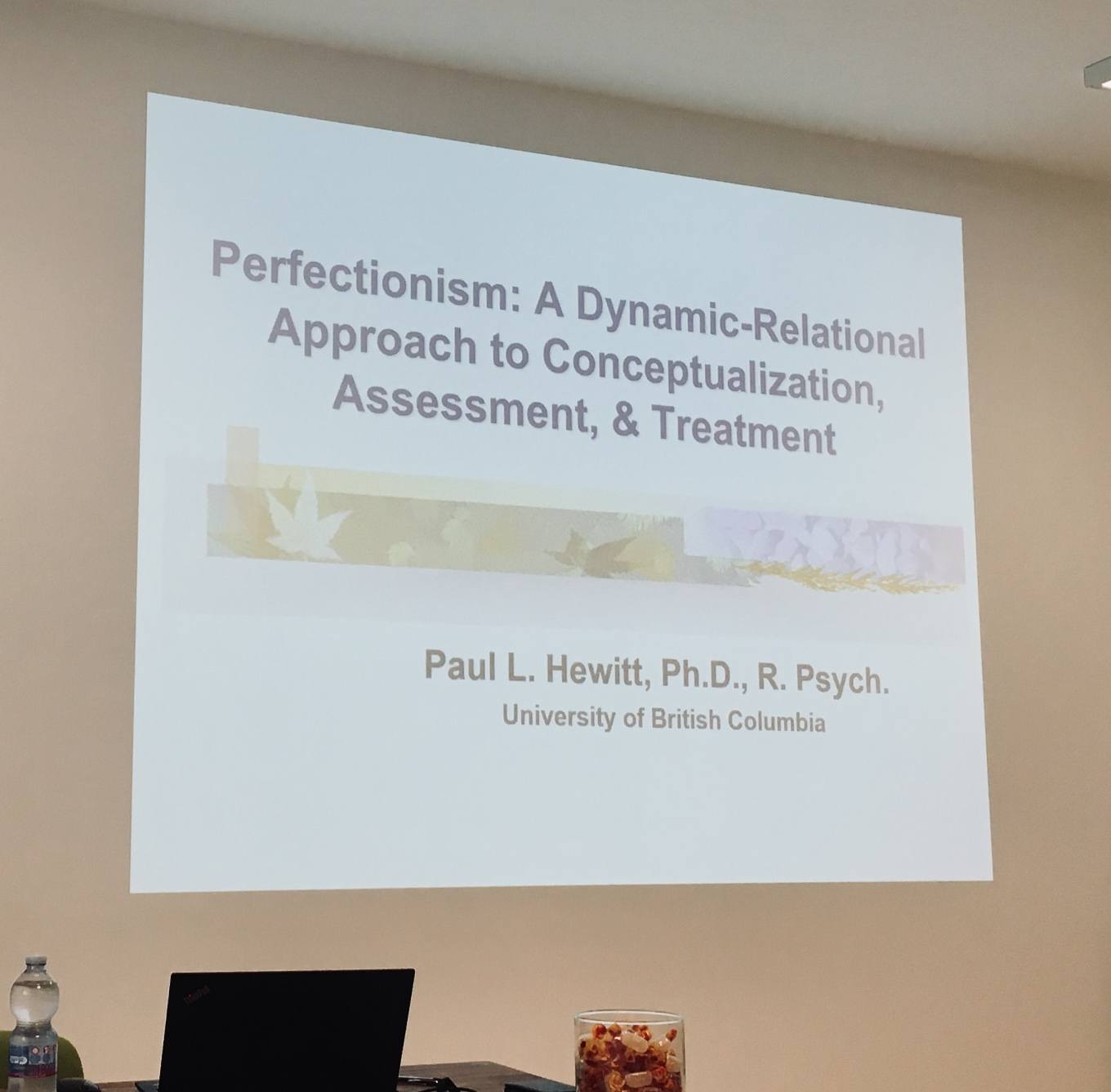Sessualità e terapia di coppia: una prospettiva olistica
“Problemi di coppia? Ecco come risolverli subito! ” Su quante riviste, siti web, blog tematici abbiamo letto una frase simile, come si trattasse di una ricetta culinaria con indicazione dei tempi di cottura, trascorsi i quali il piatto è servito.
Per fortuna ci sono autori e terapeuti che ci ricordano quanto composito sia lo scenario dell’intimità di coppia e articolate le tematiche sessuali correlate.
Coppia: ognuna ha la propria intimità
C’è chi giudica ingenui alcuni tipi di strategie suggerite dai terapeuti per raggiungere la reale intimità: per lo più basate sulla conferma, sulla fiducia reciproca, sull’accettazione; al contrario, l’intimità nella coppia può essere costruita basandosi sul conflitto, sull’autoconferma e sulla rivelazione unilaterale (Schnarch, 2001).
Da qui, il polarismo tra una “intimità confermata dall’altro” e una “intimità auto confermata”. Nel primo caso, il partner si aspetta di essere accettato, confermato, non messo in discussione; nel secondo caso, l’intimità è confermata da se stessi, in quanto la persona è capace di mantenere il proprio senso di identità nella relazione, senza esserne inghiottito, né si aspetta una totale remissione da parte del partner nei suoi confronti. Quest’ultima modalità è il risultato della capacità di avere relazione con se stessi. Infatti, la capacità di apertura di sé verso l’altro senza la garanzia che questi debba accettare e confermare se stessi avviene se vi è un elevato livello di differenziazione.
Come emerge dalle parole dello stesso Schnarch:
L’intimità autoconfermata nelle relazioni a lungo termine suona […]: ‘Non mi aspetto che tu sia d’accordo con me; non sei stata messa/o sulla faccia della terra per confermarmi e rinforzarmi: Ma voglio che tu mi ami – e non puoi realmente farlo se non mi conosci. Non voglio il tuo rifiuto – ma devo affrontare questa possibilità se devo sentirmi accettata/o o sicura/o con te.
Per questo motivo la differenziazione è il fondamento dell’intimità nelle relazioni a lungo termine.
Coppia: la terapia a supporto della sessualità
Di fronte alla carenza del desiderio, lo scopo della terapia sessuale è centrato sul concetto di sviluppo sessuale e non su quello di funzione sessuale (Clement, 2010).
In questa prospettiva lo scopo principale non è innanzitutto l’eliminazione del sintomo – dunque l’aspetto funzionale – bensì l’apertura al desiderio sessuale all’interno della relazione di coppia e la sottolineatura delle aspettative legate all’appagamento sessuale e relazionale. Non si tratta di potenziare la capacità orgasmica o di prolungare l’erezione, bensì di realizzare il potenziale umano presente in ciascuno dei due membri della relazione, presi singolarmente, e all’interno della coppia stessa, come conseguenza.
Questo significa collocare la sessualità all’interno della più ampia sfera dello sviluppo di personalità del singolo individuo, orientando il processo terapeutico alla ricerca delle risorse personali.
All’interno del modello della terapia sistemica, Clement propone interventi – esercizi e prescrizioni comportamentali – da assegnare alla coppia. Tali interventi – come del resto quelli dello stesso Schnarch (ad esempio, abbracciarsi fino a rilassarsi) – sono molto differenti da quelli di ‘prima generazione’, tesi all’apprendimento ed al rilassamento (come quelli, ‘mansionali’, di Masters & Jhonson e la Kaplan).
Alla base di questi interventi, invece, vi è l’idea che lo scopo sia ampliare il desiderio sessuale non correggere o compensare delle mancanze.
Lo scopo è capire cosa significhi e implichi per la persona l’aspetto sessuale, quale sia il suo reale profilo sessuale.
Per far questo viene usato uno strumento diverso da una domanda diretta in quanto non è sufficiente soltanto chiedere alla persona stessa, perché il profilo sessuale è un contenuto che per sua natura non viene facilmente condiviso. Le ragioni sono molteplici, ma basti semplicemente pensare alle reticenze dovute al pudore connesso al tema, alla legittima riservatezza – a volte perfino nei confronti di se stessi – che questo tema suscita. A volte nemmeno la persona interrogata è consapevole della propria sessualità. Pertanto il profilo sessuale di una persona non è facilmente accessibile attraverso semplici domande.
Secondo Clement, una comunicazione che abbia come contenuto il profilo sessuale delle due persone coinvolte nella relazione richiede tre passi:
- l’autoriflessione
- lo svelamento
- la reazione
Il primo si riferisce alla consapevolezza del soggetto circa il suo profilo sessuale e sulla natura del suo desiderio. Lo svelamento implica la comunicazione al partner. Infine, la reciprocità dello svelamento tra i partner.
Strumenti e tecniche terapeutiche per riattivare la sessualità della coppia
I tre passaggi possono non essere distinti con chiarezza, tuttavia sono collegati l’uno con l’altro con un meccanismo di feedback: l’autoriflessione correlata alla riflessione su quale contenuto si possa trasmettere e quale no. Lo svelamento tiene conto della possibile reazione del partner o anche di quella ipotizzata. Così, aspettarsi una determinata reazione dell’altro può avere un effetto frenante non solo sulla scelta e sulla presentazione dei dati del proprio profilo sessuale, ma anche sulla stessa autoriflessione. La reazione che si prevede abbia il partner può comportare una potente censura, più o meno consapevole, sullo svelamento (nel senso di un atteggiamento discreto che alleggerisca il conflitto) ma anche sull’autoriflessione. Così può instaurarsi un feedback negativo che non porta solamente a uno svelamento che fa piacere al partner (riguardo), ma anche a una censura dell’autocomunicazione (autosmentita) che, nei casi estremi, si adatta così tanto alle esigenze del partner che la differenza tra quello che si pensa e quello che si dice si riduce sempre più.
Lo scenario sessuale ideale rappresenta lo strumento cardine per il confronto tra i due partner. Si tratta di una descrizione dello scenario sessuale ideale di ciascun partner. Esso descrive un ideale incontro sessuale che si basa sui bisogni, sulle esigenze e sulle fantasie del soggetto che lo descrive, senza tener conto del partner; lasciando aperta la prospettiva di un partner diverso da quello reale. Entrambi i membri della coppia sono invitati a scrivere su un foglio ciò che essi realmente vorrebbero fare, con chi ed in quale situazione; descrivendo la situazione più soddisfacente che essi vorrebbero vedere attuata dal punto di vista erotico e “in cosa è determinante” il loro personale modo di essere uomo o donna.
Dal punto di vista psicologico non sono a tema le fantasie o i desideri che si possano o meno realizzare.
E’ importante sottolineare che la focalizzazione è sui comportamenti e non sui sentimenti provati, reciproci e non.
Al termine dell’esecuzione i due partner, singolarmente, sono invitati a riporre il foglio in una busta e a non farlo leggere all’altro, ma di procrastinarne l’apertura – o non apertura – alla seduta successiva. Nel momento che essi decidono di aprirla, l’esercizio diventa vincolante per entrambi.
Questo strumento permette il confronto tra i partner, attraverso la neutralità del terapeuta, con una sorta di coreografia erotica che consente al terapeuta di analizzare il processo di elaborazione, se ci sono fraintendimenti, come e quanto seriamente viene accettato il compito, quali reazioni emotive vengono innescate. Insomma, tutta la personalità dei due partner è implicata, coinvolta nella terapia, in un approccio olistico. Il terapeuta instrada i due partner verso una rielaborazione finale. Questo pone in secondo piano il contenuto scritto, infatti, non si focalizza l’attenzione su ciò che i due partner possono sessualmente fare, ma ciò che essi sessualmente sono.