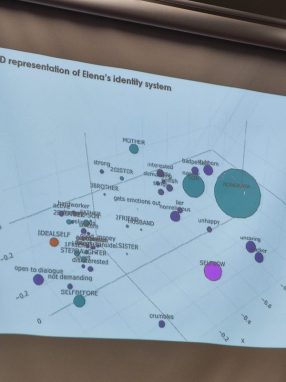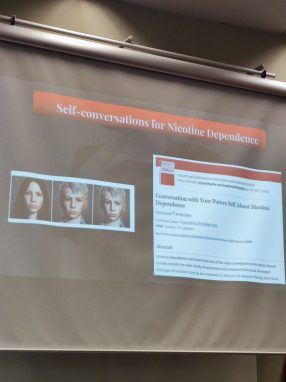La cura dei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali: l’intervento terapeutico integrato
Nella psicoterapia psicodinamica integrata applicata alla sofferenza psicologica dei pazienti affetti da malattie croniche intestinali, l’intervento del terapeuta ha lo scopo di favorire la funzione riflessiva del soggetto.
Abstract
Le
malattie croniche intestinali, IBD, dall’inglese Inflammatory Bowel Disease, sono malattie infiammatorie croniche dell’intestino; sono patologie a carattere remittente e recidivante caratterizzate dall’alternarsi di periodi non prevedibili, anche se uno stile di vita sano può aiutare a prevenire le fasi acute.
L’eziologia delle malattie croniche intestinali è sconosciuta, ma numerose ricerche suggeriscono che il processo patologico multifattoriale sia determinato da una risposta immunitaria, da una componente genetica e da fattori ambientali.
Le malattie croniche intestinali impattano in maniera compromettente sulla salute, causando anche danni strutturali, e sulla qualità di vita dell’individuo che ne è affetto. Le limitazioni nelle attività della vita quotidiana, causate dalle malattie croniche intestinali, possono essere contenute attraverso la presa in carico globale del paziente da parte di una équipe interdisciplinare dedicata.
Seguendo il modello bio-psico-sociale, gioca un ruolo fondamentale la psicoterapia integrata poiché il paziente ritrova parte della propria autonomia e, attraverso l’acquisizione di nuove strategie di coping, favorisce il miglioramento in maniera globale.
La componente medica delle terapie con pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali
Con l’acronimo IBD (Inflammatory Bowel Disease) vengono abitualmente indicate le patologie intestinali croniche di tipo infiammatorio. All’interno di questa categoria si distinguono due realtà in apparenza piuttosto differenti tra loro: il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa (RCU). La prima di esse è una malattia infiammatoria dell’intestino alla quale ha dato una definizione il gastroenterologo statunitense Burrill Bernard Crohn, nel 1932, in collaborazione con i colleghi Ginzburg e Oppenheimer, dopo le ricerche condotte presso il Mount Sinai Hospital di New York. Quello che contraddistingue la malattia di Crohn è la reazione infiammatoria di carattere granulomatoso, reazione che interessa segmenti intestinali in modalità intermittente e disomogenea. Tale reazione colpisce dei tratti specifici e proprio da questa peculiarità deriva la definizione di enterite regionale o enterite segmentaria, una definizione che però non possiamo definire del tutto esatta né calzante, dal momento che la patologia può di fatto colpire potenzialmente ogni segmento del canale alimentare, dall’area stomatologica a quella dell’orifizio anale. Nella realtà dei fatti, l’area percentualmente più colpita è quella dell’ileo terminale (che è poi l’area nella quale si erano concentrate le indagini di Crohn e dei suoi collaboratori), oppure quella del colon. La RCU è invece una malattia infiammatoria cronica che interessa la mucosa di una porzione del colon o a volte l’organo nella sua totalità, in particolare nell’area rettale, e si caratterizza per la presenza di ulcerazioni dei tessuti che possono causare frequenti perdite di sangue e muco. L’infiammazione cronica della superficie del colon si riscontra nella maggior parte dei casi nell’ampolla rettale, e se si riscontra solamente in quella zona si può parlare di proctite ulcerosa. In realtà il livello più profondo della parete intestinale non viene interessato da questo fenomeno e la patologia rimane confinata al colon, avanzando progressivamente dalle porzioni distali, o periferiche, a quelle prossimali (ossia i punti convenzionalmente considerati come origine di un organo).
Il decorso patologico presenta in entrambi i casi descritti un andamento poco prevedibile, di carattere cronico e contraddistinto dal riacutizzarsi dei sintomi a momenti alterni; la terapia adottata è generalmente di tipo sintomatico, quindi fondata sull’utilizzo di medicinali antiflogistici che non siano steroidei (ossia simulatori dell’attività biologica degli ormoni naturali); i farmaci che trovano attualmente più largo utilizzo in questo campo sono gli immunosoppressori, i farmaci biologici e i corticosteroidi. Si fa ricorso all’intervento chirurgico nei casi più gravi e complessi, vale a dire in presenza di stenosi, ascessi o fistole (condotti attraverso i quali scorrono liquidi di origine patologica). L’eziologia delle malattie croniche intestinali non è tutt’oggi univocamente definita e sistematizzata. L’agente infettivo scatenante delle malattie croniche intestinali non è stato attualmente individuato, ma è stata riconosciuta in maniera unanime l’influenza dei fattori ambientali, genetici e delle abitudini individuali insane, come il tabagismo e una dieta povera di alcuni elementi (tra i quali in particolare lo zinco).
Inoltre, il dato offerto dall’aggregazione familiare, rappresentata dal cosiddetto parametro lambda, rileva il rapporto tra la frequenza di una certa patologia nei nuclei familiari e la frequenza riscontrata nel resto della popolazione. L’aggregazione familiare è un parametro da abbinare, ove possibile, agli studi di concordanza tra gemelli, al fine di comprendere se nella patologia esiste una componente genetica determinante e di poter stabilire il livello di ereditabilità.
Per quanto riguarda i fattori legati a stress ed elementi psicologici/psicosomatici, recenti studi hanno individuato il ruolo attivo giocato dai fattori di stress nella patogenesi delle malattie croniche intestinali. Bitton e i suoi collaboratori hanno ipotizzato una relazione direttamente proporzionale fra stress e malattie infiammatorie intestinali, mentre l’ansia e la depressione possono contribuire al deterioramento di MC e RCU (Bitton A, Dobkin P. 2008). Inoltre, non è infrequente osservare l’insorgenza della malattia a seguito di un evento traumatico.
I dati epidemiologici dell’MC e RCU rilevano che le malattie croniche intestinali sono largamente diffuse in America settentrionale e in Europa centro-settentrionale, e che la loro incidenza aumenta nelle aree più a sud di questi continenti. La loro incidenza suggerisce la presenza di un elemento culturale, determinato dai ritmi delle società altamente industrializzate, dove i livelli di stress sono da tempo documentati.
Il picco stagionale della malattia si registra nei mesi invernali, ciò suggerirebbe una correlazione di fattori non solo ambientali tout court ma anche climatici, probabilmente esacerbati dall’inquinamento atmosferico, come dimostra l’incidenza maggiore nelle aree urbane e maggiormente industrializzate.
Nell’Europa Occidentale e negli Stati Uniti la prevalenza della RCU è di circa 70-150 casi ogni 100000 abitanti, con un’ incidenza annua di circa 10-15 casi per 100000 abitanti. La prevalenza della MC è di circa 20-40 casi per 100.000 abitanti, con un’incidenza di 2 casi ogni 100000 abitanti all’anno.
La fascia di età maggiormente interessata dal fenomeno è quella tra i quindici ed i quarant’anni. L’insorgenza è più precoce nei soggetti di sesso maschile, mentre il decorso più prolungato, la gravità e la frequenza è maggiore nei soggetti di sesso femminile. Nell’ultimo decennio si è osservato un secondo picco d’incidenza dopo i cinquanta anni e fino ai sessantacinque circa, oltre alla frequenza diagnostica di malattie croniche intestinali in pazienti di età ancora più avanzata (in particolare RCU).
La Psicoterapia Psicodinamica Integrata (PPI) come prospettiva di cura
Le fondamenta della Psicoterapia Psicodinamica Integrata poggiano sull’alleanza terapeutica, ovvero la relazione fra il soggetto e l’altro (o, in altre parole, all’altro da sé). Sul piano etimologico, il suo significato è di diretta derivazione dal termine greco dýnamis, ossia forza, energia, in riferimento alle energie sprigionate da ogni scambio interpersonale. La narrazione della sintomatologia e le vicissitudini a essa legate trovano senso nell’ascolto del terapeuta, che, prendendosi carico della sofferenza riportata, conduce il paziente alla scoperta del significato simbolico del sintomo.
L’aspetto integrato della terapia fa in modo che al metodo eminentemente analitico vengano abbinati altri approcci, spesso derivanti dalla terapia cognitivo-comportamentale, dalla transazionale, dalla meditazione mediata e dal training autogeno. Infatti, i pazienti impegnati in una terapia di lunga durata, come quella psicodinamica, hanno bisogno di apprendere quanto prima delle strategie di coping che consentano la gestione delle criticità quotidiane.
Riportiamo a questo proposito l’opinione di Giuseppe Lago secondo il quale il cuore della cura non si può trovare né in ambito esclusivamente biologico né in ambito esclusivamente psicologico. Al contrario, è necessario immaginare una sorta di ponte, un ampio collegamento che risolva un dualismo che ha sempre arrecato danno allo studio dell’organismo umano. Il dualismo mente-corpo deve risolversi in un’attività funzionale unica, che deriva da due realtà che appaiono come scindibili, ma che in effetti si integrano nel funzionamento reciproco, fino a costituire una sola realtà «come accade per il campo visivo: unico, ampio, esteso e nitido risultato della funzione dei due occhi» (Lago G. 2006). La Psicoterapia Psicodinamica Integrata agisce sulla mente in modo integrato, tenendo conto della plasticità neuronale (ossia la facoltà del cervello di recuperarsi e ristrutturarsi), ma anche della complessità e della creatività della mente umana. Nell’ambito della psicoterapia psicodinamica integrata, applicata alla sofferenza psicologica dei pazienti affetti da malattie croniche intestinali, l’intervento del terapeuta ha lo scopo di favorire la funzione riflessiva del soggetto.
Nel momento iniziale della psicoterapia psicodinamica integrata, o fase empatica, non si applica alcuna forma di interpretazione, specialmente del materiale onirico. La fase empatica prevede piuttosto un’esperienza emozionale correttiva (Alexander F., French T.M. 1946), nel suo significato di riattualizzazione di contenuti emotivi (detti protomentali), già ben saldi nella memoria implicita dell’individuo, successivamente riorganizzati all’interno della nuova esperienza emotiva costituita dalla psicoterapia psicodinamica integrata (Lago G. 2006). Il paziente rivela proiettivamente le sue aspettative, basate su precedenti esperienze, e la risposta del terapeuta gli fornisce un modello di regolazione affettiva, che lo aiuta a portare a termine i processi riflessivi incompleti.
La successiva fase interpretativa getta le basi e si edifica sulla precedente fase empatica, con un rinforzo che sostanzia il vincolo di alleanza nell’ambito della terapia. In particolare, nel caso di individui affetti da patologie intestinali infiammatorie croniche, che vivono uno stato di rifiuto, vergogna, financo dissociazione dalla propria corporeità, le errate percezioni e credenze cognitive devono essere esplorate e sviscerate in maniera non giudicante. Infatti l’esperienza corporea di una persona affetta da malattie croniche intestinali è talmente disturbante e disorganizzante che le distorsioni cognitive possono assumere, in alcuni casi, proporzioni deliranti e mostrarsi refrattarie agli sforzi terapeutici.
Conclusioni
Possiamo ribadire nuovamente che le malattie croniche intestinali possono essere definite a tutti gli effetti delle malattie sociali. Dal momento che la patologia insorge nel periodo della vita in cui gli individui sono nel pieno delle proprie attività, condiziona pervasivamente l’esistenza dei pazienti e di quanti vivono loro accanto. In definitiva, la vita dei soggetti affetti da malattie croniche intestinali, e dei loro familiari, si configura attorno ai costanti monitoraggi clinici, agli interventi strumentali necessari per tenere la patologia sotto controllo e ai trattamenti terapeutici invasivi che la condizione del paziente rende indispensabili.
L’impatto sociale di queste categorie patologiche è quindi tutt’altro che trascurabile: pur non incidendo direttamente sull’aspettativa di vita dei pazienti, esse possono avere un’azione invalidante sulle abilità e le potenzialità complessive di chi ne è affetto (come ad esempio il rischio di lunghi congedi per malattia, le spese rese necessarie da interventi e ricoveri frequenti, la necessità di acquistare integratori e farmaci non mutuabili, oltre agli spostamenti per sottoporsi a cure in zone geografiche lontane da quella di residenza). Basandosi su recenti stime rese pubbliche dall’Unione Europea, un paziente costa allo Stato tra i tremila e i cinquemila euro l’anno. In Italia si contano circa 150mila pazienti IBD ufficiali, anche se il conteggio potrebbe arrivare a 250mila. È quindi intuitivo quanto siano elevati questi costi, ai quali si affiancano i costi indiretti (come, ad esempio, i servizi assistenziali).
Per quanto riguarda la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa, gli obiettivi terapeutici si possono riassumere in alcune specifiche categorie: dapprima, l’induzione della remissione, quindi il suo mantenimento; a seguire, la terapia farmacologica unita a quella psicoterapica. Si intende così raggiungere un sensibile miglioramento della qualità di vita e nello stesso tempo la prevenzione di recidive, complicanze o recrudescenze.
Per concludere, un’ulteriore importante finalità consiste nella prevenzione degli effetti collaterali delle terapie stesse, siano essi a breve o a lungo termine. È una recente acquisizione, del resto, la comprensione del fatto che le finalità ed i target clinici non sono in sé sufficienti a fornire un’esaustiva definizione dell’utilità e della reale efficacia dei differenti percorsi terapeutici.
Allo stato attuale, la valutazione dello stato patologico circoscritta ai sintomi ed alla misurazione delle evidenze cliniche, non si può in alcun modo ritenere completa. Esistono delle prove scientifiche, per quanto perfettibili e tuttora in fase di ricerca, grazie alle quali si può affermare che una terapia mirata alla mera remissione sintomatologica non ottiene una guarigione stabile e duratura. Al contrario, quando ad una reazione clinica positiva viene associata una reazione altrettanto incoraggiante sul piano biologico ed umorale, è possibile aspettarsi una fase regressiva della malattia più solida e durevole.
Questa non è altro che la concezione di deep remission, come recentemente teorizzata da Colombel, il cui senso profondo è l’affiancamento di un percorso parallelo a quello clinico, che tende alla normalizzazione dei marcatori biologici di infiammazione (Colombel J. F. et al 2014) ed alla cicatrizzazione parziale o totale delle lesioni luminali esaminabili e sondabili.
La gestione ottimale prevede quindi una mappatura minuziosa prima di qualunque tipologia terapeutica (Vermeire S. et al. 2013).
Se prendiamo in considerazione le più importanti e recenti acquisizioni sulle malattie croniche intestinali, non possiamo non notare che la ricerca traslazionale conduca all’enucleazione dei target terapeutici di maggior rilievo. Questo risultato agevola da un lato la creazione di prodotti farmaceutici più efficaci e dotati di migliori garanzie circa la sicurezza, e dall’altro l’individuazione di supporti psicologici sempre più adeguati e specificamente elaborati e strutturati.
Nell’ultimo ventennio, da questi percorsi di ricerca clinica sono scaturiti rilevanti contributi all’equipaggiamento terapeutico, alla diversificazione delle opzioni di presa in carico del paziente ed alla maggiore precisione della prognosi. Sul versante psicologico il progresso terapeutico si attesta sull’affiancamento di terapie di sostegno psicologico o di gruppi d’ascolto condotti da uno psicoterapeuta.
Negli ultimi anni, le recenti intuizioni dei meccanismi eziopatogenetici, nonché la scoperta di nuovi orizzonti terapeutici, hanno avuto il merito di introdurre cambiamenti sostanziali e positivi nel trattamento dei pazienti affetti da malattie croniche intestinali. Una gestione del paziente altamente individualizzata fornisce una variabile determinante nell’approccio globale alla patologia e pone il portatore, col suo bagaglio esperienziale, psicologico e col suo vissuto irripetibile, al centro del percorso terapeutico.