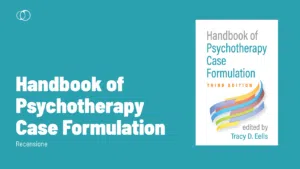Il termine “formulazione del caso” è stato definitivamente introdotto solo nel 1985 grazie a Turkat (1985, 1986), ma esso era presente nel lavoro della maggior parte dei pionieri delle terapie cognitive e comportamentali: ad esempio in Monte B. Shapiro (1955, 1957) (Shapiro & Nelson, 1955), Lazarus (1960), Meyer (1960), Wolpe (1960) e Yates (1960).
Tra tutti però spicca il contributo di Meyer perché negli altri autori, e in particolare in Shapiro, la formulazione del caso non conteneva in sé alcun elemento di accordo e condivisione con il paziente, non portava a un’alleanza di lavoro. Shapiro realizzava la formulazione del caso dapprima intervistando i pazienti per ottenere una descrizione precisa del loro comportamento problematico. Successivamente, sulla base di modelli teorici si formulavano delle previsioni sulle reazioni comportamentali dei pazienti a determinati stimoli, previsioni che erano testate in esperimenti clinici e che portavano infine alla formulazione di un piano terapeutico fatto di ripetuti esperimenti comportamentali. Insomma, Shapiro otteneva dati dal paziente ma non li riformulava al paziente, non cercava il suo assenso né gli chiedeva di utilizzare la formulazione come base per un lavoro comune.
La formulazione del caso condivisa con il paziente di Victor Meyer
Completamente diverso l’approccio di Victor Meyer (1975) che, critico nei confronti di schemi standardizzati, suggeriva di sviluppare ipotesi sulla natura del problema e di discuterle e condividerle con il paziente (Meyer, 1975, p. 22), enfatizzando dunque la comprensione e la condivisione del problema del paziente, spiegandogli la logica, cercando la cooperazione e quindi costruendo la risoluzione e la motivazione per il programma di trattamento.
Per Meyer la formulazione del caso andava condivisa con il paziente. Dopo aver raccolto i dati sulle situazioni problematiche del paziente, egli formulava il caso nei suoi termini di antecedenti, risposte comportamentali e conseguenze e lo proponeva al paziente, discutendolo con lui. Questa discussione non era una trasmissione unidirezionale di informazioni dal clinico al paziente, ma avveniva su un piano paritario ed entrava a far parte del contesto terapeutico. La condivisione delle informazioni con il paziente diventa quindi essa stessa parte della modificazione ambientale e comportamentale perseguita dal clinico comportamentale per ottenere il cambiamento terapeutico. Questa modificazione, però non avveniva all’insaputa del paziente, ma coinvolgendolo, ovvero coinvolgendo i suoi stati mentali. È chiaro che, in tal modo, si agisce non solo in maniera esterna sulle reazioni comportamentali ma in maniera condivisa, alleata e relazionale