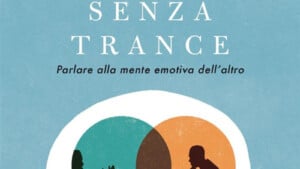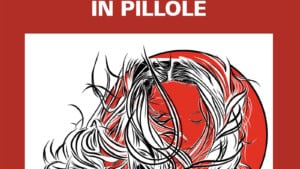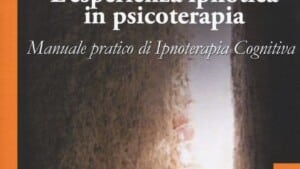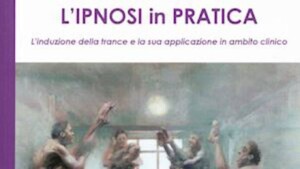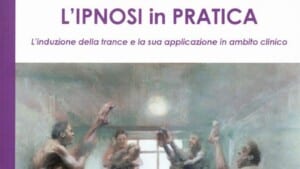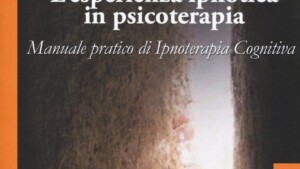Forme di democrazia in psichiatria: l’Open Dialogue finlandese
Matteo Bessone, Chiara Tarantino
L’Open Dialogue, la cui paternità spetta a Jaakko Seikkula, è la naturale conseguenza della gestazione di teorie e pratiche che risalgono alla fine degli anni ’60 in Lapponia (“il trattamento adattato al bisogno” di Alanen). Il gruppo di ricerca finlandese diretto da Alanen iniziò a perseguire, sin dal 1968, l’obiettivo di sviluppare un modello di trattamento psichiatrico pubblico destinato a pazienti schizofrenici e alle loro famiglie caratterizzato da estreme adattabilità e flessibilità (di metodi e strumenti).
Il Nord Europa rappresenta per gli abitanti del Bel Paese uno di quei riferimenti le cui politiche sociali ed economiche costituiscono un orizzonte fantastico, quasi fiabesco: c’è sempre qualcosa di migliore lassù che in fondo quaggiù crediamo purtroppo di non poter ottenere. Quello che c’incanta è solitamente legato ad una sorta di abito culturale (Bourdieu, 1980) che riesce a strutturare sia abitudini individuali che possibilità sociali e istituzionali che percepiamo come drasticamente estranee, altre, quasi esotiche e in una sorta di rassegnazione ingiustificata preferiamo raccontare tutto questo e portarlo come esempio di come dovrebbe andare il mondo, piuttosto che tentare di apportare alcuni cambiamenti nel nostro mondo.
Questo processo di fascinazione verso il Nord Europa sta interessando in questi anni anche la salute mentale e non solo quella italiana. In Lapponia infatti dagli anni ’90 i servizi psichiatrici sono organizzati secondo modalità che hanno dell’inverosimile ai nostri occhi, gli psicologi e gli psichiatri lapponi rappresentano la realtà clinica (Kleiman, 1978) secondo modalità radicalmente diverse dalle nostre e la popolazione nutre nei confronti dei servizi una fiducia e una benevolenza che ha per noi dell’inverosimile. Tale osservazione non può che essere accompagnata dalla constatazione della differenza tra i nostri servizi e quelli finlandesi. La cultura finlandese di operatori e cittadini sulla salute mentale ha caratteristiche del tutto peculiari che sono state notevolmente influenzate dai servizi e dagli approcci attualmente dominanti, in particolare da uno: l’Open Dialogue.
L’Open Dialogue, la cui paternità spetta a Jaakko Seikkula, è la naturale conseguenza della gestazione di teorie e pratiche che risalgono alla fine degli anni ’60 in Lapponia (“il trattamento adattato al bisogno” di Alanen). Il gruppo di ricerca finlandese diretto da Alanen iniziò a perseguire, sin dal 1968, l’obiettivo di sviluppare un modello di trattamento psichiatrico pubblico destinato a pazienti schizofrenici e alle loro famiglie caratterizzato da estreme adattabilità e flessibilità (di metodi e strumenti): l’idea di una terapia “su misura” per le psicosi schizofreniche emerge a partire dalla constatazione della radicale eterogeneità delle forme cliniche della schizofrenia, e da questa deriva la necessità di integrare tipologie di interventi prima ritenuti antitetici.
Negli anni 1981-1987, con la realizzazione del Finnish National Schizophrenia Project, un programma nazionale per lo sviluppo e lo studio del trattamento e della riabilitazione dei pazienti schizofrenici, si è tentato con successo di applicare questo modello a comunità psichiatriche sempre più ampie, per ridurre al minimo i trattamenti ospedalieri e privilegiare l’assistenza extra-ospedaliera. Gli esiti dimostrarono che la strategia messa a punto da Alanen a Turku poteva essere riproposta in altre città avendo registrato risultati ampiamente positivi (una ricerca relativa ai soli pazienti con un primo episodio psicotico tra il 1983 e il 1984 evidenziò che al follow-up di cinque anni il 61% era asintomatico e solo il 18% persisteva in una condizione di disabilità).
A partire da quel momento la pratica psicoterapeutica in Finlandia è diventata parte integrante del sistema di cura pubblico. Sulle orme della tradizione inaugurata da Alanen, nel 1987 (a conclusione del progetto nazionale) nell’ospedale di Keropudas venne avviato un progetto di ricerca, in collaborazione con l’università di Jyvaskyla, che ha portato alla trasformazione del sistema psichiatrico tradizionalmente orientato all’individuo in un sistema aperto, centrato sulla famiglia e sulla rete sociale.
Questo processo di cambiamento, lento ma radicale, non è stato immune da errori e delusioni: i tentativi iniziali di praticare psicoterapia familiare in setting ospedaliero si rivelarono del tutto fallimentari fino a quando il team iniziò ad organizzare incontri aperti il giorno stesso del ricovero a cui partecipavano tutti i professionisti coinvolti, il paziente e le persone che lo avevano accompagnato. Aprire i confini ospedalieri, tradizionalmente rigidi e chiusi, permise agli attori del trattamento (il paziente e la famiglia) il passaggio da un trattamento “subìto” (e spesso con scarso coinvolgimento e partecipazione) a un trattamento condiviso in cui ognuno era chiamato a offrire il proprio contributo. Quando due sistemi (ospedale e famiglia) si incontrano sono legati alle stesse leggi sistemiche e si impegnano ad accomodare il proprio comportamento a quello dell’altro, in un processo di mutua co-evoluzione (Maturana, 1988). Il nuovo sistema funzionale, creato dal lavoro congiunto di ospedale e famiglia (operatori e clienti) senza che nessuno dei sue sistemi assuma il controllo sull’altro, offre grandi opportunità di crescita e cambiamento.
Da queste premesse si è strutturato nella Lapponia occidentale un approccio con caratteristiche proprie chiamato “Dialogo Aperto”. Oltre all’ospedale di Keropudas sono stati coinvolti i cinque centri di salute mentale distrettuali presenti nel territorio, in un lavoro che è stato caratterizzato da molteplici studi sperimentali, modificato sulla base dei feedback e dell’esperienza maturata dal team. In quegli stessi anni, l’attenzione della comunità scientifica si è rivolta lentamente e cautamente al Dialogo Aperto grazie alla pubblicazione dei primi studi dai quali emergeva una incontrovertibile diminuzione del tasso di cronicizzazione della psicosi e l’abbattimento del tasso di ospedalizzazione.
Pratica clinica e ricerca hanno continuato a intrecciarsi in Lapponia nel corso di 25 anni e i risultati hanno acquistato maggior valore all’interno di un ulteriore proficuo rapporto, quello tra il sistema sanitario nazionale e università. E’ da questo dialogo tra pratica e ricerca da una parte, e tra accademia e servizi pubblici dall’altra, che viene generata quella moltitudine di evidenze cliniche e di studi che attualmente conferiscono autorevolezza e consistenza all’OD.
L’obiettivo del progetto OD è quello di ridurre le ospedalizzazioni: piuttosto che sradicare il paziente dal proprio sistema sociale, la situazione di crisi viene osservata “in vivo” nell’ambiente naturale in cui ha avuto origine, il domicilio del paziente e alla presenza di tutti coloro che avendo contribuito all’emergere dell’esperienza psicotica, possono diventare partner attivi del processo di cura. Il nucleo familiare esteso non è l’oggetto bensì l’agente del cambiamento sin dal principio. Anderson e Goolishian (1988) considerano i problemi come costrutti sociali nati e riformulati continuamente nelle conversazioni e poichè chi osserva un problema diventa parte del problema stesso, la crisi è risolta solo quando tutti coloro che lo hanno nominato tale cessano di riferirsi ad esso come ad un problema e tale riformulazione può avvenire solo all’interno della conversazione comune.
Il Dialogo Aperto si serve di 6 equipe mobili di intervento sulla crisi (per una popolazione di 72000 abitanti) incaricate di organizzare e condurre il trattamento per ogni nuovo caso di esordio psicotico (è bene sottolineare come l’OD, pur mantenendo l’originale interesse per i pazienti schizofrenici, non si possa considerare un trattamento diagnosi-specifico e venga utilizzato oggi per una molteplicità di problematiche diverse).
Il Team per ciascun caso è composto da un gruppo multiprofessionale di operatori (psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, infermieri…). Ad ogni nuova richiesta di aiuto si organizza il primo incontro al domicilio del paziente entro 24 ore dalla richiesta stessa. Chi riceve la telefonata si occupa di costituire l’equipe che dal primo incontro si assume la responsabilità di accompagnare il paziente per tutto il tempo necessario alla soluzione della crisi e in qualsiasi setting (se è necessaria una fase di ospedalizzazione il medesimo team di operatori si occuperà di condurre incontri di dialogo aperto nel reparto ospedaliero).
Offrire un aiuto immediato e tempestivo permette di ridurre notevolmente il periodo di psicosi non trattata DUP (Duration of Untreated Psychosis), cioè l’intervallo di tempo che intercorre tra l’insorgenza dei sintomi e l’inizio di un percorso di cura presso i servizi competenti. Questo intervallo di tempo è uno dei fattori maggiormente connessi alla prognosi della malattia: tanto maggiore è la durata del DUP, tanto maggiore è il rischio che la prognosi sia sfavorevole. In Lapponia, prima dell’implementazione del Dialogo Aperto nei servizi psichiatrici pubblici, il DUP ammontava in media a 12-13 mesi. Nei primi anni ‘90, successivamente all’introduzione del metodo OD, il DUP è declinato a 4,2 mesi e nel 2000 si è ulteriormente ridotto a 15 giorni. La riduzione del DUP è uno dei risultati più importanti per almeno due motivi: da una parte è chiaro che se il contatto con i servizi avviene precocemente, i sintomi psicotici sono meno radicati rispetto a quei pazienti per i quali è trascorso un lungo periodo (mesi o anni) tra l’insorgenza della malattia e l’avvio di un percorso terapeutico.
Dall’altra parte, nella provincia della Lapponia occidentale sono emersi evidenti segni di diminuzione dell’incidenza annua della schizofrenia (da 33 nuovi pazienti l’anno su 100000 abitanti nel 1985 a 2 nuovi pazienti l’anno su 100000 abitanti nei primi anni del 2000). Secondo gli attuali manuali di riferimento (DSM-5) per porre diagnosi di schizofrenia è necessario che i sintomi perdurino per un periodo di almeno 6 mesi. Questa diagnosi in terra lappone sta gradualmente estinguendosi perchè nella maggior parte dei casi i sintomi vanno incontro a un netto miglioramento nel corso dei primi sei mesi, prima che sia possibile attribuire una diagnosi di psicosi.
Inoltre la continuità psicologica (in una prima fase gli incontri possono avvenire anche per 10-12 giorni consecutivi) e la presa in carico da parte di un unico gruppo di professionisti contribuiscono a rendere più flessibili i confini tra strutture diverse e tipi di trattamento differenti con effetti positivi sull’alleanza terapeutica e sulla prevenzione dei drop-out anche perchè, oltre a promuovere la capacità del soggetto di riappropriarsi del proprio percorso di cura, il clima promosso da parte dei servizi attorno al paziente non risente della frammentazione e della conflittualità (tra servizi e famiglia o tra diversi servizi) che talvolta è possibile riscontrare.
L’obiettivo dei professionisti durante gli incontri è quello di far emergere, nello spazio di dialogo tra i partecipanti, una nuova rappresentazione della situazione problematica e un linguaggio co-costruito e condiviso per esprimerla. L’intenzione non è quella di trovare vincitori o soluzioni ai problemi, ma quello di aprire nuove prospettive (Seikkula, 2014), creandole nel dialogo. Nessun operatore si presenta come il detentore esclusivo di un sapere che investe unidirezionalmente la famiglia dall’esterno. Il compito dei professionisti è quello di ascoltare, rispondere alle comunicazioni dei clienti, permettere a ciascuno di esprimere la propria voce, la propria opinione promuovendo la sensazione di essere co-autore del percorso di cura.
Non esistono riunioni di équipe separate in cui “pianificare” la cura del paziente e tutte le decisioni inerenti il trattamento vengono prese all’interno degli incontri da parte di operatori e familiari. Le discussioni sono aperte e trasparenti e ciascun partecipante è autorizzato ad esprimersi. Quello che accade, a livello relazionale, è molto più di una autorizzazione all’espressione, è una vera e propria legittimazione e responsabilizzazione: il paziente e le persone a lui vicine hanno il diritto di costruire il proprio percorso di cura e sono le persone che, più di tutte, possiedono le conoscenze e le risorse per affrontare le proprie difficoltà.
Il rovesciamento di paradigma che è avvenuto nella Lapponia si può riassumere con le parole di Birgitta Alakare: “Ci siamo specializzati nel dire che non siamo degli specialisti” (Whitaker, 2013). Non essendoci più degli specialisti non esistono nemmeno modalità standard di pianficare il trattamento, non esistono step prestabiliti da seguire; gli sforzi terapeutici sono tutti volti ad una negoziazione dei significati e ad un adattamento sia al modo in cui i clienti fanno esperienza della crisi che ai significati che questa assume per ciascuno. Per fare questo è necessario un profondo lavoro da parte dell’équipe teso alla tolleranza dell’incertezza, valore ritenuto fondamentale, rispetto alla capacità di offrire soluzioni preconfezionate. Il compito dei terapeuti dialogici è quello di restituire ai clienti la capacità di riprendersi in mano la propria vita, il senso di “agentività” e la possibilità di plasmare il proprio destino, tutte funzioni che il nucleo familiare scivolato nella spirale psicotica ha perduto.
Il concetto di psicosi cui fanno riferimento gli ideatori del Dialogo Aperto (e che si sta diffondendo grazie ad essi in Finlandia anche tra i non addetti ai lavori) è piuttosto diverso da quelli predominanti che afferiscono ai paradigmi strettamente biologici e affonda le sue radici nella tradizione scandinava (forse negletta) delle psicosi psicogene (Wimmer, Stromgren, Retterstol). Questo termine indica una “psicosi clinicamente indipendente (distinta dalla schizofrenia e dalla psicosi maniaco depressiva) causata da fattori mentali o traumi emotivi, generalmente su un terreno predisposto; tali traumi determinano l’insorgenza, il decorso e la fine della psicosi la cui forma e i contenuti riflettono il trauma in modo significativo, più o meno direttamente e comprensibilmente” (Wimmer, 1913).
In un’intervista con lo staff del Keropudas Hospital di Tornio del 10 Settembre 2009, Tapio Salo sostiene che [blockquote style=”1″]la psicosi non è qualcosa che hai nella testa; è qualcosa che esiste nella zona di confine tra i membri di una famiglia o tra i membri di un piccolo gruppo. E’ qualcosa che esiste all’interno di queste relazioni: la persona che diventa psicotica rende percepibili tutti questi aspetti negativi. E’ come se indossasse l’abito sintomatologico e prendesse su di sè gli oneri che ciò comporta[/blockquote] (Whitaker, 2013).
In questa concezione, la schizofrenia perde i caratteri della malattia diventando una risposta “naturale”, una modalità singolare e certamente tragica di affrontare un evento di vita alienante e terrificante, la risposta ad un trauma che non è possibile significare nè verbalizzare e che ha trovato come unica forma di espressione i sintomi psicotici. E’ l’esperienza di una totale frattura del discorso interno che si ripercuote verso l’esterno e viceversa: quanto più il pensiero diventa frammentato tanto più diffice sarà instaurare relazioni significative, e a questo isolamento corrisponde una frammentazione che depaupera il paziente.
La comunicazione si interrompe. Per Bateson (1977) in quel particolare linguaggio che è il guazzabuglio schizofrenico, il paziente sta descrivendo una situazione traumatica che comporta un groviglio metacomunicativo. Il sintomo rappresenta in tale contesto l’ultima possibilità espressiva del soggetto, la riattualizzazione metaforica della sua esperienza. Cogliere la portata comunicativa, e la costruzione di significato di cui il sintomo si fa veicolo, permette agli operatori e alla comunità di costruire delle rappresentazioni di tali tipi di esperienze che guideranno verso determinate direttrici la strutturazione degli interventi e conseguentemente dei servizi.
Tamponare il sintomo, soffocare le voci, amputare l’esperienza psicotica non rappresentano la priorità in questo tipo di approccio e il farmaco assume un nuovo ruolo. Se da una parte gli operatori non avvertono il bisogno di soffocare il sintomo, dall’altra l’utilizzo del farmaco non viene neanche escluso aprioristicamente. Il trattamento farmacologico viene considerato come una delle possibili traiettorie dei percorsi di cura, possibilità che, al pari delle altre, diventa oggetto di un confronto dialogico, senza venir imposta. In maniera prioritaria si cerca di ripristinare il sonno del paziente e di attenuare il suo stato d’ansia, somministrando ipnoinducenti e benzodiazepine. A volte si ritiene necessario l’uso di antipsicotici, sempre a basse dosi. Dal punto di vista pratico quando, durante un incontro dialogico, viene evocata la possibilità di iniziare una terapia antipsicotica, devono passare almeno tre incontri in cui sia possibile riflettere su questa alternativa, prima che si possa prendere una decisione e iniziare, eventualmente, l’assunzione.
Nella realtà clinica solo in un terzo dei casi si decide di inziare un trattamento farmacologico, sempre con l’intenzione che tale trattamento sia il più breve possibile. Le valutazioni a lungo termine sui pazienti trattati nel periodo 1992-1997 hanno evidenziato che a cinque anni, il 79% dei pazienti era asintomatico e l’80% lavorava, studiava o era alla ricerca di un lavoro. Solo al 20% era stata assegnata una pensione di invalidità. Di tutti questi pazienti, circa i due terzi (67%) non avevano mai seguito una terapia con antipsicotici, il 33% ne aveva fatto solo un uso breve ed occasionale, e solo il 20% aveva assunto e proseguito regolarmente la terapia (Seikkula et al., 2006). Questi risultati sono rimasti stabili lungo un periodo di oltre dieci anni: lo studio più recente, condotto nel periodo 2003-2005, ha valutato specificatamente la stabilità dei risultati ottenuti all’interno del periodo complessivo di utilizzazione dell’OD in Lapponia (1992-2005), sottolineando che oltre il 70% dei pazienti non ha avuto neanche una ricaduta in questo periodo. Contrariamente a quanto consigliato dalle linee guida italiane per il trattamento della psicosi, quindi, in fase iniziale il trattamento farmacologico viene evitato: durante i primissimi giorni di crisi sembra possibile parlare di cose di cui è difficile invece discutere in seguito, [blockquote style=”1″]le allucinazioni possono essere affrontate e prese sotto esame, e questa opportunità di parlarne non riappare poi successivamente, se non dopo molti mesi di terapia individuale. E’ come se la finestra su queste esperienze estreme rimanga aperta solo per pochi giorni (i primi)[/blockquote] (Seikkula, 2014).
Questo nuovo ruolo assegnato alla farmacoterapia non sembra affatto diminuire l’efficacia dell’OD rispetto ad altri metodi psicoterapeutici. In un recentissimo articolo apparso su Science, Michael Balter (2014) propone una breve rassegna di dieci studi che riassumono lo stato dell’arte dell’efficacia psicoterapeutica dei vari approcci alla schizofrenia: accanto ad una moderata efficacia della psicoterapia psicodinamica (Rosenbaum et.al, 2012) o della psicoterapia cognitivo-comportamentale (CBT) (Morrison et al., 2014; Grant et al., 2012; Van der Gaag et al., 2012), quasi sempre associate al trattamento farmacologico tradizionale, l’autore cita il lavoro di Seikkula e collaboratori (Seikkula et al., 2011), che, tra i dieci presi in esame, è l’unico a vantare una percentuale di guarigione dell’ 81% con un ridottissimo utlizzo di farmaci antipsicotici.
Gli effetti dei cambiamenti introdotti all’interno del sistema psichiatrico con l’OD hanno però portata ben maggiore, una portata che investe, come è stato detto, le rappresentazioni stesse della psicosi, della cura e che colora anche i rapporti tra la cittadinanza e i servizi. La sollecitudine dei servizi, la possibilità di muoversi dentro un registro cooperativo da questi promosso, la completa trasparenza dei processi decisionali, la consapevolezza che la propria domanda sarà, in ogni caso, presa in carico, genera un circolo virtuoso in cui l’esperienza psicotica, non viene vissuta come qualcosa da nascondere o negare, quanto un problema come altri, da gestire, che può trovare una risposta concreta, immediata, flessibile e realmente centrata sui propri bisogni. I servizi sono quindi interpellati in prima istanza e non rappresentano più l’ultima spiaggia nella deriva individuale e familiare.
L’OD costituisce un incentivo ed un esplicito invito da parte delle istituzioni alla partecipazione della famiglia e della rete sociale al processo di guarigione. Tale invito sembra andare nella direzione di una riapproriazione della salute da parte della comunità, resa possibile solo grazie alla cessione, da parte del sistema medico, di una quota del proprio potere, contrariamente a quella che Illich definiva “l’espropriazione della salute” (Illich, 2005) del sistema medico e che descriveva come uno dei risultati della iatrogenesi sociale ovvero da quel processo generato dall’espansione pervasiva della medicina che porta l’ambiente ad essere privato delle condizioni che permettono agli individui, alle famiglie e alle comunità di occuparsi autonomamente della propria salute.
Il sistema OD al contrario restituisce alla famiglia, alla rete sociale e alla collettività il potere di co-determinare il proprio percorso di cura. Il sistema medico cede loro parte di quel potere di cui è detentore e che gli è stato conferito per una delega politica. La cittadinanza demanda un’istituzione alla cura e questa, di rimando, invita la famiglia a partecipare. Questo processo è retto da un autentico interesse reciproco (istituzione medico-familiare) al servizio dell’individuo sofferente. All’interno del setting il nucleo familiare si riappropria di una parte di quel potere contrattuale che per Basaglia era precluso ad alcuni, in un rapporto di sopraffazione e di violenza tra potere e non potere, che si tramuta nell’esclusione da parte del potere del non potere.
L’abbattimento del tasso di cronicizzazione della psicosi non influenza solo direttamente gli attori di questo processo, ma ha un effetto positivo sul fenomeno della stigmatizzazione. Sono ben note le ripercussioni che lo stigma può comportare sul soggetto che ne è vittima. La rapida remissione sintomatica (legata all’avviamento di un tempestivo processo di significazione, invece che di annullamento della sintomatologia psicotica) è possibile porti all’incorporazione, a livello sociale, di un diverso concetto di malattia rispetto ai luoghi in cui non vi è tale remissione. Non si tratta però di esperienze individuali fenomenologicamente distinte rispetto alle nostre, quanto piuttosto di differenze nel trattamento che producono utenti diversi (esiti diversi) e quindi differenti concezioni della malattia, probabilmente più funzionali, sia per la collettività che per il soggetto.
La psicosi, cessando di essere un attributo del soggetto, per collocarsi nello spazio tra i membri di una famiglia o di un piccolo gruppo, viene fronteggiata da tutti i membri del sistema che ne determinano la comparsa e non è più un attributo dell’individuo, ma del sistema-famiglia. E’ questa gestione sinergica, non solitaria, che permette di affrontare e superare la malattia. La psicosi cambia faccia: la persona e la famiglia possono riemergere dall’esperienza traumatica della psicosi, continuare a condurre una vita il cui funzionamento sociale può non essere inevitabilmente compromesso da una diagnosi.
Anche il nostro Paese, talvolta sordo ai richiami e alle evidenze provenienti dai cugini europei, questa volta ha subito il fascino dialogico. In un momento importante di profonda riflessione autocritica rispetto agli esiti del proprio operato la psichiatria avverte, in maniera ambivalente, l’intima esigenza di esperienze più soddisfacenti. Volendo considerare l’istituzione psichiatrica quale luogo del prendersi cura, dovremmo allora poterne modificare la funzione: non più un’istituzione che categorizza e contiene la malattia mentale, ma un’istituzione che in primo luogo promuova quei fattori protettivi per la salute mentale e in cui la prevenzione torni ad avere un ruolo primario. Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 ha inserito tra i suoi obiettivi prioritari la salute mentale e ha assegnato a tutte le strutture sanitarie preposte (Dipartimenti di Salute Mentale, Dipartimenti di Prevenzione, Servizi Territoriali) il compito di intervenire precocemente nelle crisi psichiatriche. A questo proposito è utile sottolineare che gli interventi precoci in psichiatria sono una questione spinosa e discussa. Talvolta l’efficacia e il senso dell’azione terapeutica sono stati sacrificati all’altare della rapidità d’azione stessa, con effetti controproducenti. La prevenzione viene così spesso scambiata per un allargamento, a cerchi concentrici, dei potenziali pazienti, che vanno a costituire così una base sempre più ampia, e che continua a conquistar terreno, da cui attingere i casi che meglio si adattano ai sistemi di cura esistenti (nel caso dei nostri servizi, i farmaci).
Una reale prevenzione ha come obiettivo la promozione della salute nella e della comunità, non può coincidere semplicemente con la riduzione delle conseguenze negative della malattia o della crisi attraverso l’identificazione tempestiva, ma consiste in politiche che promuovano un ambiente che favorisca in tutti, e specialmente nei più deboli, la fiducia in se stessi, l’autonomia, la dignità e capacità personale di far fronte alla vita in modo autonomo e responsabile (Illich, 1976).
Uno dei risultati più sorprendenti e degli effetti più significativi dell’OD consiste proprio in questo, una utilizzazione del tutto nuova, più sapientemente scelta e partecipata, dei servizi territoriali.
In risposta a ciò l’ASL TO1 della regione Piemonte ha presentato al Ministero della Salute- CCM (Centro Controllo Malattie) un progetto di sperimentazione della durata di 24 mesi che ha come obiettivo generale la valutazione della trasferibilità (operativa e organizzativa) del Dialogo Aperto per il trattamento di pazienti in fase di esordio e acuzie nei DSM italiani. Il progetto è esteso su tutto il territorio nazionale e coinvolge regioni del Nord, del Centro e del Sud del Paese. La sfida che si prospetta non è semplice, ma è stata già portata avanti con successo da altri 6 paesi occidentali. Il progetto presuppone certamente una fase di formazione sull’ OD e un adattamento del metodo alla struttura organizzativa dei DSM selezionati in base alle caratteristiche di contesto e sociali dei rispettivi territori, molto differenti rispetto a quelli finlandesi (in termini, ad esempio, di rapporto operatori/abitanti, numero di casi ecc.). Le équipe mobili costituite si occuperanno esclusivamente delle nuove richieste di intervento pervenute al DSM da pazienti residenti nel territorio selezionato per il progetto.
Il progetto è sicuramente ambizioso e non esente dalle criticità che caratterizzano ogni valevole tentativo di cambiamento. Il ricorso a professionisti volontari, necessario per ottimizzare le già limitate risorse esistenti (e per salvaguardare la qualità del progetto che ricade così nelle mani di professionisti realmente motivati) potrebbe creare conflitti, all’interno dei DSM, legati alla presa in carico e alla gestione dei nuovi pazienti. Inoltre potrebbe sorgere scetticismo rispetto alla possibilità di trasferire efficacemente l’OD nei nostri DSM, a causa della radicale differenza rispetto al contesto socioculturale ed economico. Durante la fase di implementazione dell’intervento, sarà necessario lasciare spazio a modalità più democratiche di quelle attuali nella scelta del percorso di cura e a relazioni con i pazienti maggiormente simmetriche e centrate sui loro bisogni.
Un altro interessante aspetto da tenere in considerazione sarà la valutazione del rapporto costo/benefici del Dialogo Aperto. Sebbene non siano state condotte delle specifiche analisi in merito a ciò, possiamo tentare di leggere l’implementazione dell’OD alla luce del contesto economico e dei finanziamenti al sistema di cura pubblico nella regione finlandese. A causa della profonda recessione del 1991 , i fondi per i servizi psichiatrici nella Lapponia occidentale sono diminuiti del 33%, configurandosi tra i più bassi di tutti i distretti sanitari finlandesi. Tuttavia questa situazione non ha influenzato negativamente la qualità del trattamento dei pazienti psicotici.
Attualmente, il costo pro-capite dell’assistenza psichiatrica in questa regione è il più basso di tutta la Finlandia. Inoltre lungo questi anni si è anche registrata una riduzione del numero totale di letti ospedalieri (e delle spese correlate) da 320 a 66, in seguito alla ricollocazione dei pazienti nelle proprie case. Questo nuovo sistema ha letteralmente svuotato i reparti psichiatrici di un ospedale che negli anni ‘80 era gremito di pazienti considerati cronici e incurabili. Quali potrebbero essere i risultati attesi nei nostri SPDC che riversano in situazioni di cronici affanni e sovraccarichi? Dovremo attendere un pò per rispondere al quesito.
Quando si chiede a Seikkula come sia stato possibile realizzare un cambiamento di questa portata e come sia pensabile la sua traduzione in altri contesti, si riceve sempre la stessa risposta: [blockquote style=”1″]Il Dialogo Aperto non è un modello da seguire uniformemente da luogo in luogo. Siamo realmente contrari alla generalizzazione dei modelli di trattamento psichiatrici, piuttosto siamo dell’idea che ogni pratica debba naturalmente seguire le condizioni e la cultura della società in cui è applicata. Allo stesso tempo, però, consideriamo il Dialogo Aperto non un metodo, ma uno stile di vita. Quando nasciamo, la seconda cosa che impariamo a fare, dopo respirare, è quella di coinvolgerci in relazioni dialogiche. Questo significa che quando organizziamo gli incontri di Dialogo Aperto stiamo tornando all’idea davvero essenziale, basica, della vita umana, non stiamo applicando un metodo. Come professionisti dobbiamo imparare a seguire il modo di vivere e il linguaggio dei nostri pazienti, completamente, interamente, senza eccezioni o pregiudizi. Non è facile. Ma questo è il vero cambiamento.[/blockquote]
ARTICOLO CONSIGLIATO:
La capacità di metacognizione come focus di trattamenti della schizofrenia
BIBLIOGRAFIA:
- ALANEN ,Y.O.(2005), La schizofrenia. Le sue origini e il trattamento adattato al bisogno. Giovanni Fioriti Editore, Roma.
- ANDERSON, H., GOOLISHIAN, H. (1988) A view of human systems as linguistic systems: some preliminary and evolving ideas about the implications for clinical theory. Family Process, 27: 371-393.
- BALTER, M. (2014) Talking Back to Madness. Science, Vol. 343 no. 6176 pp. 1190-1193
- BASAGLIA, F.(1968), L’istituzione negata. Baldini Castoldi Dalai, Milano.
- BATESON, G.(1977), Verso un’ecologia della mente. Adelphi, Milano.
- BOURDIEAU, P.(1980), Le Sens pratique. Minuit, Paris.
- ILLICH, I.(1976), Medical Nemesis. Trad. it. Nemesi medica. L’espropriazione della salute. (2005) Boroli, Milano.
- KLEINMAN, A.(1978), “Cultural Construction of clinical reality: comparison of practitioner-patient interaction in Taiwan”.In KLEIMAN, A. ET AL. (a cura di), Culture and Healing in Asian Societies. Shenkman, Cambridge, Massachusetts.
- MATURANA, H.(1988) Reality: the search for objectivity or the quest for a compelling argument. The Irish Journal of Psychology (Special Issue), 9: 144-172. DOWNLOAD
- SEIKKULA J., AALTONEN J., ALAKARE B., HAARAKANGAS K., KERANEN J., LEHTINEN K.(2006). Five-year experience of first-episode non-affective psychosis in open-dialogue approach: Treatment principles, follow-up outcomes, and two case studies. Psychotherapy Research 16, 2, 214–228.
- SEIKKULA, J.(a cura di Chiara Tarantino) (2014) Il dialogo aperto. L’approccio finlandese alle gravi crisi psichiatriche. Giovanni Fioriti Editore, Roma.
- WHITAKER, R.(2013), Indagine su un’epidemia. Giovanni Fioriti Editore, Roma
- WIMMER A.( tradotto da Schioldann, J.) (2003) Psychogenic Psychoses. Adelaide Academic P