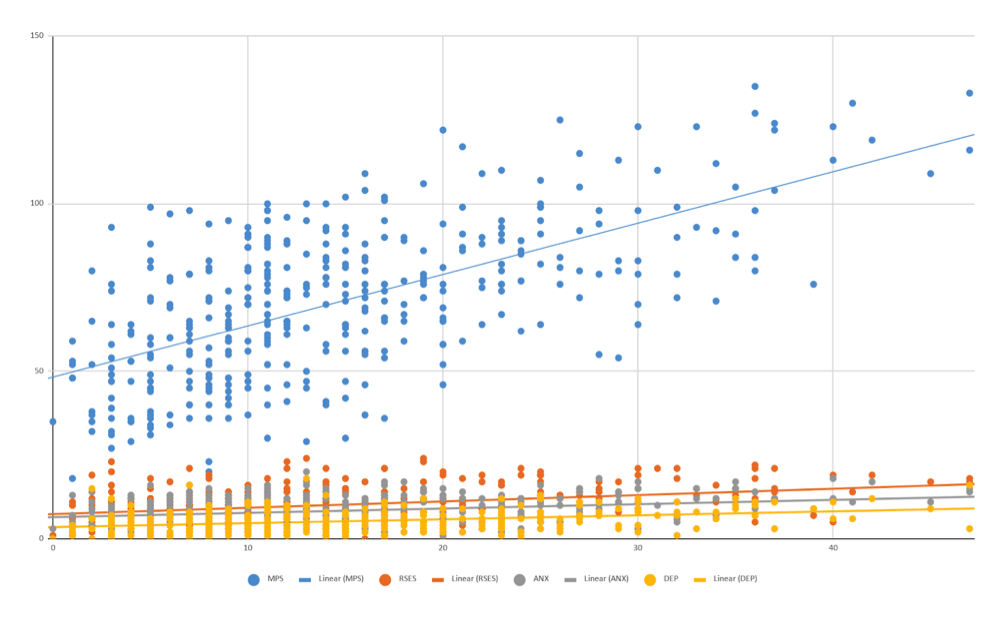La recovery dai disturbi alimentari: il punto di vista dei pazienti
La ricerca qualitativa si è dimostrata particolarmente idonea per indagare aspetti che difficilmente potrebbero essere catturati con altrettanta profondità dalle ricerche quantitative. Il processo e l’esperienza di remissione da un disturbo alimentare, così come descritti e narrati dai pazienti, hanno il potenziale di essere una ricca fonte di informazioni fornendo nuove comprensioni e preziosi contributi per la creazione di piani di trattamento più efficaci.
Elisa Petetta – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Recentemente, le
ricerche condotte con l’impiego di metodologie di stampo qualitativo, stanno assumendo un crescente utilizzo e stanno iniziando ad essere adoperate per indagare numerosi aspetti connessi ai vissuti e alle problematiche di svariate psicopatologie. Le particolari caratteristiche che contraddistinguono questo modo di fare ricerca contribuiscono a connotare la ricerca qualitativa di elementi che la rendono particolarmente idonea, laddove condotta nel rispetto di procedure rigorose e rintracciabili, ad indagare aspetti che difficilmente potrebbero essere catturati con altrettanta profondità dalle ricerche condotte con disegni di ricerca quantitativi che, per definizione, fanno impiego di strumenti maggiormente standardizzati.
Accanto a questa proliferazione di ricerche assistiamo anche ad un crescente interesse verso i vissuti esperienziali dei pazienti, a come questi ultimi sperimentano la loro malattia e a come riescano a raggiungere, da questa, uno stato di remissione. L’attenzione a come il paziente percepisce lo stato di guarigione e a ciò che è più funzionale o, di contro, ostacolante in questo processo, sta divenendo un ambito di ricerca in molte psicopatologie compresi i disturbi alimentari (DA).
I disturbi dell’alimentazione sono disturbi particolarmente complessi, caratterizzati da un’alterazione delle abitudini alimentari e da un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. Stanno avendo una sempre più larga diffusione, per genere, fasce di età e area geografica. Insorgono prevalentemente durante l’adolescenza, interessando soprattutto il sesso femminile e possono alterare il normale corso dello sviluppo (Berkman, Lohr, & Bulik, 2007). Gli aspetti collegati alle comorbilità di questi disturbi, alle gravi complicanze a livello fisico, sociale, relazionale e a quelli di cronicità, li rendono disturbi difficili da riconoscere precocemente, trattare e dai quali ottenere una remissione completa.
Il concetto di recovery è emerso a partire dagli anni Novanta del secolo scorso ed è un aspetto sempre più importante all’interno dei servizi che si occupano di salute mentale. I processi di recovery appaiono spesso complessi e difficili da misurare e possono essere compresi in maniera più approfondita focalizzandosi sulle prospettive dei pazienti mediante l’impiego di metodi di ricerca di stampo qualitativo (Jacobson, 2001).
La ricerca qualitativa impiega numerosi metodi per la raccolta e l’analisi dei dati che si distinguono tra loro in quanto si basano su assunti epistemologici specifici e per i quali non è presente una tassonomia definita. I principali sono la Grounded Theory (Glaser & Stauss, 1967), l’etnografia (Remotti & Fabietti, 1997), i focus group, (Albanesi, 2004) e l’approccio narrativo come il metodo delle storie di vita (Lieblich, Tuval-Mashiac & Ziber, 1998). Altri metodi che possono essere impiegati sono l’analisi del discorso (Van dijk, 1997) e l’analisi della conversazione (Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974).
Le caratteristiche essenziali che possono descrivere questo tipo di approccio sono:
- l’impiego di metodi di raccolta dei dati open-ended;
- l’uso di parole e immagini visive al posto di dati statistici per descrivere eventi o esperienze psicologiche;
- la convinzione che le scoperte siano costruite socialmente piuttosto che sia la “verità”ad essere scoperta;
- il focus costante sul participant meaning (Hill, Knox, Thompson, Williams, Hess &Ladany, 2005).
Per quanto riguarda i tassi di guarigione da un disturbo alimentare, questi oscillano nelle ricerche tra il 24 e il 76% (Katzman, Golden, Neumark-Sztainer, Yager, &Strober, 2000; Zipfil, Lowe, Reas, Deter, & Herzog, 2000). Le differenze nei tassi sono dovute parzialmente alle varie definizioni applicate al concetto di guarigione, così come ai criteri impiegati per definirne il raggiungimento (peso corporeo, severità dei sintomi accusati, comportamenti riguardanti l’assunzione di cibo e ricomparsa e stabilità del ciclo mestruale) (Herzog, Nussbaum, &Marmor, 1996). Questi criteri tuttavia sono stati messi in discussione dal momento che è stato rilevato come alcuni pazienti con anoressia nervosa (AN) che sono riusciti a recuperare il loro peso precedente, mantengano degli atteggiamenti controversi nei riguardi del cibo e delle forme del proprio corpo (Fenning, Fenning, & Roe, 2002) e altri, nonostante abbiano sospeso la pratica di comportamenti alimentari disfunzionali, continuano ad esibire problemi psichiatrici e limitazioni nel funzionamento sociale e lavorativo . Quando la remissione da un DA viene determinata solo dai clinici e dai ricercatori, importanti aspetti di questo processo potrebbero essere sottovalutati e fattori di natura psicologica dovrebbero essere considerati nella valutazione della recovery. Una valutazione globale, che tenga conto sia dei fattori fisici che psicologici, è molto rara e difficile da perseguire e non sempre fattibile nella pratica clinica (Couturier & Lock, 2006).
Il processo e l’esperienza di remissione da un disturbo alimentare, così come descritti e narrati dai pazienti, hanno il potenziale di essere una ricca fonte di informazioni fornendo nuove comprensioni e preziosi contributi per la creazione di piani di trattamento più efficaci.
Tra i temi ricorrenti che emergono dagli studi qualitativi ci sono i turning points o punti di svolta. Questi vengono definiti dalle pazienti come momenti o eventi particolari fondamentali per intraprendere l’iter verso la guarigione. Possono essere descritti come epifanie, altre volte sono più graduali, ma in ogni caso fungono da fattori di innesco per la presa di decisione. La malattia o la scomparsa di una persona cara ha agevolato la scelta di vivere in alcuni pazienti con AN (Nillson& Hӓgglöf, 2006; Mitchison, Dawson, Hand, Mond, &Hay, 2016), così come il giungere a pensare di togliersi la vita (Dawson, Rhodes, &Touyz, 2014). I turning points possono essere anche eventi spaventanti connessi alla propria salute:
Stavo malissimo e penso che quello sia stato un punto di svolta per me […] ogni volta che vomitavo sentivo le palpitazioni forti del mio cuore e sudavo freddo, […], mi resi conto che se avessi continuato così sarei morta, perché quello non era normale…sapevo solo che qualcosa doveva cambiare. (Patching & Lowler, 2009, p.17)
Altri eventi individuati sono stati ad esempio il collasso in spiaggia per una giovane paziente con AN, l’irregolarità e velocità del proprio battito cardiaco durante un episodio di vomito auto indotto per un’altra affetta da bulimia nervosa (BN) (D’Abundo & Chally, 2004) e l’ospedalizzazione (D’Abundo & Chally, 2004; Matoff & Matoff, 2001). Alcune pazienti descrivono di aver fatto esperienza di una sorta di “click”, o switch mentale alla cui base ci può essere anche il riconoscimento di nuovi bisogni, in aree diverse della vita, aldilà delle restrizioni offerte dai disturbi alimentari:
[Mi stavo chiedendo] come posso essere felice nella mia vita?…è come se stessi sprecando il mio tempo facendo quello [le abbuffate]. Non stavo facendo nient’altro..non avevo un buon lavoro, non avevo un’educazione…dovevo impiegare le mie capacità per fare qualcos’altro. (Krentz et al., 2005, p. 124)
I “click” possono essere innescati anche da commenti sullo stato di deprivazione fisica o sulle conseguenze negative dei disturbi dell’alimentazione:
Il mio dottore mi disse che mi stavo bruciando l’esofago e che sarei potuta morire…e allora ho iniziato a riflettere se liberarmi o meno dal disturbo e… ho capito che non volevo assolutamente morire! (Las Hayas et al., 2015, p.13)
Anche aspetti connessi alla maternità possono fungere da improvvisi punti di svolta, sia che si declinino nello scoprire di aspettare un figlio (Lindgren, Enmark, Bohman, & Lundström, 2015), sia nell’apprendere di averlo perso a causa delle compromissioni fisiche causate dalla malattia (Weaver, Wuest & Ciliska, 2005).
La comprensione e l’accettazione delle conseguenze negative causate dal disturbo in molti contesti della vita sono aspetti frequentemente implicati nel percorso di guarigione. Possono riguardare le complicanze fisiche legate ai DA, come i danni all’esofago a causa del vomito autoindotto o la connessione tra le aritmie, i collassi e la protratta malnutrizione (Lindgrenet al., 2015). Altre conseguenze negative emerse sono i sentimenti di imbarazzo provati per i propri comportamenti alimentari, la sofferenza psichica e fisica causata dagli episodi di abbuffate e dai conseguenti meccanismi di purging, le difficoltà di concentrazione e la sensazione di stanchezza e spossatezza costanti (D’Abundo & Chally, 2004). Molte pazienti riportano di aver preso coscienza di come il disturbo alimentare abbia impedito loro di ottenere i risultati sperati come terminare l’università o migliorare la propria carriera (Jenkins & Ogden, 2012; Matoff & Matoff, 2001). In senso più ampio, le riflessioni delle pazienti si possono allargare anche alla presa di coscienza delle ristrette possibilità di vita offerte dalla malattia:
Ad un certo punto ho iniziato a pensare a tutte le cose che avrei potuto ancora perdere e a tutte le cose che invece avrei voluto fare, e tutti i Paesi che avrei voluto visitare. (Lindgrenet al., 2015, p. 864)
Anche accettare che molte occasioni lavorative non sono state colte o che non si è riusciti ad istaurare delle relazioni intime a causa del disturbo fa parte del percorso:
Sento un grande dolore perché ho speso 25 anni della mia vita con la bulimia e ora so che molti treni sono passati e che ormai li ho persi. (Pettersen, Wallin & Björk , 2016, p.6)
La recovery viene descritta come un processo nel quale le donne sentono di aver riguadagnato il controllo delle loro vite, ad esempio decidendo di alimentarsi in maniera più sana:
Penso che il fattore più importante per me per star bene è stato assumere il controllo in un modo sano piuttosto che in un modo non sano. La malattia ha controllato la mia vita e dal momento che ho deciso [di voler star meglio], ho riassunto il controllo sulla mia alimentazione…e così ho iniziato a sentire di nuovo anche altre cose nella mia vita di più sotto il mio controllo. (Patching & Lowler, 2009, p. 7)
Come è emerso dallo studio di Lamoureux e Bottorff (2005) il potere e il controllo offerti dall’AN sono fattori che aumentano la vulnerabilità dei soggetti e rendono più difficile il distanziamento progressivo dalla malattia. Una “cura consapevole di sé attraverso un’alimentazione sana” (Weaveret al., 2005) e un “avvicinarsi a dei comportamenti sani e salutari” (D’Abundo & Chally, 2004) vengono descritti dalle pazienti come modalità efficaci e non più distorte attraverso le quali poter riacquistare il controllo perso a causa del disturbo:
Credevo che non mangiando potessi ottenere il controllo. Ad un certo momento ho improvvisamente realizzato che solo mangiando, potevo ottenerlo. […] Quando smetti di mangiare sei veramente fuori controllo. Ora mangio in maniera sana e ho il controllo della mia vita! (D’Abundo&Chally, 2004, p.1102)
Alcuni fattori connessi al ruolo delle terapie e dei trattamenti vengono ritenuti particolarmente importanti, come ad esempio la disponibilità all’ascolto da parte del terapeuta e la sua empatia, la possibilità per il paziente di avere una certa quota di controllo sul piano di trattamento e il sentirsi aiutato nell’identificare le cause profonde del disturbo (Jenkins e Ogden, 2012).
Aspetti problematici per alcune pazienti sono stati trovare un terapeuta con la necessaria esperienza e il controllo del peso, considerato come un elemento che accentua la sensazione di essere ancora
“giudicate da una scala” (Arthur-Cameselle e Quatromoni, 2014). Il focus eccessivo sul peso e sulle misure viene percepito come un elemento ostacolante laddove molte donne ritengono che i trattamenti dovrebbero riporre enfasi maggiore alla salute e al benessere a livello globale (Linville, Brown, Sturm, &McDougal, 2012). Gli obiettivi raggiunti in termini di peso riacquistato o stabilizzato vengono considerati come tra i punti più bassi nel processo personale di recovery:
L’ho raggiunto [il target di peso] […] ma un sacco di cose nella mia testa non sono cambiate…il trattamento è stato molto focalizzato sul fisico e loro [i dottori] non guardavano al lato mentale delle cose e sebbene misi su del peso, non prendevano realmente in considerazione cosa la mia mente stesse facendo, dicevano – stai molto meglio, tu dovresti sentirti meglio – ma dentro di me non lo ero, non lo ero per niente! (Jenkins&Ogden, 2012, p. 27)
La figura del nutrizionista è stata ritenuta di supporto solo quando ha provveduto a fornire piani personalizzati e graduali, mentre in altri casi è stato controproducente:
Sono andata due volte [dal nutrizionista], ma personalmente pensavo che mi facesse più male che bene perché dovevo scrivere ogni cosa che mangiavo…la passione delle anoressiche proprio…misurare, controllare ogni piccolo pezzettino di cibo che viene inserito in bocca. (Arthur-Cameselle&Quatromoni, 2014, p. 8)
Essere non giudicate e ricevere un atteggiamento compassionevole sono fattori molto importanti, laddove invece, non sentirsi comprese o l’essere trattate con superiorità o con sufficienza vengono rintracciati come elementi ostacolanti la guarigione (Fogarty & Ramjan, 2016). L’aiuto maggiore è stato percepito quando i terapeuti si sono aperti alla prospettiva delle donne concentrandosi nell’ascolto di cosa fosse ritenuto per loro rilevante e nel prendersi cura della loro sofferenza piuttosto che approcciarsi con un insieme di preconcetti o di risposte preimpostate (Weaveret al., 2005). Il bisogno di essere coinvolti nelle decisioni riguardante la recovery può significare anche negoziare le condizioni per l’acquisizione del peso e su quanto rapidamente ciò debba avvenire (D’Abundo e Chally, 2004).
Per alcune donne la guarigione dal disturbo alimentare ha comportato riscoprire un senso di libertà anche nei confronti del rapporto con il cibo. Questa libertà, nel caso della BN, è espressa da una nuova capacità di gustare cibi una volta proibiti, come i dolci senza diventare ansiosi o cibi non salutari senza abbuffarsi né mettere in atto comportamenti compensatori (Lindgrenet al., 2015). Nel percorso viene sottolineato come le pazienti abbiano provato spesso sentimenti di ambivalenza e paura collegate alla necessità di mangiare esclusivamente cibo salutare seguendo una routine. Dopo la recovery una parte dei soggetti sembra aver sviluppato una competenza alimentare maggiore, mentre un’altra sperimenta ancora vissuti di disagio nelle interazioni sociali che vedono il cibo coinvolto e difficoltà nel capire i livelli di sazietà:
é ancora difficile capire quando sono sazia. A volte penso di esserlo e mangio il resto per ghiottoneria. Non so esattamente quando mangiare di più o di meno, non so realmente se mi sento soddisfatta, mangio tutto quello che c’è nel piatto e punto, è tutto. (Ulianet al., 2013, p. 279)
I soggetti fanno esperienza di una “dualità” tra la voce anoressica residuale, che richiederebbe loro di restringere l’intake calorico, e le nuove competenze acquisite durante la terapia, che invitano invece a bilanciarlo e adeguarlo ai propri bisogni. Spesso, dopo anni passati con il disturbo, le pazienti hanno dovuto “reimparare” a mangiare normalmente e ad avere una relazione sana e spontanea con il cibo, il peso e il proprio corpo:
Non avevo idea di cosa fosse una normale porzione di cibo. Ho dovuto imparare tutto di nuovo come farebbe un bambino. (Pettersenet al., 2012, p.4)
Dopo la recovery la questione di cosa e quanto mangiare non è più così dominante nelle loro vite quotidiane:
Ora posso gustare quello che mangio e me lo permetto […] e non mi preoccupo più un’intera settimana se sono stata invitata da qualche parte e non ho il controllo sul pasto che verrà servito. (Björk & Ahlström, 2008, pp. 932-933)
Una flessibilità maggiore viene acquisita anche sfidando le regole auto imposte su cosa è permesso mangiare e su cosa non lo è, abbandonando anche la rigidità nei confronti degli orari dei pasti (Pettersenet al., 2016). Nel caso particolare del binge eating disorder (BED) è stato evidenziato lo sforzo delle pazienti nello sperimentarsi in maniera nuova con il cibo, eliminando o modificando le precedenti regole imposte, prestando maggiore attenzione al rispetto dei pasti e alla consapevolezza di quanto assumono:
Non mangio più di corsa, ma provo a…pianificare i pasti. […] Almeno tre pasti al giorno e non ho eliminato nessun specifico alimento perché appena provo a farlo comincio ad esserne ossessionata. (Krentzet al., 2005, p. 126)
Mangiare poi in maniera regolare evitando di acquistare troppo cibo, non avere bilance in casa e mantenere un peso stabile trovando un equilibrio con una regolare attività fisica, viene impiegata anche come strategia per evitare possibili ricadute (Björk, Wallin & Pettersen, 2012).
Lo sport e l’attività fisica possono essere visti sia come elementi di supporto alla recovery (Las Hayeset al., 2015; Nillson & Hӓgglöff, 2006) sia aspetti per i quali si deve trovare maggiore equilibrio se venivano adoperati in maniera compulsiva o compensatoria. Durante il processo di recovery, l’attività fisica può essere utilizzata per tenere sotto controllo il peso, per regolarizzare il tono dell’umore, ma anche per diminuire l’ansia sperimentata nei confronti delle preoccupazione verso le proprie forme corporee. Un processo caratteristico di questa fase è quello che riguarda la trasformazione dell’esercizio da un set di comportamenti e pensieri compulsivi e dannosi a un’attività bilanciata dalla quale trarre ristoro e divertimento, sino a diventare parte di uno stile di vita sano e equilibrato (Young, Rhodes, Touyz, &Hay, 2015). Nel caso di pazienti atlete, i progressi migliori si sono presentati quando le ragazze si sono rese conto che le proprie performances miglioravano se si nutrivano in maniera corretta e lo sport ha contribuito ad allentare la paura di aumentare di peso che è spesso una barriera alla recovery:
Se vuoi fare ogni cosa al meglio devi avere l’energia altrimenti non puoi farcela. (Arthur-Cameselle&Quatromoni, 2014) p.340)
L’ambiente sportivo può essere utile perché aiuta ad avere uno scopo ma nello stesso tempo può anche essere d’ostacolo a causa delle pressioni subite per eccellere e delle norme stringenti che ruotano intorno all’esercizio e al cibo o favorire le ricadute quando i propri compagni sono ancora affetti da Disturbi Alimentari.
Un’ attività che viene ritenuta particolarmente utile dalle pazienti è lo yoga, che per molte pazienti ha contribuito a favorire la riconnessione con se stesse ad istaurare una relazione più positiva con il proprio corpo (Hay&Cho, 2013; Lamoureux & Bottorff, 2005).
Nel processo di recovery il ruolo del supporto sociale è il fattore più menzionato e in alcuni casi è stato identificato dalle pazienti come un fattore fondamentale (Arthur-Cameselle & Quatromoni, 2014; Las Hayas et al., 2015; Hay & Cho, 2013; Pettersen & Rosenvinge, 2002). Le relazioni sono essenziali alla recovery, sia perché provvedono a fornire amore incondizionato, supporto, fiducia e speranza durante l’intero percorso (Dawson et al., 2014), sia perché forniscono il contesto ideale per mettere in pratica e familiarizzare con le nuove strategie di coping o con le skills apprese durante l’eventuale trattamento (Matoff&Matoff, 2001).
Per alcune pazienti ad esempio, nonostante l’utilità del supporto psicologico, la presenza di un persona particolarmente importante è stato individuata come il fattore essenziale per la guarigione (D’Abundo &Chally, 2004; Moulding, 2015). La persona identificata è più frequentemente la madre, il partner ma anche il padre (D’Abundo & Chally, 2004). Il supporto da parte degli amici viene individuato come un fattore importante, perché questi ultimi possono essere d’esempio per stili di vita più equilibrati (Nillson & Hӓgglöff, 2006). Il partner può esercitare sia un’influenza sia positiva che negativa, influendo sull’autostima delle donne in base all’importanza attribuita da quest’ultimo al peso e all’aspetto (Granek, 2007). Altre pazienti hanno riconosciuto come importante anche il supporto di altri individui con Disturbi Alimentari (Dawson et al., 2014; Hay&Cho, 2013). perché le ha aiutate a capire di non essere le sole o ad incitarle a chiedere aiuto. Le relazioni possono essere anche d’ostacolo quando i pazienti non si sentono compresi da familiari o amici che non conoscono il disturbo alimentare, che lo rilegano ad una questione di vanità o di richiesta di attenzione o che ridicolizzano la loro battaglia (Las Hayas et al., 2015; Linville et al., 2012), ed ha un peso importante anche nel favorire le ricadute (Federici & Kaplan, 2007). Un fattore di ostacolo viene rintracciato anche nella sensazione di apprezzamento e di approvazione da parte dei pari che supportano la perdita di peso (Granek, 2007).
Intraprendere nuove sfide e attività, come l’attivismo politico, il volontariato o nuovi hobbies come scrittura, pittura, danza, canto, lettura e i viaggi (Las Hayas et al., 2015; Matusek & Knudson, 2009), sono stati riferiti come fattori importanti nel sostenere il percorso. E’ stato evidenziato anche il beneficio apportato dall’acquisto e dall’accudimento di un animale domestico (Hay & Cho, 2013; Matoff&Matoff, 2001).
Nuovi interessi e attività sono stati identificati come utili perché hanno permesso alle pazienti di distanziarsi dalla malattia che tende a consumare il loro tempo e la loro energia (Hay&Cho, 2013). Anche il coinvolgimento in una causa o in un obiettivo comunitario sentito come più grande viene individuato come
Un modo per cercare attivamente alternative per dare senso al mondo e trovare valore nella vita aldilà della prigione sperimentata a causa del DCA. (Matusek & Knudson, 2009, p.704)
Diventare capaci di mantenere un’occupazione giornaliera come il lavoro o la scuola sono considerati aspetti altrettanto importanti.
Molte pazienti riportano come abbiano iniziato a modificare gradualmente i propri patterns di pensiero imparando a “priorizzare le cose importanti della vita”, accettando l’immodificabilà di alcuni eventi e potenziando i dialoghi interni positivi. Alcune strategie riportate dalle pazienti per modificare la mentalità anoressica sono state diventare consapevoli di alcune idee distorte, come quella che mangiare rende “cattive persone” o che aumentare di peso significa diventare automaticamente obese, e lavorare per decostruirle. Questo lavoro ha comportato anche lo sfidare le credenze relative al fatto che l’AN fosse l’unico mezzo per raggiungere l’autostima. Riconoscere tutti questi come “pensieri anoressici” o “pensieri sbagliati” potendosene poi distanziare le ha aiutate a sviluppare una prospettiva più accurata sulle loro vite e su se stesse. Per molte donne questo processo riflessivo è stato facilitato dal possedere un diario nel quale annotare il pensiero “corretto” e quello “distorto” (Lamoureux & Bottorff, 2005; Linvilleet al., 2012). Quando le pazienti hanno iniziato a pensare in maniera più razionale, hanno cominciato anche a realizzare che il cibo, il nutrirsi correttamente e adeguatamente è necessario e fondamentale alla sopravvivenza:
Pensare che si può buttar giù solo una cosa per cena e vivere è molto irrazionale. Ora so che non si possono affrontare i problemi in questo modo. (D’Abundo&Chally, 2004, p. 1102)
Mi sento forte, mi sento bene, forse mangiare non è così sbagliato perché mi fa sentire meglio. Se posso sentirmi così, forse, aver preso giusto un po’ di peso non è una cosa così brutta. (Lamoureux&Bottorff, 2005, p. 179)
Sebbene talvolta ci siano momenti nei quali sentono ancora le voci critiche interiori hanno appreso nuove strategie di coping e attività che le hanno aiutate a smorzare le litanie mentali punitive o a gestire più efficacemente le loro emozioni (Matoff & Matoff, 2001). Lo sviluppo di queste nuove strategie richiede tuttavia molta disciplina e persistenza. Anche i comportamenti più salutari devono essere praticati ripetutamente fino a quando viene creato un nuovo stile di vita:
Ho cambiato il mio atteggiamento mentale e il mio modo di pensare. Ho iniziato a credere sempre più che mangiare equivale a salute, benessere, libertà, e scelta. È stato quasi come se mi fossi riprogrammata, come si fa con i computer…è stato difficile cambiare il mio modo di pensare perché è come se mi sono dovuta fare il lavaggio del cervello. (Dawson et al., 2014, p. 501)
L’inclusione di una dimensione spirituale nella propria quotidianità è stata riportata come un aiuto nel processo di accettazione di se stesse e dei loro corpi e ad iniziare a nutrire stima per quello che sono e viene declinata nell’avere speranza, nel valorizzare la vita ed avere fede (D’Abundo & Chally, 2004; Linville et al., 2012). Alcune pazienti hanno riferito che l’aver instaurato una relazione con una “forza superiore” le ha aiutate a riconoscere come i loro comportamenti fossero autodistruttivi e pericolosi per la loro salute. Una giovane riporta di aver smesso di abbuffarsi e vomitare durante la Quaresima: “può suonare strano, ma l’ho fatto solo per Dio” (D’Abundo &Chally, 2004, p. 1101).
La mancanza di speranza viene riportato dalle pazienti come uno tra gli ostacoli maggiori del percorso (Dawson et al., 2014) e se la speranza non proviene dalle pazienti può essere utilmente infusa anche da chi si trova loro accanto come ad esempio dalla famiglia (Las Hayas et al., 2015). Apprendere di percorsi completati da altri con successo infonde validazione e speranza, soprattutto nei momenti in cui si sperimentano i maggiori dubbi e reticenze, come in riferimento ad alcuni ostacoli alla guarigione come il temuto aumento di peso. Sono soprattutto i percorsi sentiti come più rassomiglianti ai propri ad evocare un senso di speranza maggiore nelle pazienti (Shaw & Homewood, 2015),
Un elemento giudicato fondamentale è giungere e nutrire l’accettazione di se stesse :
Desidero essere esattamente come sono. Riconosco che c’è una componente genetica nel mio corpo che mi fa essere così e lo accetto. Questo è stato un input importante per accettare me stessa così come sono. (Krentzet al., 2005, p. 125)
Alcune pazienti hanno iniziato a vedere i loro corpi più realisticamente enfatizzando le potenzialità realizzabili attraverso questi ultimi e gli aspetti connessi alla salute. Alcune donne hanno smesso di pesarsi, concentrandosi di più sui segnali della fame e lasciandosi guidare da questi (Krentzet al., 2005), giungendo ad avere un rapporto con il peso meno teso e reagendo ad un’eventuale aumento non come se fosse “la fine del mondo” (BjöRk & Ahlström, 2008). Accettare il proprio corpo ha significato per molte pazienti cominciare a sentirsi a proprio agio con le altre persone ed essere in grado di avere una relazione con un partner stabile condividendone l’intimità (Pettersen & Rosenvinge, 2002). Soprattutto le relazioni intime hanno contribuito nell’accettazione delle proprie forme corporee (Jenkins & Ogden, 2012). Una cura maggiore di sé e dei patterns di vita più regolari hanno aiutato altri pazienti a concentrarsi più su se stessi, ad essere più amorevoli nei propri confronti, a scoprire e soddisfare i propri bisogni e a sentire di “meritare” la guarigione (Pettersenet al., 2016). Alcune pazienti riportano inoltre che certi tratti di personalità, che a loro avviso hanno giocato un ruolo essenziale nello sviluppo del disturbo, siano stati adoperati per facilitare i cambiamenti positivi (ad esempio la pazienza, la resistenza, la determinazione e il perfezionismo). L’auto accettazione poi, unita alla determinazione, ha potenziato anche il ritmo e la velocità del processo di recovery (Patching & Lowler, 2009). Alcune pazienti hanno adoperato termini come “trovare me stessa”, “celebrare me stessa” (Weaveret al., 2005) o “diventare la reale me stessa” (Lamoureux & Bottorff, 2005) o “scoprire la vera me stessa” (Williams et al., 2016) per riferirsi alle ultime fasi del lungo e complicato processo verso l’autoaccettazione:
quando tu stai bene e quando se ne è andata [l’AN] tu sarai semplicemente tu, tu non sarai l’anoressica, tu sarai te stessa. (Williams et al., 2016, p. 222).
Imparare ad amarsi ha contribuito inoltre ad avere maggiore compassione verso se stessi e gli altri tollerando le imperfezioni umane e a sviluppare la capacità di essere più indulgenti.