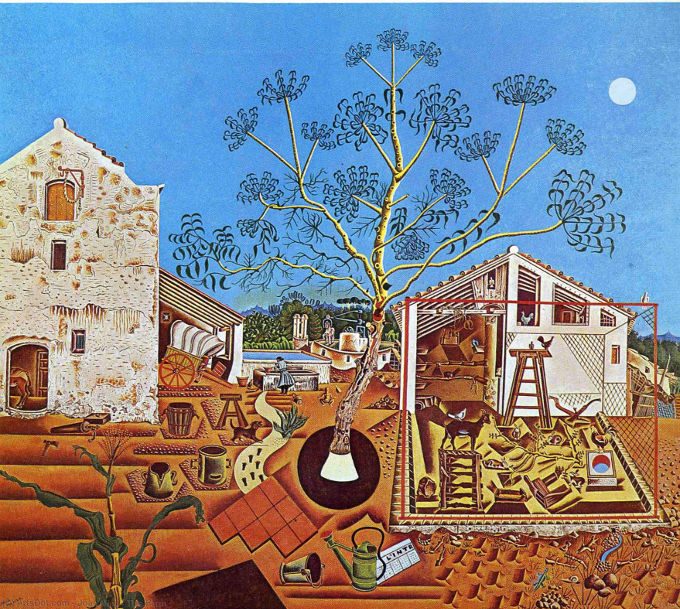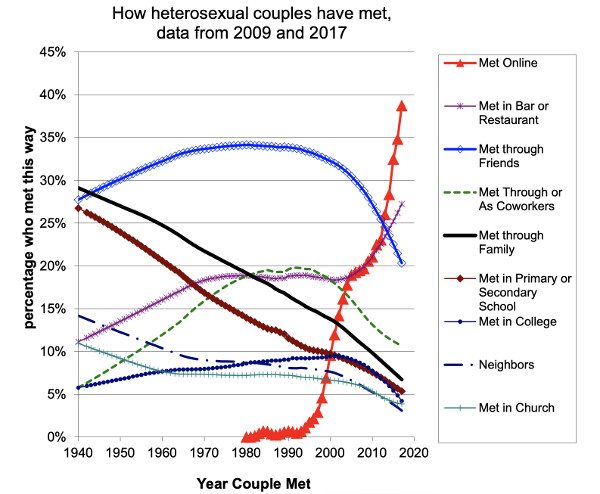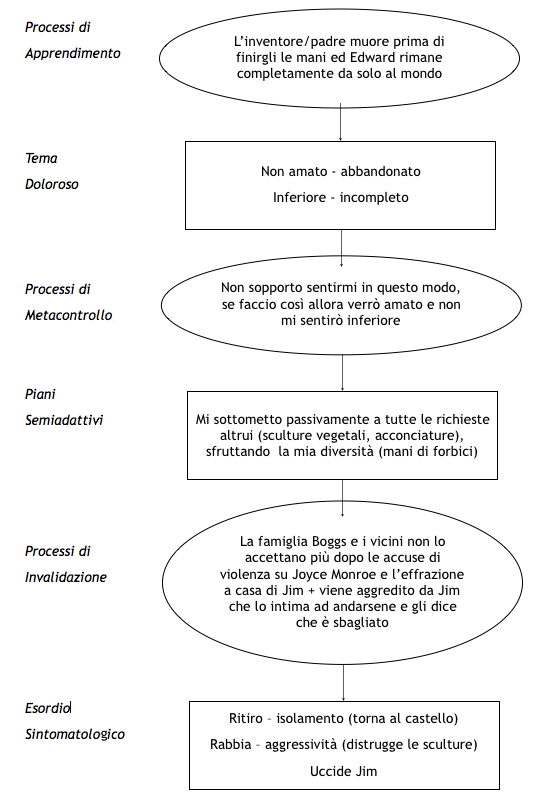ASMR, la nuova tecnica di rilassamento sul web
La Risposta Autonoma dei meridiani Sensoriali (ASMR) ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico negli ultimi anni. Questa esperienza sembra comune a molti, ma tanti altri non riescono a sperimentarla. Perché questa diversità?
Immagina di essere in una biblioteca silenziosa. Due persone dietro di te iniziano a sussurrare, digitano delicatamente sulla tastiera e qualcuno inizia a mangiare tranquillamente una mela, poi alzi lo sguardo e guardi qualcuno che gira delicatamente le pagine di un libro. Per molti, queste potrebbero essere distrazioni frustranti e irritanti in un ambiente apparentemente tranquillo mentre, per altri, questo tipo di immagini e suoni porterebbe all’innesco di una vera e propria una sensazione di formicolio, in genere esperita a livello del cuoio capelluto, del collo o delle spalle. Questa sensazione nasce in risposta a specifici stimoli (trigger) tattili, audio e visivi ed è stata denominata per la prima volta nel 2010 da Jennifer Allen come “Risposta Autonoma dei Meridiani Sensoriali” (ASMR; Poerio et al., 2018).
Soltanto recentemente questo fenomeno è stato portato all’attenzione del pubblico (del Campo e Kehle, 2016), infatti, attualmente sono moltissimi i video ASMR pubblicati e ricercati sul web allo scopo di sperimentare la sua conseguente sensazione di rilassamento e benessere (Copeland, 2017).
Per raggiungere tale rilassamento, in questa pratica vengono raccolti, tramite microfoni super-sensibili, rumori delicati e ripetitivi, infatti, tra i trigger comunemente utilizzati per ottenere ASMR ritroviamo spesso il sussurro, suoni nitidi e movimenti lenti come la spazzolatura dei capelli o il martellare le unghie su una specifica superficie (Barratt & Davis, 2015).
L’ASMR sembra un’esperienza comune a molti, ma tanti altri non riescono a sperimentarla; perché?
Un fattore determinante è probabilmente la personalità. Infatti, nello studio di Fredborg, Clark e Smith (2017), 290 individui con ASMR e 290 controlli corrispondenti hanno completato il Big Five Personality Inventory (BFI; John et al., 1991). Gli autori concordano con ricerche precedenti nelle quali emerge che le persone che sperimentano ASMR otterrebbero un punteggio superiore ai controlli nel dominio Openness-to-Experience del modello di personalità dei Big Five. Questa previsione si basava sul presupposto che i partecipanti all’ASMR avrebbero aumentate la sensibilità e la ricettività alle sensazioni. Inoltre, una maggiore sensibilità alle questioni estetiche, misurata da questo dominio, potrebbe essere generalizzata alle sensazioni corporee dell’ASMR, come le esperienze di formicolio.
Precedenti ricerche di Barratt e Davis (2015) hanno anche portato gli autori ad ipotizzare che gli individui con ASMR differiscano dai controlli sul dominio del nevroticismo del BFI. Gli autori, infatti, hanno trovato una grande percentuale di livelli di depressione da moderati a gravi nel loro campione. Dato che la depressione è associata al nevroticismo, si aspettavano che gli individui con ASMR producessero punteggi più alti su quest’ultimo rispetto ai controlli corrispondenti. Questa ipotesi è stata supportata, poiché gli individui con ASMR hanno ottenuto punteggi significativamente più alti rispetto ai controlli, indicando livelli più bassi di stabilità emotiva. Per quanto riguarda gli altri tre domini del Big Five, ovvero Estroversione, Coscienziosità e Piacevolezza, gli individui con ASMR hanno ottenuto punteggi significativamente inferiori rispetto ai controlli. Tuttavia, il motivo preciso di queste relazioni non è chiaro. Soltanto per quanto riguarda il dominio dell’Estroversione, gli autori hanno ipotizzato che le persone che guardano verso l’interno abbiano maggiori probabilità di manifestare sintomi di ASMR rispetto alle persone più socievoli e che guardano verso l’esterno.
Nello studio di Smith, Fredborg e Kornelsen (2019), è stato recentemente approfondito questo fenomeno: un totale di 17 soggetti con ASMR e 17 partecipanti al controllo sono stati sottoposti a scansione fMRI durante la visione di sei video di 4 minuti. Tre di questi video sono stati progettati per suscitare formicolio ASMR e tre no. I risultati di questo studio evidenziano la complessità del fenomeno: durante la visualizzazione di video che suscitano l’ASMR, le persone con ASMR hanno mostrato un aumento dell’attività neuronale nelle regioni della corteccia correlate all’attenzione, all’udito, alle emozioni e al movimento. Questa attività non è stata osservata nei partecipanti al controllo. Quando sono state confrontate le risposte dei soggetti con ASMR e dei partecipanti al controllo che guardano i video dell’ASMR, gli individui appartenenti al primo gruppo hanno mostrato una maggiore attività nel talamo, nella corteccia cingolata anteriore, nel precuneo e nelle regioni sensomotorie mediali. Nell’insieme, queste analisi dimostrano che l’ASMR non è semplicemente un fenomeno sensoriale o emotivo ma suggeriscono un coinvolgimento delle componenti sensoriali, motorie, affettive e attenzionali.
Un altro documento clinicamente rilevante riguarda uno studio pubblicato da Barratt e Davis (2015) condotto su 475 persone, con il quale viene dimostrata l’utilità dell’ASMR nel rilassarsi, affrontare lo stress (70%) e dormire con maggiore facilità (82%), mentre solo una piccola percentuale (5%) ha riferito di utilizzare i media-ASMR per la stimolazione sessuale. Gli autori dimostrano anche che questa tecnica provoca un effetto positivo sull’umore e una significativa riduzione dei sintomi del dolore cronico per diverse ore successive a una sessione di ASMR. In questo stesso studio sono state riportate, inoltre, le differenti aree dove viene sperimentata la sensazione di formicolio dai partecipanti: in genere, nella parte posteriore della testa e delle spalle, se però intensa, questa sensazione è in grado di estendersi lungo la linea della colonna vertebrale, delle braccia e delle gambe; sebbene ciò non si verifichi in ogni sessione e ogni individuo non sperimenti lo stesso percorso. Inoltre, in uno studio condotto da Smith, Fredborg e Kornelsen (2017), è stata riportata dai partecipanti un’intensità maggiore dei formicolii quando gli attori dei video erano rivolti direttamente allo spettatore anziché vedere la scena in terza persona.
L’ASMR può essere usata a scopo terapeutico?
Come già riportato sopra, l’ASMR viene utilizzato come meccanismo di coping per aiutare a gestire e ridurre i sintomi di alcune condizioni psicologiche e dolore cronico. Barratt e Davis (2015) hanno identificato livelli più bassi di depressione e dolore cronico durante e dopo aver sperimentato l’ASMR, i quali sono gradualmente tornati ai livelli di pre-intervento nell’arco di tre ore. È interessante notare che i partecipanti a cui è stata diagnosticata la depressione clinica hanno riportato la più grande diminuzione delle misure post-intervento della depressione, tuttavia questo effetto si è dissipato più rapidamente. Collettivamente, questi risultati suggeriscono che l’ASMR può essere utilizzato per fornire miglioramenti a breve termine dell’umore e del dolore cronico, sebbene venga riconosciuto che questi risultati si basano su indagini limitate. Per quando riguarda gli effetti a lungo termine, Ditchburn e Bedwell (2018), hanno cercato di stabilire se la stimolazione regolare di ASMR, per un periodo di una settimana, potesse conferire miglioramenti significativi dell’umore rispetto a un gruppo di controllo; i risultati suggeriscono, però, che l’ASMR è un intervento a lungo termine inefficace.
Nonostante la comunità scientifica abbia già compiuto numerosi studi volti ad indagare il fenomeno dell’ASMR, risulta ancora necessario un ulteriore approfondimento dello stesso, sia riguardo al suo funzionamento che al suo possibile utilizzo terapeutico. Risultano, invece, chiari ed evidenti i suoi effetti benefici su alcuni sintomi come il dolore cronico e l’umore, anche se solamente a breve termine. Potrebbe, quindi, essere interessante approfondire l’utilizzo di tale tecnica per la cura dei disturbi non ancora indagati. Rimane, in ogni caso, una buona modalità di rilassamento con effetti a breve termine, da utilizzare anche in autonomia.