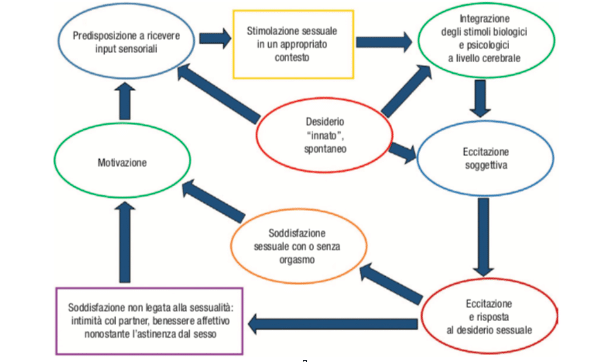Pensiero consapevole e automatico – Il Framing
Ogni clinico dovrebbe tenere in considerazione nel suo lavoro con i pazienti che tutti siamo soggetti a bias ed imparare ad operare con piani più adattivi e funzionali, trasformando l’errore in occasione di apprendimento.
Il presente contributo è il sesto e l’ultimo di una serie di articoli sull’argomento. Nell’ articolo continueremo ad approfondire le teorie di Daniel Kahneman per meglio comprendere le conseguenze dell’attivazione del pensiero lento e veloce in psicoterapia.
Il Framing
La cornice entro la quale si presentano le informazioni di un problema influenza notevolmente la scelta delle alternative di soluzione individuate. Gli esperimenti su questo tema sono copiosi.
Nel setting terapeutico con il paziente andiamo a verificare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi concordati durante la terapia. E’ bene non farlo spesso, perché il framing ampio riduce l’avversione al rischio. In pratica si è più disposti a percepire il piacere dei guadagni, ciò che si è ottenuto dalla terapia, piuttosto che il dolore per le perdite, ciò che ancora non si riesce ad ottenere in termini di risultato. E’ possibile, così che il paziente possa ritenersi soddisfatto del trattamento, senza consolidare le nuove acquisizioni e senza aver maturato la capacità di generalizzarle e soprattutto abbandonando il setting prematuramente prima di aver risolto tutte le problematiche presentate.
Il conflitto d’interessi tra omissione e commissione
Il senso di responsabilità è maggiore per il fare (colpa) che per il non fare (rammarico). La differenza è la deviazione dal default, non riduciamo le perdite per non ammettere il fallimento.
Il giocatore che perde continua a giocare, l’innamorato non si dà per vinto e continua a corteggiare la stessa donna che non ne vuole sapere, il broker naif continua a mantenere i suoi investimenti quando la borsa è segnata dall’orso. L’ossessivo non abbandona i suoi rituali compulsivi fin quando non si dice di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento terrifico.
Il rammarico di non aver fatto tutto ciò che era possibile è peggio del rimorso per aver compiuto un’azione dannosa. Tra l’altro i nostri conti mentali sono separati, per l’effetto che agiscono in contesti mentali diversi e separati, quindi le perdite e i guadagni, non sono compensati. Utilizziamo un framing ristretto che ci impedisce di avere una visione di più largo periodo che ci farebbe evitare molti costi sommersi (il famoso “fare trentuno perché abbiamo già fatto trenta”) dovuti agli investimenti in conti perdenti quando sarebbero disponibili investimenti migliori.
L’impegno in piani di vita disadattivi, per esempio, è spesso difficile da dismettere proprio perché il framing è ristretto e l’avversione alla perdita impedisce il cambiamento, anche se si pagano costi sommersi enormi in termini di sofferenza.
Una possibile motivazione a prendere decisioni diverse può essere fornita se la valutazione è congiunta, ossia se anziché valutare un unico scenario (un unico piano) si è nella condizione di valutare più scenari alternativi. Così è più facile che si arrivi a un’inversione di preferenza (Kahneman, 2013) in contesti mutati.
In realtà, per lo stesso motivo, anche i terapeuti spesso sono restii a riorganizzare strategie terapeutiche risultate fallimentari quando si è alla presenza d’impasse e rotture dell’alleanza.
Frame e realtà
Il framing emozionale è stato valutato da neuroscienziati in molti esperimenti e consiste nell’attivazione dell’amigdala che provoca eccitazione emozionale durante una scelta del sistema 1. Resistere comporta un conflitto con l’attivazione del cingolo anteriore. Le scelte più razionali, condotte da soggetti meno esposti al framing, attivano la corteccia frontale che combina emozione e ragione.
Il framing emozionale influenza le scelte secondo la formulazione e descrizione della situazione, del funzionamento diverso del sé esperienziale e del sé memonico e in virtù del fatto che le decisioni non sono sempre associate all’esperienza, ma spesso forgiate dai ricordi (Kahneman, 2013).
Ciò mette in discussione il modello dell’agente razionale. Abbiamo preferenze sulla durata delle conseguenze dolorose e piacevoli favorite dalla memoria, una funzione del sistema 1 che si è evoluta in funzione della regola picco-fine. La valutazione di un’esperienza retrospettivamente è riferita al momento peggiore e al termine dell’esperienza stessa, mentre vi è disattenzione per la durata.
Quando pensiamo a un fallimento, la finale dei campionati europei persa, trascuriamo tutto ciò che di positivo vi è stato durante il torneo. Un percorso terapeutico può fornire al paziente un’esperienza positiva se la narrazione è ricordata dal sé memonico che ha più influenza del sé esperienziale senza che vi sia un evento, per esempio, in fase di chiusura, momento che proprio per questo va curato in modo particolare con molta attenzione, che metta a repentaglio l’integrità dell’intero percorso. L’illusione della focalizzazione induce in errore sullo stato attuale, il paziente può fermare l’attenzione sul momento senza consolidare il tempo e quindi la durata del trattamento.
Il sé esperienziale mette insieme una serie di momenti che possono essere più o meno felici e più o meno dolorosi, ma la somma dei valori dei vari momenti può essere offuscata dal sé memonico che ferma e rappresenta alcuni momenti critici, il culmine e la fine, mentre la durata è trascurata.
La ricostruzione della narrazione nella sequenza temporale e la regolazione di alcune funzioni esecutive (memoria, attenzione, pensiero) possono ridare coerenza e integrazione tra sé memonico e sé esperienziale, riducendo bias che generano sofferenza per una ricostruzione parziale e distorta degli eventi.
La distanza psicologica
Gli eventi possono essere valutati in modo diverso per la distanza psicologica da cui si valutano. La distanza è temporale e spaziale quindi un evento può essere prossimo o distante in termini temporali o spaziali. Queste distanze secondo la construal level theory influenzano il livello di costruzione della realtà (Mancini, Giacomantonio, 2018).
L’assetto motivazionale in terapia può essere così influenzato rispetto al raggiungimento degli scopi concordati o dei compiti assegnati.
Review della letteratura recente sul tema
La literature review ha utilizzato l’archivio elettronico “EBSCOhost” inserendo le parole chiave “prospect theory; decision making; thought & thinking; framing effect; anchoring effect; anchoring and adjustment heuristic; affect heuristic” e selezionato le pubblicazioni accademiche dell’ultimo decennio relative al processo decisionale in ambito clinico.
Sull’argomento del decision making la letteratura è vasta e ne prenderemo in considerazione solo una parte inerente l’interesse specifico del tema: lavorare in psicoterapia comporta scelte sia per il paziente, sia per il terapeuta soggette a possibili bias che quanto meno, possono ostacolare il raggiungimento degli scopi.
Il processo di decision making è il risultato di processi cognitivi ed emozionali che determinano scelte tra diverse alternative. Pravettoni et al. (2015) distinguono due approcci, uno normativo, l’altro descrittivo. Il primo sostiene che in condizioni d’incertezza e rischio si rappresentano diverse opzioni in termini di utilità attesa e la scelta è fatta in modo razionale rispetto alla probabilità di conseguire il risultato atteso, per il secondo la capacità di prendere decisioni non segue sempre le leggi della razionalità ma è influenzata sia da processi cognitivi sia da aspetti emotivi e sociali.
Il meccanismo del Deferred Acceptance Algorithm (Cormen et al., 2013) può rappresentare un ottimo esempio del primo approccio, consente di rimandare, infatti, le scelte definitive fino a quando si è trovata la soluzione ideale. Quando si giunge alla soluzione ideale tutte le opzioni sono state considerate e non ce n’è una migliore.
La distanza temporale, però, è uno dei criteri con cui costruiamo le scelte (temporal discounting) e spesso l’interesse a breve termine (l’uovo oggi) si contrappone all’interesse a lungo termine (la gallina domani) e la preferenza è inversamente proporzionale al ritardo della ricompensa (Ruokang, Takahashi, 2012; Livet, 2017). Inoltre il Deferred Acceptance Algorithm, non tiene conto delle rappresentazioni e delle emozioni dell’agente il cui ruolo è stato molto bene segnalato dalla teoria del marcatore somatico di Damasio (Lerner et al., 2015).
L’approccio descrittivo, invece, si propone di determinare i pattern cognitivi sottostanti i reali comportamenti decisionali, facendo ricorso alle euristiche (Gigerenzen, 2011; 2015), scorciatoie che consentono di arrivare rapidamente, senza una ricerca esaustiva di tutte le informazioni, a una scelta che consente il raggiungimento degli scopi.
Una grande quantità di studi presenti in letteratura si soffermano sul processo decisionale in termini di guadagni o perdite evidenziando che le persone reagiscono in modo diverso a una particolare scelta a seconda che sia presentata come una perdita o come un guadagno. Mettere in rilievo l’uno o l’altro dei due aspetti complementari influenza la valutazione e le decisioni che ne conseguono.
Gong et al. (2013) hanno condotto una review della letteratura pubblicata in lingua inglese dal 2005 al 2012, utilizzando ricerche elettroniche e bibliografiche attraverso l’utilizzo di Medline, Science Direct e Pro Quest Digital Dissertation.
Le conclusioni mettono in evidenza risultati a volte incoerenti per la presenza di un’eterogeneità di variabili che possono entrare in gioco quando le persone devono effettuare scelte nel campo della salute. Ulteriori conferme in questo senso sono state fornite da altre ricerche (Evangeli et al., 2013; Van’t Riet et al., 2014; Lucas et al., 2016).
Alcuni lavori presi in considerazione attestano, ad esempio, sia che le persone sono più facilmente persuase dell’importanza di mettere in atto comportamenti di prevenzione quando i messaggi hanno un contenuto positivo rispetto ad uno negativo, sia l’opposto.
Kingsbury et al. (2015) hanno esaminato gli effetti del framing sui comportamenti che hanno sia implicazioni sulla salute che nelle relazioni interpersonali. Lo studio ha rilevato che i messaggi inquadrati come guadagno sono più efficaci per promuovere comportamenti positivi in ambito di salute, mentre per quanto riguarda le conseguenze sociali, per sortire maggiori effetti sul comportamento è preferibile inquadrare i messaggi come perdite.
Il framing dei messaggi è importante per incoraggiare il cambiamento del comportamento e deve tenere presente i benefici enfatizzati e le priorità personali dei pazienti (Keyworth et al., 2018) nonché l’ottimismo disposizionale (Zhao et al., 2015).
I messaggi con contenuti negativi, in relazione a quanto afferma la Prospect Theory, necessitano di un’elaborazione più lunga e portano i soggetti a mettere in atto comportamenti difensivi e protettivi (Brown et al. , 2014).
In sostanza numerose variabili entrano in gioco nella decisione di mettere in atto o meno un determinato comportamento, le caratteristiche individuali dei singoli soggetti, la propensione personale ad assumere rischi, l’esperienza, il contesto organizzativo, le preferenze del paziente, la condivisione del processo decisionale (Broc et al., 2017).
Anche l’età ha il suo peso. Malhotra et al. (2017) e Pachur et al. (2017) hanno osservato il ruolo dei fattori cognitivi e motivazionali nei processi decisionali di rischio confrontando i giovani con gli anziani: gli anziani sono più ottimisti rispetto ai guadagni e non hanno mostrato alcuna avversione alla perdita.
Gli studi di Lombardi et al. (2010) e di Kreiner et al. (2017) si sono soffermati sull’impatto che una domanda può avere sulla risposta, rilevando che le risposte sono suscettibili di ancoraggio quando viene data al soggetto la possibilità di utilizzare un formato di risposta in scala o utilizzando dei grafici.
Verhofstadt et al. (2016) hanno esaminato come le risposte dei soggetti cambiano a seconda del tipo di ancoraggio che contiene la domanda; se l’ancora è fornita dall’interlocutore e quindi è esplicita oppure viene autogenerata dal soggetto.
Aspetti questi da tenere in debita considerazione durante un colloquio clinico poiché il modo in cui viene posta la domanda dal terapeuta influenza il paziente circa la dimensione che valuta e la risposta che fornisce.
Domande aperte su concetti e costrutti multidimensionali, ad esempio, volte a comprendere il vissuto di un soggetto circa la propria qualità di vita, il proprio benessere o quanto si sente felice senza fornire dei parametri di riferimento, portano il soggetto intervistato ad individuare una propria ancora (il soggetto può confrontarsi con altri soggetti, confrontare la propria vita attuale con quella desiderata, essere sensibile al contesto in cui viene posta la domanda, ecc.) che avrà un impatto sulla stima effettuata ed influenzerà la risposta.
Una ricerca di Lisa et al. (2017) ha esplorato come, oltre al modo in cui viene presentato un problema, anche il tempo diventi un fattore determinante nel processo decisionale. Quando le persone devono affrontare decisioni improvvise ed immediate, la pressione del tempo aumenta gli effetti del framing attivando il pensiero di tipo1, più intuitivo ed emotivo, facilitando risposte automatiche.
Le ricerche sugli effetti del framing nel processo decisionale in ambito psicopatologico non sono moltissime, ma è ragionevole presumere, come rilevato da Jefferies-Sewell et al. (2015) che anche gli esperti del settore non siano immuni da tale effetto. Uno studio di questi autori che ha coinvolto 678 psichiatri attesta che la presentazione delle informazioni sui rischi può influenzare il processo decisionale. Rispetto alla teoria classica in cui le situazioni inquadrate positivamente portano avversione al rischio e le situazioni incorniciate negativamente comportano una maggiore possibilità di scelte rischiose, in questo studio sembra emergere un modello inverso. I partecipanti a cui era detto che i rischi fossero “alti”, si sono mostrati più inclini a scegliere comportamenti di cautela, mentre quelli a cui era detto che il rischio fosse “basso” si mostravano meno propensi a tenere in debita considerazione la sicurezza del paziente. Jefferies-Sewell et al. concludono che gli effetti del framing possono essere spiegati in termini di mancanza di comprensione della probabilità che un certo evento si verifichi e sottolineano l’importanza di un’adeguata formazione soprattutto per professionisti meno esperti.
Parker (2014; 2018) si è soffermato sulle caratteristiche specifiche che entrano in gioco quando si fa una diagnosi, spiegando l’importanza del “ragionamento clinico”. Riprendendo l’esempio riportato da Kahneman relativo all’abilità acquisita da un giocatore di scacchi che a seguito di un ampio addestramento è in grado di prendere decisioni non in base a scelte intuitive, Parker sostiene che in ambito diagnostico è necessario formulare una “diagnosi provvisoria” in maniera “automatica” e successivamente attivare il Sistema 2 per verificare i dati di cui si dispone in modo da confermare o respingere la prima ipotesi diagnostica. In psichiatria i sintomi non hanno un peso assoluto e specifico per questo l’autore sostiene l’importanza di utilizzare in modo integrato il sistema 1 e il Sistema 2 per definire ipotesi soggette a invalidazioni e/o conferme. Gli errori in cui può incorrere il Sistema 1 sarebbero cosi compensati dal Sistema 2.
Parker, inoltre, evidenzia l’importanza e la centralità dell’esperienza, dato che l’analisi dei sintomi non è spesso sufficiente vista la peculiarità dell’indagine clinica che deve tenere in considerazione diverse dimensioni e per questo soggetta a fallacie e bias.
In ambito psicopatologico la diagnosi non trova conferme in prove di laboratorio è, quindi, necessario il ragionamento clinico, oltretutto quasi tutte le diagnosi psichiatriche mancano di una precisa definizione di confini, le categorie diagnostiche si modificano nel tempo e gli stessi sintomi sono presenti in differenti patologie.
Inoltre, un clinico non si limita solamente a fare diagnosi ma si chiede il perché un paziente ha presentato proprio in un momento specifico una determinata condizione e cerca nella sua storia evolutiva una serie di informazioni utili alla definizione del progetto terapeutico (Parker, 2018).
Relativamente agli errori euristici che possono commettere gli esperti, soggetti con adeguata formazione accademica e conoscenze specifiche relative al processo decisionale, Ribiero et al. 2014 e Bennett et al., 2014 in linea con la Prospect Theory, mettono in rilievo la possibilità che anche questi professionisti possano essere soggetti all’effetto ancoraggio che si può verificare anche quando l’ancora è incompleta, inaccurata, irrilevante, non plausibile o persino casuale.
Sebbene tale effetto sia stato ampiamente riconosciuto come un’euristica estremamente robusta e potente, uno studio di Zhao (2012) ha rimarcato che motivare all’accuratezza del giudizio e fornire informazioni sui processi metacognitivi può contrastarlo. Risultati simili sono stati ottenuti da Smith et al. (2013) che, contrariamente a quando riferito da Kanheman, sottolineano come una maggiore conoscenza porta ad un minor effetto ancoraggio e che, in relazione all’influenza delle ancore sulle valutazioni, gli effetti sono ancora più moderati se quelle fornite hanno dei valori estremi.
Anche le ricerche di Chiesi et al. (2011) e De Neys (2014) hanno attestato che le capacità metacognitive sono positivamente correlate alla tendenza a inibire risposte euristiche e alla capacità di prendere in considerazione diverse alternative, riducendo la tendenza a fare affidamento su scelte rapide e predefinite.
Le ricerche di Wendt et al.(2018) e di Zamarian et al. (2019) mostrano, altresì che l’esperienza migliora la capacità diagnostica e quindi diminuisce gli effetti di ancoraggio e di framing.
Da un punto di vista più strettamente neuropsicologico gli studi di McElroy et al. (2013) e di Corser et al. (2014) hanno esaminato il ruolo di entrambi gli emisferi nell’ambito del decision making favorendo la comprensione del contributo di ciascun emisfero nel processo decisionale, mentre altre ricerche hanno evidenziato il ruolo dell’ambiente in relazione ai diversi livelli di analisi per la riformulazione di credenze implicate nei processi di cambiamento decisionale (Kotabe et al. 2016; Kempermann, 2019; Berman et al. 2019).
Di estremo interesse è una ricerca di Johnson et al.(2013) che prende in considerazione il ruolo della Prospect Theory rispetto al tema della socialità. L’essere umano da un punto di vista evolutivo è portato alla socializzazione e, pertanto, il concetto di avversione alla perdita non si può ritenere valido per questo dominio. L’importanza di entrare in relazione è così importante per l’uomo (sopravvivenza e successo riproduttivo) che più facilmente assume i rischi del coinvolgimento sociale con gli altri rispetto a rischi in ambiti non sociali, indipendentemente dal fatto che la scelta sia inquadrata come guadagno o perdita.
Considerazioni conclusive
Nel complesso gli studi sul decision making hanno evidenziato che i soggetti sono sensibili e influenzati dal modo, dal tipo e dal contesto in cui le informazioni cliniche sono comunicate. Dall’analisi della letteratura emerge che diversi fattori possono influenzare le scelte dei soggetti e i risultati che in alcuni casi sono anche discordanti. I dati a disposizione dovranno essere adeguatamente approfonditi da ricerche future.
Sembra, comunque, emergere il ruolo delle capacità metacognitive, del ragionamento clinico e dell’esperienza nel ridurre significativamente i bias in ambito psicopatologico e queste indicazioni rappresentano informazioni che ogni clinico dovrebbe tenere in debita considerazione nel suo lavoro con i pazienti.
Il sistema 1, il pensiero intuitivo, commette errori quando guida il comportamento, ma è anche all’origine di molte scelte corrette. La memoria conserva le abilità acquisite per fronteggiare le situazioni problematiche che si presentano. Ambiente regolare, pratica e feed-back sull’efficacia di pensieri e azioni ci permettono di acquisire un repertorio di competenze, giudizi e scelte intuitive che si rivelano adattivi.
A volte la realtà ci richiede una risposta euristica più complessa, meno rapida, più analitica. Ecco che entra in gioco il sistema 2 che ci avverte che siamo in un territorio pieno di trappole, dilemmi, intoppi e dobbiamo muoverci con cautela per non incorrere in illusioni cognitive.
Avere ben chiaro che siamo soggetti ai bias descritti può aiutarci a operare con piani più adattivi e funzionali e a trasformare l’errore in occasione di apprendimento. E ciò è utile al paziente e al terapeuta.
Altri articoli sull’argomento: