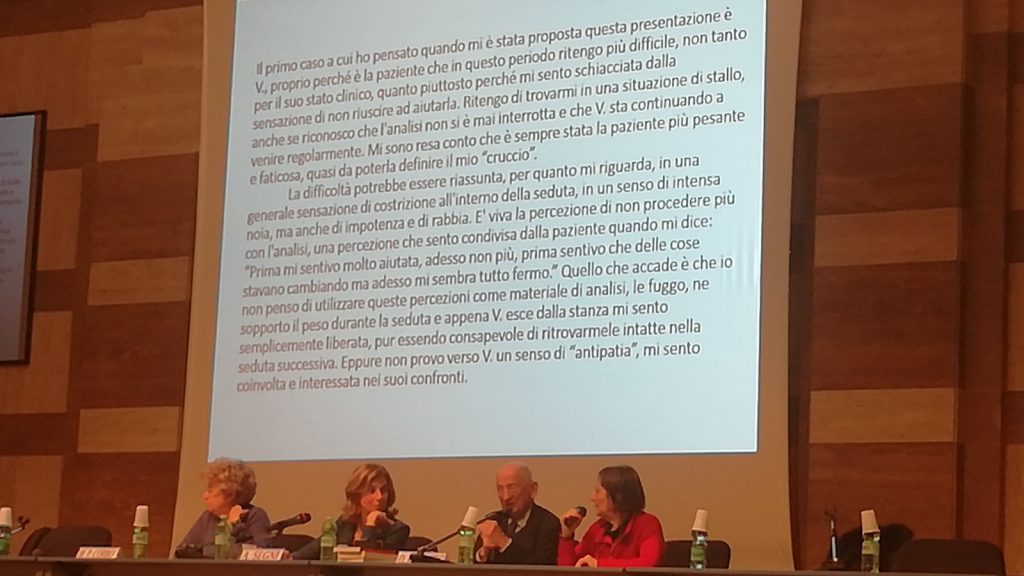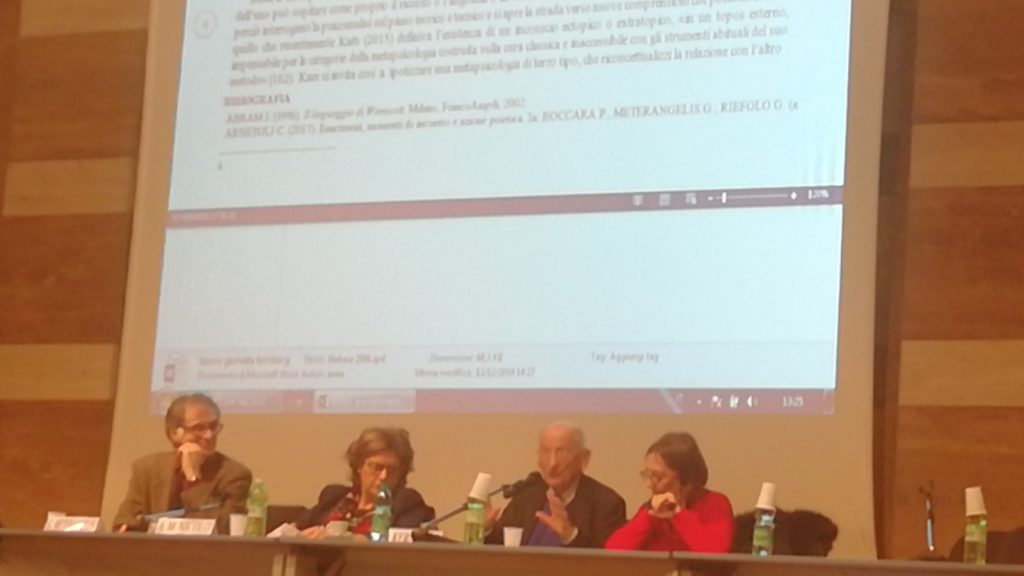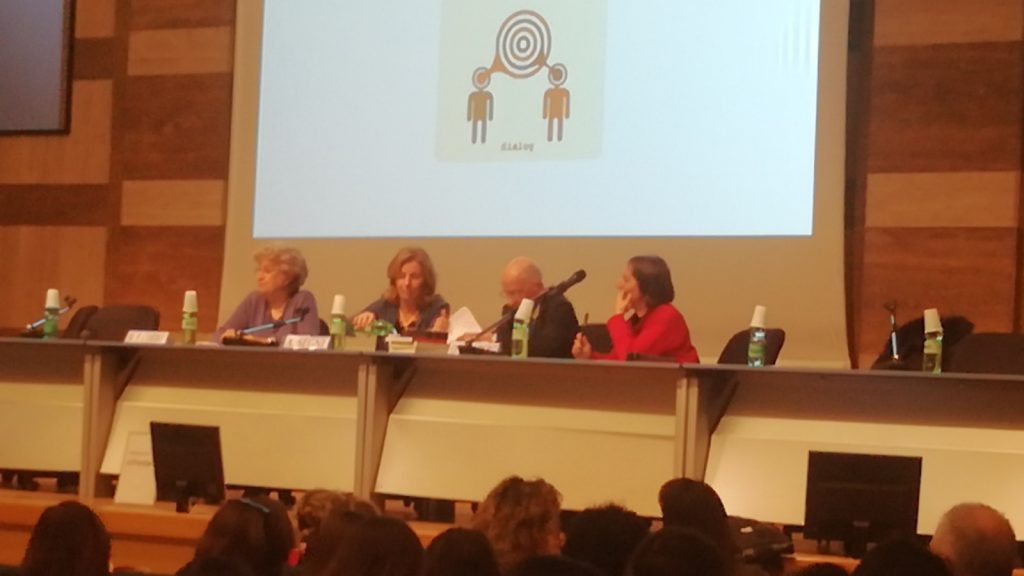Scuola: integrare l’integrazione. Prospettive a confronto
L’inclusione di alunni con disabilità è da sempre un tema centrale per la pedagogia della scuola italiana. È una pratica attiva che dà luogo a un processo di crescita per gli alunni con disabilità, ma anche per i loro compagni.
Maddalena Mauri e Silvia Busti Ceccarelli – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi e Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Milano
Infatti, secondo la pedagogia italiana, crescere è un processo individuale che ha però le proprie fondamenta nel rapporto e nella relazione con gli altri; per questo la scuola si propone di essere una comunità educante, che accoglie ogni alunno con l’obiettivo di fornire le condizioni ideali a consentirne il massimo sviluppo (Ministero della Salute, dell’Università e della Ricerca, 2009).
Linee Guida per l’Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità
Da un punto di vista giuridico, la tutela di tale diritto è garantita dalla norma costituzionale del diritto allo studio, la quale, interpretata alla luce della legge 59/1997 e del DPR 275/1999, prevede che le scuole, con autonomia e flessibilità, garantiscano le condizioni migliori perché avvenga lo sviluppo e la crescita formativa di ciascun alunno (Ministero della Salute, dell’Università e della Ricerca, 2009).
L’Italia presenta una delle legislazioni più avanzate in materia di garanzia di diritto allo studio degli alunni con disabilità (Caturano 2016).
La costituzione italiana sancisce che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano uguali dinnanzi alla legge, e che sia dovere della Repubblica rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno sviluppo dei cittadini.
All’interno delle scuole speciali e delle classi differenziali, è stato fin da subito evidente il problema dell’emarginazione sociale degli alunni con disabilità. Grazie alle leggi 118/71 e alla successiva 517/77 venne predisposto che l’obbligo scolastico dovesse avvenire in classi normali, stabilendo con chiarezza presupposti, strumenti e finalità che l’intero consiglio di classe deve attuare al fine di garantire l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità e infine inserendo la possibilità dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno. La legge 104/92 prevede per l’alunno con disabilità un percorso formativo individualizzato, che a livello fattuale si applichi tramite il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Data l’importanza di tali documenti, è necessario che nella loro stesura vengano coinvolte amministrazione scolastica, organi pubblici di cura della persona e famiglie. Inoltre è necessario che vengano sottoposti a verifiche e modifiche in itinere (Ministero della Salute, dell’Università e della Ricerca, 2009).
Nel 2001, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) raccomandandone l’uso agli stati membri. L’ICF, incarnando perfettamente la visione sociale e non soltanto sanitaria della disabilità, prevede un’attenzione alle potenzialità complessive e alle diverse risorse della persona oltre che al contesto, personale, naturale, sociale e culturale in cui esse possono esprimersi. Il modello introdotto dall’ICF è quello bio-psico-sociale, che correla le condizioni di salute della persona alle risorse e agli ostacoli ambientali presenti. La Diagnosi Funzionale elaborata dagli enti di cura è oggi redatta in base al modello ICF (Ministero della Salute, dell’Università e della Ricerca, 2009). Nel prossimo futuro il Profilo Dinamico Funzionale andrà a formare, insieme alla Diagnosi Funzionale, il Profilo di Funzionamento, nuovo documento che sarà redatto secondo ICF.
Con la legge 59/1997 è stata attribuita alle istituzioni scolastiche autonomia nella realizzazione dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, il cui obiettivo primario deve essere lo sviluppo delle competenze dell’alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione e socializzazione. Tali scopi possono essere raggiunti tramite una pianificazione attenta e precisa degli interventi educativi, formativi e riabilitativi così come previsto dal PEI. È il Dirigente scolastico ad essere il garante dell’offerta formativa che viene progettata ed attuata dall’istituzione scolastica per tutti gli studenti, dunque, anche quelli con disabilità. Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) deve prevedere la possibilità di dare risposte precise ad esigenze educative individuali; in quest’ottica, la presenza di alunni disabili non è un incidente di percorso, un’emergenza, ma un evento che richiede una riorganizzazione del sistema già individuata in via previsionale e che rappresenta un’occasione di crescita per tutti (Ministero della Salute, dell’Università e della Ricerca, 2009).
La definizione di integrazione o inclusione degli alunni con disabilità prevede che essi facciano esperienze e apprendano insieme agli altri, condividendo obiettivi e strategie, e non soltanto stando accanto agli altri. Per non disattendere questo obiettivo è necessario che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari insieme all’insegnante di sostegno. L’intero corpo docente è chiamato a organizzare i curricula in funzione delle diverse attitudini cognitive, a gestire la classe e i materiali e a utilizzare strategie scolastiche in relazione ai bisogni di tutti gli alunni. Le strategie favorevoli da adottare comprendono: l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di ausili informatici. È importante che gli insegnati predispongano il materiale in formato multimediale per favorire gli alunni che utilizzano supporti informatici (Ministero della Salute, dell’Università e della Ricerca, 2009). Nelle ore in cui non è presente l’insegnante per le attività di sostegno esiste il rischio che per l’alunno con disabilità non ci sia una adeguata tutela del suo diritto allo studio. È quindi compito di tale insegnante coordinare la rete delle attività anche in sua assenza, in modo che l’integrazione venga pienamente raggiunta (Ministero della Salute, dell’Università e della Ricerca, 2009). La documentazione relativa alla programmazione deve essere disponibile alla famiglia, la quale prende visione e può approvare il piano formativo. La famiglia ha diritto a partecipare alla stesura del PDF e del PEI, e alle loro successive verifiche. I rapporti tra famiglia e istituzione scolastica devono avvenire nella logica di supporto alle famiglie, le quali devono essere costantemente informate e coinvolte (Ministero della Salute, dell’Università e della Ricerca, 2009). È importantissimo, soprattutto nel passaggio tra un grado e l’altro di istruzione, il fascicolo individuale dell’alunno con disabilità, il quale deve essere previsto a partire dall’inizio del percorso formativo del bambino. La documentazione dovrà essere completa e sufficientemente articolata per consentire alla nuova scuola di progettare al meglio i propri interventi. Nelle fasi di passaggio è consentito che l’insegnante del ciclo già frequentato partecipi alle fasi di accoglienza e di inserimento nel grado successivo. Il PEI dell’alunno con disabilità prevede un progetto che innalzi la qualità di vita del bambino o ragazzo che va al di là del percorso scolastico, con percorsi che ne sviluppino sia il senso di autoefficacia e autostima, sia le competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comune (Ministero della Salute, dell’Università e della Ricerca, 2009).
Grazie alla sopracitata legislatura e alle garanzie che da essa ne derivano, in meno di 20 anni (dal 1995 al 2013) gli alunni con disabilità integrati all’interno della scuola sono passati da 108.000 a 220.000, mentre gli insegnanti per le attività di sostegno da 35.000 a 102.000 (Caturano, 2016).
Evidence Based Education
La letteratura internazionale riporta, come risultato di studi di meta-analisi, che l’efficacia delle azioni nel campo dell’inclusione deve tener conto non solo delle strategie prescelte ma anche di altre variabili di grande importanza: l’organizzazione, le relazioni, la metodologia di lavoro, la disponibilità e la formazione dei docenti, le alleanze che si stabiliscono tra tutti i soggetti implicati.
L’Education Endowment Foundation (EEF), nel Regno Unito, si è occupata di sviluppare una guida per gli insegnanti e le scuole per l’adozione di approcci e strategie didattiche basate su evidenze scientifiche. Sono stati presi in esame 33 differenti strategie, tra le quali l’apprendimento cooperativo, l’utilizzo di tecnologie digitali, il feedback, il tutoring tra pari, l’apprendimento per scoperta, la metacognizione e l’autocontrollo, offrendo anche per ciascuno utili elementi di fattibilità (durata, costi, effetti stimati).
In Italia, nonostante la lunga storia di integrazione ed inclusione scolastica degli alunni con disabilità, costruita dal basso, dalle scuole, la quale pone il nostro paese in una posizione di avanguardia rispetto a molti altri paesi europei, manca una tradizione di ricerca empirica di efficacia degli interventi, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2011 nemmeno cita il modello italiano nel suo report. Questo aspetto può portare ad evidenziare alcune criticità: in Italia è prevalente un modello biomedico di assistenzialità, che si evidenzia con un crescente numero di certificazioni di disabilità; in molti casi il disagio viene patologizzato, con un conseguente dispendio di risorse ed energie, ma senza un efficace riconoscimento dei reali bisogni dell’alunno (Caturano, 2016).
Dalla Teoria alla Pratica
Come ci ricordano Ianes e Canevaro (2015) realizzare un buon intervento di integrazione scolastica è solo il primo passo verso quella che possiamo definire una scuola inclusiva, cioè una scuola che riconosce e valorizza pienamente tutte le differenze superando la dicotomia ‘alunni con BES’ vs ‘tutti gli altri’. In una scuola inclusiva il punto di arrivo, come ricorda don Milani, la giustizia, è l’equità, il fare parti uguali tra disuguali distribuendo le risorse secondo i bisogni di ciascuno. In quest’ottica, è importante che la figura dell’insegnante di sostegno si trasformi radicalmente ed entri a tutti gli effetti a fare parte di un corpo docenti che lavora in compresenza, senza essere colui a cui è delegata la gestione del singolo alunno con maggiori difficoltà. Così l’intero corpo docenti diventerebbe vero protagonista dell’integrazione, senza più affidarla solo a qualcuno (Ianes, 2015).
Nel volume Buone prassi di integrazione scolastica (Ianes e Canevaro, 2015), gli autori hanno reso disponibili 20 esempi di progetti realizzati presso scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado. Si tratta di una testimonianza preziosa in quanto spesso l’integrazione che viene fatta da anni con impegno nelle scuole italiane non lascia traccia: così l’intelligenza collettiva si perde e i professionisti si trovano isolati nella reiterazione di pratiche sempre uguali poco a rischio di contaminazione. Gli autori evidenziano alcuni elementi in comune a tutti i progetti che mantengono però una propria identità e originalità suggerendo l’importanza dell’utilizzo della creatività nel lavoro con la disabilità. Ecco di seguito quelle che vengono definite le costanti significative delle buone prassi raccontate e alcuni esempi tratti dai singoli progetti riportati nel testo.
1. Una forte collaborazione tra gli insegnanti. All’interno di un progetto volto a promuovere le abilità metacognitive in tre classi quarte della scuola primaria il presupposto da cui partono gli insegnanti per descrivere il lavoro svolto è che per praticare integrazione sia necessario coinvolgere l’intero corpo docenti e non solo l’insegnante di sostegno. Nello specifico, all’interno delle classi coinvolte vi è un alunno con difficoltà prevalentemente nell’aera socioaffettiva che il corpo docenti ha seguito con particolare attenzione nel corso del percorso proposto, adottando nei suoi confronti comportamenti simili in modo da creare una coerenza nella gestione educativa del bambino evitando così di proporre modelli di comportamenti differenti e pertanto confusivi.
2. Un’idea forte, unificante, che caratterizza la prassi: il razionale alla base del progetto è solido. Il secondo progetto descritto nel volume ha avuto come obiettivo quello di lavorare sui prerequisiti grafici per la scrittura in un gruppo di 10 bambini dell’ultimo anno della scuola d’infanzia e si è basato sulla didattica del gesto grafico che sottolinea l’importanza di lasciare spazio alla spontaneità del bambino. Sono state quindi proposte attività di gioco con le braccia, le mani e le dita, con i pregrafismi in verticale, giochi grafo-motori e di stimolazione dei prerequisiti motori. Il progetto è stato valutato con dei test standardizzati pre-post dimostrando l’efficacia dell’intervento.
3. Un’apertura all’esterno e un utilizzo delle risorse del territorio. Le prassi per una buona integrazione non si esauriscono nel PEI, ma confluiscono in un progetto di vita più ampio incoraggiando gli alunni a uscire dalla scuola e a esplorare l’ambiente circostante. È il caso ad esempio della prima e seconda classe di secondaria coinvolte in un progetto di educazione ambientale che ha previsto lo studio di diverse tipologie di insetti e altri materiali biologici trovati all’esterno spontaneamente dai ragazzi (coleotteri, cavallette, cimici, resti alimentari, crani d’uccello, etc..). Da questi materiali sono state ottenute delle realizzazioni permanenti esposte in mostre locali che hanno visto la partecipazione attiva degli alunni, i quali hanno contribuito nella preparazione degli allestimenti e nell’accompagnamento del pubblico con le spiegazioni di quanto raccolto. Gli alunni diversamente abili della scuola e delle classi coinvolte sono stati attivi e propositivi all’interno del progetto, anche nei confronti dei compagni.
4. Gli alunni sono i soggetti attivi della costruzione della loro conoscenza. Gli alunni vengono guidati verso l’acquisizione di nuove competenze che possano renderli soggetti attivi, autonomi e consapevoli. In questa direzione si muove ad esempio l’utilizzo di una didattica che prevede un approccio metacognitivo allo studio, soprattutto a partire dalla ricerca di materiali interattivi e multimediali per alunni con DSA e BES. Per quanto riguarda la scelta degli esercizi, vengono proposti ai ragazzi direttamente su computer o LIM dei file interattivi che permettono di operare un controllo sul proprio apprendimento con feedback immediato. Nel processo di studio, l’alunno viene lasciato libero di scegliere quali parti del testo nascondere e ripetere a voce alta, rendendolo principale responsabile del proprio processo di apprendimento con una modalità ingaggiante e al contempo supportiva.
5. Si rompono le barriere tra ordini di scuola e tra classi: alunni di diverse classi e scuole si trovano a lavorare insieme. Tra i molti progetti che hanno visto la cooperazione tra alunni e insegnanti di diverse classi e scuole citiamo un lavoro di integrazione realizzato in un Istituto Professionale per operatori e tecnici dell’abbigliamento, che è associato a un Istituto d’arte con il quale condivide diverse collaborazioni. Inoltre, l’Istituto Professionale collabora con una scuola dell’infanzia ubicata ai piani inferiori. Il progetto ha quindi coinvolto tutte le studentesse con disabilità presenti nell’Istituto Professionale, le classi prima, seconda e quarta dell’Istituto e quattro sezioni della scuola dell’infanzia e si è posto come obiettivo quello di fornire agli alunni occasioni di incontro in cui stabilire nuove relazioni, oltre alla creazione di opere d’arte e alla loro esposizione.
6. Le relazioni inclusive e solidali tra compagni di scuola con le loro varie diversità sono la trama indispensabile per tessere l’integrazione: la prima risorsa per l’integrazione sono i compagni. In un progetto a carattere biennale con bambini della scuola dell’infanzia e primaria sono stati attuati percorsi formativi volti a incrementare le abilità prosociali al fine di migliorare il livello di interazione e di empatia verso i compagni con disabilità. Tale formazione, all’interno della scuola dell’infanzia, ha previsto a) la creazione di situazioni ludico-ricreative in aula inserendo materiali che stimolassero l’esplorazione sensoriale in modo da essere più motivante e fruibile anche per gli alunni con disabilità, b) l’avvio di un programma di simulazione dei deficit visivi e motori di cui sono portatori alcuni compagni e c) il modellamento, da parte delle insegnanti, dei comportamenti adeguati verso i compagni disabili messi in atto dai bambini spontaneamente attraverso il rinforzo positivo. Con i bambini della scuola primaria il programma formativo si è basato principalmente su a) un programma operativo di educazione prosociale e b) sul modellamento di atteggiamenti adeguati nei confronti del bambino con pluridisabilità.
7. L’apprendimento cooperativo in piccoli gruppi eterogenei. Troviamo un chiaro esempio di tale prassi nella metodologia utilizzata nel progetto sopra citato volto a promuovere le abilità metacognitive nelle quarte della scuola primaria, in cui le tre classi coinvolte sono state divise in quattro sottogruppi eterogenei di 12/13 bambini. In questo modo è stato possibile agevolare il controllo degli apprendimenti e delle abilità acquisite da ciascuno e prestare più attenzione all’integrazione degli alunni con maggiori difficoltà.
8. La crescita psicologica di tutti gli alunni. Il progetto educativo sullo sviluppo delle intelligenze multiple attuato in una scuola dell’infanzia si è posto come finalità quella di valorizzare le abilità di ogni bambino, fornendo loro occasioni per sperimentarsi in differenti attività dando spazio alle diverse forme di intelligenza (intrapersonale, interpersonale, esistenziale, linguistica, matematica, naturalistica, visivo-spaziale, musicale, cinestetica, digitale, civica e di cittadinanza), adottando una modalità ludico-narrativa. L’innovatività di un progetto simile risiede nel fatto di dare agli alunni la possibilità di operare utilizzando molti linguaggi differenti senza dover padroneggiare per forza il classico canale linguistico e logico-matematico.
9. Il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato si raccordano con la programmazione di classe. Se gli strumenti della programmazione individualizzata non si integrano con quella della classe, si creano le condizioni per ulteriori frammentazioni. È pertanto importante conciliare i progetti mirati ai singoli alunni con gli obiettivi più estesi al gruppo classe, come emerge chiaramente da un progetto per lo sviluppo della comunicazione attuato nella classe terza di una scuola primaria, in cui sono stati portati avanti tre interventi in parallelo: 1. un percorso di danzaterapia per rispondere ai bisogni affettivo-relazionali dell’intero gruppo classe; 2. un progetto di corrispondenza epistolare tra un alunno con disabilità e un alunno di un’altra scuola, successivamente esteso a tutta la classe; 3. un progetto specifico di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per un altro alunno con disabilità.
10. Il coinvolgimento della famiglia. Coinvolgere le famiglie è un passaggio molto importante affinché la ricchezza del programma di inclusione non si esaurisca tra le mura scolastiche: organizzare un lavoro di rete attorno al bambino è infatti fondamentale per dare continuità e coerenza all’intervento. All’interno del progetto individualizzato per la promozione dell’integrazione e dello sviluppo delle autonomie di un alunno frequentante la prima classe di scuola secondaria di primo grado, è stato possibile perseguire gli obiettivi in un lavoro di rete con le strutture sanitarie e la famiglia del ragazzo. Quest’ultima ha rappresentato un partner primario nell’intervento, ricevendo anche un supporto a domicilio dagli operatori di un’associazione attiva sul territorio limitrofo e coordinato con l’intervento scolastico.
11. La replicabilità. Gli autori dei diversi progetti sopra citati non solo hanno mostrato disponibilità alla condivisione del proprio bagaglio esperienziale, ma lo hanno organizzato e presentato in modo preciso e sistematico, spesso fornendo anche esempi concreti di schede e materiali utilizzati o evidenze sperimentali dell’efficacia degli interventi tramite misurazioni pre-post. Tutto questo permette alla comunità scientifica e clinica di crescere, soprattutto a fronte del fatto che la letteratura scientifica scarseggia in merito, e le prassi per l’intervento per l’inclusione scolastica rischiano di rimanere un tema intrappolato tra le mura di classe.
Il ruolo dello psicologo
All’interno di uno scenario così complesso e in cambiamento, è importante che i diversi professionisti facciano rete e che il mondo educativo e quello scientifico si incontrino per costruire insieme dei modelli di lavoro per inclusione efficaci e replicabili ma che lascino al contempo margini per la personalizzazione dell’intervento. In stretta collaborazione con altre figure professionali quali pedagogisti, educatori e insegnanti, lo psicologo si inserisce quindi come figura ponte tra mondo scolastico, strutture socio-sanitarie e famiglie, per progettare e monitorare l’intervento con una raccolta dati qualitativa e quantitativa che sia utile direttamente sul campo e in un’ottica più ampia di ricerca scientifica.