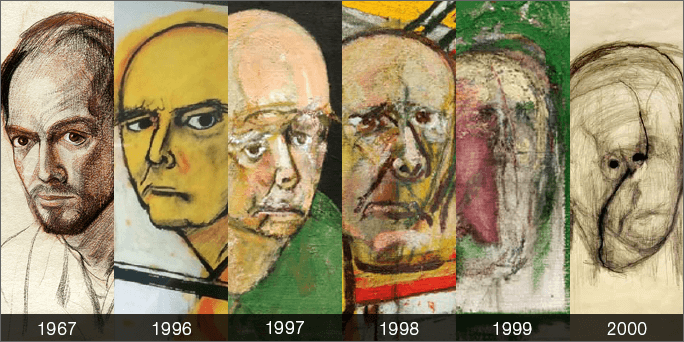La testimonianza: invecchiamento ed emozioni
La ricerca sperimentale proposta è stata improntata con il fine di rilevare le differenze tra giovani e anziani nella rievocazione di eventi, osservando, inoltre, come diversi stati emotivi possano influenzare la testimonianza resa dai soggetti.
Fabiola Caruso – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
I cambiamenti dell’invecchiamento
Nel corso dell’
invecchiamento, sullo stato psicologico dell’individuo, hanno effetto una serie di fattori non psicologici come i cambiamenti biologici, sociali e gli eventi di vita. Tra i cambiamenti biologici si registrano modificazioni a carico di quasi tutti gli organi e apparati, in particolare del sistema nervoso, di quelli cardiovascolare, respiratorio, endocrino, scheletrico e muscolare, digestivo, urinario e genitale. Si tratta di cambiamenti geneticamente predeterminati, dovuti sia a cause ambientali, sia a comportamenti individuali. Particolare importanza hanno i vissuti relativi alla propria immagine corporea e alla
sessualità. Tra i cambiamenti sociali i principali sono il pensionamento e i cambiamenti della struttura familiare, con la perdita, rispettivamente, del ruolo lavorativo e del ruolo di genitore. Queste perdite possono essere più o meno drammatiche a seconda della centralità che questi ruoli avevano nell’identità dell’individuo. Eventi stressanti come malattie possono comportare invalidità anche solo temporanea, ma possono indurre o far emergere forme di
depressione. Infine, l’esperienza della
morte di una persona cara comporta, attraverso una serie di passaggi, una lunga fase di elaborazione del lutto e nei casi positivi, il recupero della capacità di stabilire nuove relazioni affettive.
I cambiamenti cognitivi
L’invecchiamento è un fenomeno multidimensionale e multidirezionale, dove diverse dimensioni seguono andamenti diversi; questo dato è riscontrabile anche al livello cerebrale, dove solo alcune aree appaiono maggiormente sensibili all’avanzare dell’età, tra le quali la corteccia prefrontale. Grazie alla plasticità neuronale si assiste ad una riorganizzazione funzionale che permette all’anziano di mantenere adeguati livelli di prestazione nonostante il declino biologico.
L’attenzione
L’attenzione può essere definita come la capacità del nostro sistema percettivo di selezionare tra le moltissime informazioni che colpiscono i nostri organi di senso quelle a cui siamo interessati e che siamo in grado di elaborare. L’attenzione selettiva è la capacità di ignorare l’informazione irrilevante per gli scopi del soggetto e di mettere a fuoco quella rilevante, facoltà che sembra diminuire nell’anziano, come dimostrato in alcuni studi sull’ascolto dicotico, ovvero in situazioni in cui vengono trasmesse informazioni diverse ai due orecchi con l’istruzione di ascoltare solo un messaggio ignorando l’altro (Rabbit, 1965). L’attenzione distribuita entra in gioco quando si devono svolgere due compiti contemporaneamente, come conversare e scrivere un appunto, risulta anch’essa meno efficiente nell’età avanzata. L’attenzione sostenuta o vigilanza è la capacità di mantenere una adeguata prestazione in compiti monotoni per periodi relativamente lunghi; nell’invecchiamento subentra una maggiore distraibilità dovuta alla ridotta capacità di inibire le informazioni irrilevanti. Si ritiene che l’inibizione sia un meccanismo molto importante nei processi cognitivi e che nell’invecchiamento subisca un declino che spiegherebbe il rallentamento dell’anziano durante l’esecuzione di diversi compiti cognitivi in cui, appunto, perderebbe tempo in operazioni inutili, tant’è vero che spesso le prestazioni dell’anziano sono più lente ma più accurate (Rabbit, 1965). L’attenzione è coinvolta in modo differente nelle diverse operazioni cognitive. Secondo Hascher e Zack alcuni processi sono automatici, ovvero, richiedono poche risorse cognitive, sono poco influenzati dallo svolgimento di un altro compito, come pure da una forte attivazione emozionale o da affaticamento. Altri processi sono controllati, cioè richiedono un investimento maggiore di risorse cognitive, sono sensibili alle istruzioni del compito, all’interferenza di un compito contemporaneo e allo stress (Cornoldi, 1986). Una stessa attività può essere svolta con processi controllati nella fase di apprendimento e poi con l’esperienza può svolgersi attraverso processi automatici. Nell’invecchiamento, il declino delle capacità attentive influenza principalmente i processi controllati, mentre attività guidate da processi automatici possono essere svolte ad un buon livello.
Apprendimento e memoria
Ratti e Amoretti (1991) hanno effettuato una rassegna delle ricerche sperimentali sulle prestazioni di memoria degli anziani. Da questa rassegna si evince che per quanto riguarda la memoria sensoriale non si riscontrano differenze con l’avanzare dell’età e anche per quanto riguarda la memoria a breve termine, la quantità di informazioni che può contenere non sembra variare con l’età, mentre quando l’informazione deve essere riorganizzata o resa disponibile per qualche scopo, le capacità degli anziani si mostrano peggiori di quelle dei giovani. Nell’invecchiamento la memoria a lungo termine è il sistema più danneggiato, in particolar modo, è più deteriorata quella che usiamo nella vita di tutti i giorni e che riguarda gli avvenimenti abbastanza recenti, mentre è più preservata quella che riguarda gli avvenimenti più remoti. Si è riscontrato un deficit che riguarda selettivamente la rievocazione, ovvero la ricerca di un elemento che si è appreso senza nessun aiuto o suggerimento esterno, mentre il riconoscimento è meno deteriorato e consiste nella capacità di distinguere l’elemento appreso se viene presentato in mezzo ad altri elementi nuovi. Questa situazione di divario è presente anche nei giovani, ma negli anziani è molto più accentuata e fa presupporre che la perdita di informazione avvenga a livello di recupero piuttosto che a livello di codifica. Inoltre, la tecnica di rievocazione guidata da suggerimenti dello sperimentatore sembra avvantaggiare più gli anziani che i giovani. Gli anziani mostrano un rallentamento della velocità della prestazione che è maggiormente presente nei compiti complessi. La prestazione degli anziani si avvicina a quella dei giovani nei compiti in cui ai soggetti non vengono date delle scadenze temporali. Inoltre è stata riscontrata negli anziani una difficoltà nell’uso spontaneo di strategie, sia nella fase di codifica e sia nella fase di recupero. È stata messa in evidenza negli anziani anche una difficoltà nell’elaborazione profonda degli item da memorizzare, come per esempio, un’elaborazione semantica invece di una visiva o fonetica, probabilmente dovuta a un problema di accesso alla memoria semantica. In aggiunta, è stato osservato che le situazioni sperimentali che studiano la prestazione dei soggetti anziani in compiti più simili ad un’esperienza d’esame che di vita quotidiana risultano, per l’anziano, particolarmente stressanti ed ansiogene, con l’effetto di far crollare la sua prestazione. Queste condizioni, ai giovani, risultano più familiari e frequenti, in quanto sono analoghe ai compiti scolastici e ai test di profitto. Inoltre, un alto livello di stress, un basso livello di motivazione al compito e una bassa autostima possono rendere l’anziano meno reattivo ed efficiente sul piano mentale.
La memoria autobiografica
La memoria autobiografica presenta, per chi la voglia studiare, un problema metodologico: non è quasi mai possibile riscontrare l’effettiva veridicità del materiale ricordato, non si può cioè valutare la correttezza del ricordo, dato che si tratta in gran parte di una ricostruzione sociale, in cui l’esperienza di un autentico ricordo è difficilmente distinguibile dalla narrazione che quell’evento ha subito nell’ambito familiare. Per questo nella ricerca si ricorre frequentemente a ricordi detti pubblici, come il Giro d’Italia, il presidente della Repubblica, il Festival di San Remo o un certo film. I ricordi autobiografici, compresi quelli pubblici, sembrano ben conservati nella memoria degli anziani. Andreani e collaboratori (1988) verificarono che esiste una perdita dei ricordi d’infanzia dopo i 70 anni. In generale la fascia d’età di cui si conservano meglio i ricordi è quella tra i 10 ed i 30 anni. Questo fenomeno può essere dovuto al fatto che in quegli anni accadono gli eventi più positivi e più emozionanti della vita, come l’indipendenza economica, le prime relazioni sentimentali importanti, la nascita dei figli. Oppure può essere dovuto dal fatto che i ricordi relativi a quegli anni siano stati codificati in corrispondenza della massima efficienza del sistema cognitivo dell’individuo, garantendo una migliore conservazione e possibilità di recupero dei ricordi anche dopo molto tempo.
Il linguaggio
Per quanto riguarda il lessico, la capacità di comprendere il significato delle parole sembra restare inalterata con il trascorrere del tempo, mentre la capacità di produrre le parole si riduce con l’avanzare dell’età. In particolare i processi più colpiti sono il ricordo di specifiche parole, la pianificazione di quello che si vuole dire, un rallentamento nella codifica e di conseguenza anche nella comprensione, soprattutto quando il materiale è sintatticamente complesso o con doppie negazioni dato che gravano sul la memoria di lavoro (MacKay, Abrams, 1996).
Emozioni
I processi cognitivi, sociali e affettivi sono intrinsecamente connessi. Pertanto, le emozioni hanno un ruolo decisivo nell’apprendimento, nella memoria, nelle motivazioni dell’individuo, in quanto facilitano o, al contrario, ostacolano tali processi, contribuendo al raggiungimento o meno degli obiettivi. Emozioni intense come la paura indotta da una minaccia per la propria vita, sono in grado di disturbare temporaneamente la capacità di ricordare dati, nomi, nozioni, fatti ed eventi autobiografici, ossia compromettono per breve tempo la rievocazione di ricordi che appartengono alla memoria dichiarativa nelle sue componenti semantica ed episodica. In generale, l’effetto prevalente delle emozioni sulla registrazione e la rievocazione dei ricordi è positivo. Infatti, in circostanze che suscitano delle emozioni, siamo in grado di fissare particolari e dettagli che altrimenti ci sarebbero sfuggiti. Inoltre il ricordo di episodi autobiografici rilevanti in termini affettivo-emotivi persiste molto più a lungo e ci appare temporalmente più prossimo di quello relativo a fatti e circostanze che abbiamo vissuto come neutri. Numerosi esperimenti hanno dimostrato che l’emozione accresce l’efficienza della percezione e dell’attenzione durante la codifica e aumenta la probabilità che un’informazione sia ulteriormente elaborata ed organizzata (Brown e Kulik, flashbulb memories 1977; Schonfield 1980; Carstensen e Turk-charles, 1994). Una mole, non meno cospicua, di prove sperimentali, sostiene l’evidenza di una modulazione emozionale positiva delle fasi di consolidamento post-codifica, consistente nel rendere estremamente più probabile che un evento sia ritenuto e conservato nella forma di una traccia stabile e durevole (LeDoux, 1996; Steca e Caprara 2007). Anche sulla rievocazione si è dimostrato un effetto di rinforzo da parte dell’emozione, che oltre ad accrescere la probabilità che un’informazione sia recuperata, determina la sensazione di essere in possesso di un ricordo più vivido, presente, incisivo ed in grado, a sua volta, di generare emozione. Inoltre, la riattivazione di ricordi espliciti è facilitata quando le condizioni in cui ci troviamo sono simili a quelle che erano presenti al momento della registrazione: ci si riferisce sia al mondo fisico composto da immagini, suoni ed odori, che al mondo interiore composto da stati della mente, emozioni e modelli mentali. Le emozioni sono il cuore delle nostre relazioni sociali e permettono di agire nei contesti famigliari, culturali o sociali. Ma come cambiano e quali sono le emozioni dell’anziano? Secondo la teoria selettiva socioemotiva di Carstensen (2006), le emozioni sono dei processi psicologici centrali, la cui regolazione, all’aumentare dell’età, diventa più sofisticata poiché cambiano gli obiettivi che gli anziani si prefiggono. Si privilegiano emozioni positive e si minimizzano quelle negative. Queste modifiche sono dovute all’esperienza che gli individui hanno acquisito con l’età e alla consapevolezza che il tempo che resta è breve. Secondo tale teoria, la ristretta rete sociale degli anziani viene interpretata non in termini di disimpegno, ma come selezione di quelle relazioni che sono importanti, gratificanti, significative e che li ricompensino emotivamente rispetto a quelle superficiali. Secondo la teoria cognitiva affettiva di Labouvie-Vief (1996) gli anziani tendono a regolare le emozioni più frequentemente e spontaneamente dei giovani per adeguarsi alle norme sociali, evitando inutili conflitti. Nel corso della vita si passa da un controllo primario, volto all’influenza diretta sul mondo esterno, ad uno secondario, centrato sul Sé e sui cambiamenti intraindividuali (Schulz, 1998). Più che di cambiamenti emotivi, con l’avanzare dell’età, si osserva una maggiore modulazione delle emozioni, ciò spiega la maggiore stabilità dell’umore, la diminuzione della risposta psicofisiologica e la ridotta ricerca di emozioni. Gli aspetti emotivi positivi nell’invecchiamento, in assenza di ansia o depressione, non declinano con l’età e si potenziano, sfatando il mito dell’anziano triste e brontolone. Ciò nonostante, una delle emozioni più studiate è la depressione, dato che è una delle maggiori cause dei disordini della memoria, infatti, più una persona è depressa, peggiori saranno le prestazioni di memoria. Per trasferire qualcosa in memoria dobbiamo dedicare una certa quantità di sforzo al compito e focalizzarci su di esso per elaborare il materiale, collegarlo ad altre informazioni dato che la qualità del nostro ricordo dipende da quanto abbiamo elaborato il materiale appreso. Ogni singola esperienza, quindi, non stimola solo una singola risposta emotiva, ma anche alcune emozioni correlate. Caratteristica della vecchiaia è proprio l’accumulo di molte esperienze emotive, alle quali la mente attinge. I compiti più difficili, per i soggetti anziani, specialmente se depressi, sono quelli che richiedono un maggior sforzo per organizzare ed elaborare il materiale. Quindi possiamo sostenere che le emozioni giocano un importante ruolo nei processi cognitivi legati alla memoria, in quanto la forza dei ricordi dipende dal grado di attivazione emozionale indotto dall’apprendimento, per cui eventi ed esperienze vissute con una partecipazione emotiva di livello medio-alto vengono catalogati nella nostra mente come importanti e hanno una buona probabilità di venire successivamente ricordati. Inoltre, il cervello interagisce con il mondo e registra le diverse esperienze in modo tale per cui gli avvenimenti passati influiranno in modo diretto su come e che cosa impariamo, anche se di tali avvenimenti non necessariamente abbiamo un ricordo conscio, mentre la riattivazione di ricordi espliciti è facilitata quando le condizioni in cui ci troviamo sono simili, in termini di mondo fisico (immagini, suoni, odori) o interiore (stati della mente, emozioni, modelli mentali), a quelli che erano presenti al momento della registrazione ordinaria.
Lo stress
Secondo Aldwin e collaboratori, in tarda età, si assiste ad un passaggio da stress episodici, tipici dell’età adulta, a stress cronici, che possono riguardare la perdita di persone care o l’insorgenza di malattie, che possono influenzare i processi di coping. Gli eventi, in generale, possono essere soggettivamente vissuti come molto stressanti e risultare molto destrutturanti. Labouvie-Vief e collaboratori hanno riscontrato che gli anziani usano una combinazione di strategie di coping focalizzate sulla regolarizzazione delle emozioni e sulla maggiore accettazione del proprio stato, come controllo e soluzione degli eventi stressanti. Le persone anziane si mostrano con maggiori capacità di adattamento alle situazioni di avversità.
La testimonianza
Le scienze cognitive hanno dimostrato come la memoria sia un fenomeno dinamico e largamente ricostruttivo che consiste di diversi processi (percezione, codifica, immagazzinamento e recupero) su ciascuno dei quali possono agire fattori di distorsione cognitivi, emotivi, relazionali e culturali. La testimonianza è un processo complesso e multidimensionale, specie quando essa riguarda eventi traumatici. Infatti, non bisogna mai trascurare gli elementi contestuali ed emotivi che accompagnano non solo il racconto, ma l’intero processo di acquisizione e consolidamento dei ricordi. Un esempio di come la testimonianza sia largamente influenzata dalle caratteristiche emozionali dell’evento oggetto del ricordo è costituito dal cosiddetto effetto weapon focus (Loftus, Loftus e Messo,1987; Steblay, 1992), ovvero quel fenomeno che accade quando un elemento saliente in una scena (ad esempio l’arma impugnata dal criminale) si impone sull’attenzione, ponendo sullo sfondo e quindi oscurando altri elementi e dettagli presenti nella scena che verranno per questo ricordati in modo peggiore. Le caratteristiche del weapon focus sono consistentemente riscontrabili durante l’esperienza di un evento traumatico, in cui i particolari che il soggetto registra al momento del fatto, e quindi sotto spinta emotiva, sono i soli che riesce a rievocare. Il nostro bagaglio di memorie, quindi, si sviluppa attraverso processi di codifica, immagazzinamento e recupero largamente ricostruttivi e interpretativi. Per quanto riguarda gli aspetti di codifica, da numerose ricerche sul campo è emerso che il materiale che ha un significato si ricorda meglio di quello che non ce l’ha, informazioni presentate lentamente si ricordano in modo migliore rispetto a quelle presentate velocemente, informazioni concrete si ricordano meglio di quelle astratte, eventi inusuali si ricordano più facilmente di quelli comuni (Roediger e Gallo, 2002). In altri studi sperimentali (Cristianson, Loftus, 1991) si è verificato come si tende a ricordare con maggiore precisione un numero più elevato di elementi nel caso di situazioni emotivamente più cariche rispetto ad altre neutre. Per quanto attiene al recupero di un ricordo, esso avviene attraverso una ricostruzione di elementi che non sempre sono ben collegati tra loro e che subiscono influenze ambientali, culturali ed emotive. Questo dato è particolarmente significativo quando si parla di ricordi di eventi traumatici siano essi fisici o psichici.
Le fonti di distorsione nel ricordo di un evento
La ricerca ha individuato tre fonti di distorsione del ricordo. Quelle interne, cioè legate esclusivamente alle caratteristiche dell’osservatore. Quelle esterne, in cui le informazioni successive all’evento incidono sulla fissazione del ricordo del soggetto. Infine quelle relazionali, in cui la rievocazione può essere influenzata da aspetti relazionali e comunicativi con l’interlocutore durante la testimonianza. Le prime due forme di distorsione non sono dovute a specifici suggerimenti, mentre la terza incide fortemente nel corso delle tecniche di intervista e o di interrogatorio. Per quanto riguarda le fonti di distorsione interne ci si riferisce alle caratteristiche di suggestionabilità del soggetto ed alle abilità connesse al source monitoring, ovvero la capacità di identificare il contesto nel quale è avvenuto l’evento oggetto del ricordo. Il reality monitoring è uno specifico aspetto dell’identificazione della fonte del ricordo, che descrive la capacità di discriminare eventi interni (ad esempio immaginati) ed eventi esterni (ad esempio visti o uditi). La confusione o gli errori nel reality monitoring conducono ad un falso ricordo (Johnson, 2006). Rispetto ai fattori esterni all’individuo nella percezione e nel recupero del ricordo, oltre alle informazioni ricevute successivamente all’evento, studi di laboratorio (Baddeley et al., 2009) hanno individuato altre variabili da tenere in considerazione, quali la frequenza dell’esposizione all’evento, la durata dell’osservazione e la posizione dell’evento, cioè la collocazione di un singolo fatto in una serie più vasta di avvenimenti. Ad esempio, la durata di esposizione all’evento aumenta la possibilità di percezione e dunque di codifica, mentre, se si assiste a una sequenza di eventi, è più facile percepire e ricordare quelli che si sono verificati all’inizio (effetto primacy) e alla fine (effetto recency) rispetto a quelli nel mezzo. Le distorsioni della memoria possono, infine, dipendere anche dall’influenza di fattori relazionali e comunicativi, come suggerimenti, nuove informazioni e conoscenze che causano una distorsione del ricordo o producono, nei casi più estremi, un falso ricordo. Si presentano diversi effetti che scaturiscono dall’aggiunta di informazioni e da domande suggestive: tra questi ricordiamo l’effetto cosiddetto di suggestionabilità e di compiacenza. L’effetto compiacenza accade quando al soggetto vengono rivolte le stesse domande più volte, alla fine il testimone risponde con ciò che l’esaminatore vuole sentirsi dire (Fornari, 2008). La semplice ripetizione della stessa domanda nel caso di bambini può portare al ricordo di eventi mai avvenuti (Gulotta e Ercolin, 2004). I testimoni possono essere più o meno suscettibili a queste influenze.
Suggestionabilità e testimonianza
Le fonti di distorsione esterne (informazioni post-evento) interagiscono con le caratteristiche dell’individuo soggetto e della relazione tra esso e l’interlocutore nel plasmare la capacità di ricordare. Le influenze delle informazioni post-evento sulla memoria possono essere particolarmente subdole. Elizabeth Loftus ha condotto diverse ricerche che hanno posto l’attenzione sul potere esercitato da determinate tipologie di domande o suggerimenti esterni nel recupero di un evento vissuto. Ad esempio, è emerso che è sufficiente cambiare in una domanda una piccola parte, come l’articolo, per aumentare la probabilità di modifica di un ricordo (Loftus e Zanni, 1975, Loftus, 2005). Ad esempio, se si chiede hai visto un uomo o hai visto l’uomo la domanda cambia poiché nel primo caso si indica un individuo qualunque di genere maschile mentre, nel secondo caso, si fa riferimento ad un individuo specifico di cui si assume che l’interlocutore abbia conoscenza. Il fenomeno per cui l’aggiunta di informazioni suggestive porta a modificare il ricordo di un evento si chiama post-event misinformation effect, ossia l’effetto di un’informazione fuorviante fornita dopo l’evento (Loftus, 2005). Questo effetto può avvenire in situazioni sociali (Gabbert et al., 2004; Wright, Self, e Justice, 2000; Gulotta e Ercolin, 2004, Brainerd e Reyna, 2005) e non sociali (Lindsay, 1990; Loftus e Palmer, 1974). Diversi studi di laboratorio hanno cercato di analizzare i meccanismi che portano a modificare i ricordi. Un interessante studio è stato condotto da Crombag, Wagenaar e Van Koppen (1996) in merito allo scontro avvenuto tra un Boeing 747 e un palazzo di undici piani ad Amsterdam nell’ottobre del 1992. La televisione olandese riportò tutti i momenti dell’evento ma non trasmise alcuna immagine del momento dello schianto. I telegiornali riportarono la notizia del disastro per alcuni giorni. La ricerca, tesa a sondare il ricordo del terribile evento, evidenziò che 61 dei 93 studenti che parteciparono all’esperimento risposero in modo affermativo alla domanda: Hai visto in televisione il filmato del momento in cui l’aereo ha colpito il palazzo?. Tale domanda in realtà conteneva una falsa informazione, ovvero che il filmato dello schianto fosse stato mostrato in televisione. Inoltre, molti testimoni fornirono numerosi dettagli dell’inesistente video dell’impatto dell’aereo. È bene sottolineare che la suggestionabilità non implica solo aggiungere o modificare gli elementi di una scena, ma riguarda anche ricordare eventi mai vissuti (Hyman, Husband e Billings,1995; Loftus e Pickrell, 1995; Gulotta e Ercolin, 2004). A tale proposito, va considerato che affinché negli individui si crei un falso ricordo, è necessario che le fonti di distorsione rispondano a tre requisiti (De Leo, Scali e Caso, 2005):
- l’evento suggerito deve essere plausibile, cioè deve trattarsi di qualcosa di possibile.
- il soggetto dovrà anche costruire un’immagine del ricordo e una narrazione. Infatti, tutti i ricordi sono costruzioni che combinano conoscenze di base provenienti da varie fonti con esperienze personali, suggerimenti e richieste attuali (Bartlett, 1932).
- è necessario che ci sia un errore nella valutazione della fonte, cioè che il soggetto creda che quell’informazione non sia stata creata da lui ma provenga dall’esterno.
Gisli H. Gudjonsson è uno dei più importanti studiosi di suggestione e ha condotto numerose ricerche tese ad analizzare come i soggetti reagiscono di fronte a situazioni e domande suggestive. Gudjonsson e collaboratori, attraverso alcuni studi hanno messo in luce che intelligenza, autostima, capacità mnestica e assertività, locus of control interno e capacità di agire strategie di coping sono fattori psicologici che risultano correlati negativamente con la suggestionabilità (Gudjonsson, 2003). Per poter studiare la suggestionabilità Gudjonsson (1984, 2003) costruì uno strumento per valutare la suscettibilità ad interrogatori coercitivi che si basa su due diversi aspetti della suggestionabilità, il cedimento (yielding) a domande suggestive e il cambio di risposta (shifting) quando è applicato un interrogatorio pressante. Il test consiste nel presentare un racconto e nel chiedere di riportare tutto ciò che si ricorda della storia. Dopo la fase di rievocazione il soggetto viene sottoposto a 20 domande delle quali 15 sono suggestive ed errate. Dopo aver risposto, alla persona viene detto che ha commesso un certo numero di errori, anche se non è vero. Inoltre, in modo vigoroso, viene richiesto di rispondere nuovamente alle domande, con la raccomandazione di essere più accurato. Il cedimento si riferisce alla suscettibilità dell’intervistato alle domande suggestive, mentre il cambio di risposta si riferisce al cambiamento in seguito all’interrogatorio pressante. La somma tra il numero di cambi e di cedimenti fornisce il punteggio totale ottenuto nella scala di suggestionabilità.
Lo stress e la rievocazione del ricordo
Tra i diversi fattori che possono incidere sulla rievocazione del ricordo uno particolarmente importante è lo stress. È importante sottolineare che uno stress eccessivo, come ad esempio assistere a una rapina violenta o all’omicidio di un proprio caro, può portare anche ad uno stato di dissociazione. In questi casi si può arrivare a non ricordare elementi centrali dell’evento o addirittura l’intero evento traumatico, in tal caso si parla di amnesia retrograda o dissociativa (Holmes et al, 2005; Loftus, 1993; Pezdek, 1994; Pezdek e Banks, 1996). Un altro aspetto importante riguarda il coinvolgimento emotivo e la memoria dell’evento. Smith e colleghi (2004) studiarono un gruppo di studenti canadesi dell’Università di Toronto a sei mesi dall’attacco alle Twin Towers a New York. Gli autori sottoposero il campione ad un questionario per valutare la memoria dell’evento e quella autobiografica. Essi rilevarono una correlazione tra il grado di coinvolgimento emotivo e la qualità del ricordo. Nello specifico, i ricercatori notarono che all’aumentare del coinvolgimento emotivo diminuiva la memoria autobiografica ed aumentava quella relativa all’evento in questione. Lo studio di Grey e colleghi (2002) evidenzia che la memoria delle vittime di un trauma è frammentata e lacunosa, in particolare, relativamente ai momenti chiave dell’evento. Concludendo, ad oggi non è ancora chiaro se un elevato stress durante la fase di codifica o recupero porti ad un vantaggio o svantaggio mnestico. Le contraddittorie scoperte suggeriscono che la relazione tra stress e memoria sia complessa e dipenda da molteplici fattori biologici e psicologici, le cui interazioni meritano ulteriore approfondimento scientifico.
Attendibilità della testimonianza
L’attendibilità della testimonianza è strettamente connessa all’accuratezza di ciò che viene dichiarato, si tratta di determinare se il ricordo rifletta in maniera fedele tutti gli elementi che riguardano l’evento di cui si è stati testimoni. Attendibilità e accuratezza, quindi, riguardano gli aspetti percettivi, cognitivi e riproduttivi della testimonianza. I fattori che incidono sull’attendibilità e l’accuratezza della testimonianza, riguardano sia le condizioni in cui avviene la codifica dell’evento, come la natura dell’evento, la sua coloritura emotiva, i diversi elementi della scena (luogo, oggetti e persone presenti, loro collocazione spaziale, il volto e le loro azioni, ecc.), sia le condizioni in cui avviene il recupero, come il tipo di prova di memoria a cui il soggetto è sottoposto (ricordo libero, guidato, ecc.), l’intervallo di tempo che intercorre tra la codifica dell’evento e del suo recupero. Inoltre, anche le convinzioni e i pregiudizi sociali delle persone, possono avere una grossa influenza fino a modificare il modo in cui un evento viene percepito. Spesso capita che nel ricordare un evento, possiamo correggere l’informazione in maniera inconsapevole, allo scopo di renderla concordante con le nostre aspettative. Incidono anche la presenza o assenza dell’intenzione di dover ricordare nel momento in cui si assiste all’episodio, la quantità di tempo che passa tra l’episodio e la testimonianza, la consapevolezza della differenza tra verità e menzogna e la volontà di voler dire la verità e quella di mentire.
La ricerca sperimentale
La ricerca sperimentale proposta è stata improntata con il fine di rilevare le differenze tra giovani e anziani nella rievocazione di eventi, osservando, inoltre, come diversi stati emotivi possano influenzare la testimonianza resa dai soggetti. È stata condotta su un totale di 144 soggetti, divisi in due gruppi principali, uno formato da 72 giovani con età media di 16,5 anni e quello degli anziani composto da 72 soggetti con età media di 76,5 anni. In un primo momento i soggetti sono stati sottoposti ad un test che rilevasse il loro stato emotivo, ovvero il Positive Affect and Negative Affect Scales (PANAS). Il PANAS (Watson et al., 1988) è uno degli strumenti più utilizzati per valutare gli stati affettivi positivi e negativi, composto da 20 aggettivi, 10 per la scala di affetto positivo (PA) e 10 per la scala di affetto negativo (NA). In particolare, la sottoscala PA riflette il grado in cui una persona si sente entusiasta, attiva e determinata, mentre la sottoscala NA fa riferimento ad alcuni stati spiacevoli generali come la rabbia, la colpa e la paura. Il soggetto deve valutare quanto si sente generalmente nel modo descritto dall’aggettivo, rispondendo su una scala Likert a 5 punti (1= per nulla, 2=poco, 3=moderatamente, 4=abbastanza, 5=molto). Esempi di aggettivi sono interessato, entusiasta, deciso, angosciato, ostile e nervoso. Dopo la somministrazione di questo test tutti i soggetti hanno ottenuto due punteggi, corrispondenti al proprio stato emotivo, positivo e negativo. In seguito i due gruppi sono stati entrambi suddivisi in 6 sottogruppi da 12 soggetti. Due sottogruppi di entrambi i gruppi principali hanno visionato un video divertente dalla durata di 5 minuti, altri due sottogruppi di entrambi i gruppi hanno visionato un video neutro sulla costruzione di una libreria della durata di 5 minuti e i restanti 2 sottogruppi hanno visionato un video negativo di 5 minuti sulla guerra di Pearl Harbor. I tre video sono stati introdotti nella sperimentazione per poter osservare se la loro visualizzazione inducesse un cambiamento emotivo nei soggetti. In seguito alla visione del filmato (divertente, neutro, negativo) i soggetti sono stati sottoposti nuovamente al PANAS, in modo da poter confrontare i punteggi ottenuti ai due test. In seguito troviamo il grafico che mostra le modificazioni dell’umore nei due gruppi in base ai video visionati.
Per quanto riguarda la visione del video neutro, possiamo osservare, per il gruppo dei giovani, un calo della sottoscala dell’affetto positivo (PA), probabilmente ciò lo si può spiegare ipotizzando che il video sia stato ritenuto un po’ noioso. Per il gruppo degli anziani si osserva un invariato stato emotivo. Per quanto riguarda la visione del video positivo, nel gruppo dei giovani si osserva una riduzione dei valori della sottoscala dell’affetto negativo (NA) e un lieve aumento della sottoscala dell’affetto positivo (PA). Nel gruppo degli anziani si evince un lieve aumento della sottoscala PA e i valori della sottoscala NA sono quasi invariati. Per quanto riguarda la visione del video negativo, il gruppo dei giovani mostra un lieve aumento dei valori della sottoscala NA, mentre la sottoscala PA è quasi invariata. Nel gruppo degli anziani si osserva una riduzione della sottoscala PA e un aumento della sottoscala NA; probabilmente questo effetto più marcato si può spiegare con il fatto che la maggior parte degli anziani ha vissuto in prima persona la seconda guerra mondiale mentre i giovani no. In generale, gli anziani hanno delle modificazioni emotive meno marcate rispetto ai giovani, in accordo con la teoria cognitiva affettiva di Labouvie-Vief secondo cui gli anziani tendono a regolare le emozioni più frequentemente e spontaneamente rispetto ai giovani, ad eccezione delle emozioni negative che hanno effetti maggiori nelle persone anziane. A questo punto i partecipanti hanno visionato il video di una rapina senza audio, ed hanno ricevuto le istruzioni di osservare bene il video in quanto avrebbero dovuto rispondere a delle domande su di esso. Le istruzioni precisavano di prestare attenzione in quanto il sapere di dover ricordare aumenta l’attendibilità della testimonianza. Il video è stato presentato senza audio in modo da poter permettere, in un momento successivo, l’introduzione di alcune informazioni fuorvianti e l’osservazione degli effetti che essi provocano nella testimonianza. Il video scelto rappresenta una rapina in banca, dato che rappresenta un evento carico emotivamente e quindi dovrebbe produrre una traccia mnestica abbastanza forte. Dopo la visione del filmato della rapina in banca ai soggetti è stato somministrato il Verbal Associative Fluency Test, che consiste in tre compiti di denominazione di parole, con il set di lettere FAS, infatti il test è a volte chiamato FAS. Ai soggetti è stato chiesto di scrivere tutte le parole che iniziano con la lettera dell’alfabeto indicata, escludendo i nomi propri, i numeri, ed alcune parole con un suffisso differente. Questo test è stato introdotto sia per testare la fluenza dei soggetti sia come distrazione. Successivamente ai 3 sottogruppi del gruppo dei giovani e ai 3 sottogruppi del gruppo degli anziani (visione video neutro, positivo, negativo) è stato fatto ascoltare un audio che descriveva la scena della rapina. Ai restanti 6 sottogruppi è stato fatto ascoltare un audio che descriveva il video della rapina, ma sono state inserite alcune informazioni errate, in modo da poter verificare se queste potessero falsificare il ricordo del video della rapina. In seguito ai soggetti è stato presentato un questionario a scelta multipla dove erano elencati 12 item, di cui 3 rappresentavano le parole corrette da dover riconoscere in quanto erano presenti nel video della rapina, 3 rappresentavano le parole critiche, ossia si riferivano al brano modificato, ma non erano realmente presenti nel video, ed altri 6 item erano di riempimento, ovvero non erano presenti né nel video e né nel brano ascoltato. Ai soggetti veniva data l’istruzione di rispondere al questionario facendo riferimento al video della rapina, indicando per ogni parola, attraverso una crocetta, se era presente nel filmato (si o no) e in che misura erano sicuri, dove 1 indicava tiro ad indovinare, 2 indicava non sono molto sicuro e 3 indicava sono molto sicuro. Per eseguire correttamente il questionario i soggetti avrebbero dovuto rispondere con una crocetta sul sì solo per le tre parole che erano realmente presenti nel video e con un no per le altre parole. Quindi la variabile dipendente di interesse era il numero di errori critici, ovvero la tendenza a riconoscere come appartenenti al video degli elementi inseriti solo nel brano. I risultati sono stati ottenuti effettuando un’analisi statistica fattoriale, un’ANOVA tra il gruppo dei giovani e quello degli anziani, tra la condizione fuorviante e quella di controllo, e tra le diverse tipologie di video (video positivo, negativo e neutro). I risultati, sui punteggi proporzionali medi degli item critici, non hanno evidenziato un effetto principale significativo del gruppo, in quanto sia i giovani che gli anziani hanno commesso un numero di errori simili (.37 i giovani e .35 gli anziani). È stato riscontrato un effetto principale significativo della condizione, in quanto la condizione fuorviante ha generato un maggior numero di errori (.44) rispetto alla situazione di controllo (.28). È stato inoltre riscontrato un effetto principale significativo del tipo di video dovuto al fatto che dopo il video negativo sono stati commessi in generale meno errori (negativo =.29, positivo=.41, neutro=.38). L’interazione a due vie tra i gruppi e le condizioni è risultata significativa in quanto il numero di errori nei giovani è stato simile nella condizione fuorviante (.39) e quella di controllo (.35), mentre negli anziani il numero di errori è stato maggiore nella condizione fuorviante (.49) rispetto a quella di controllo (.21). L’interazione a due vie tra i gruppi e i video non è risultata significativa, indicando che le emozioni abbiano agito in maniera simile in entrambi i gruppi. L’interazione a due vie tra le condizioni e i video è risultata significativa in quanto il numero di errori aumenta molto di più nella condizione fuorviante rispetto a quello della condizione di controllo dopo la visione del video negativo. Infine, l’interazione a tre vie tra gruppi, condizioni e tipo di video non è risultata significativa. Un’ANOVA effettuata solo sui giovani e solo sugli anziani ha evidenziato come nei giovani non ci siano effetti della condizione e del tipo di video sul numero degli errori. Invece, negli anziani è risultato significativo il tipo di condizione, in quanto gli anziani hanno commesso più errori nella condizione fuorviante. L’effetto del tipo di video è risultato marginalmente significativo. Tuttavia, l’interazione tra condizione e video è risultata significativa in quanto sono state soprattutto le emozioni negative a provocare un maggior numero di errori negli anziani nella condizione fuorviante rispetto a quella di controllo.
Conclusione
Una delle caratteristiche della vecchiaia è l’accumulo di molte esperienze emotive, alle quali la mente attinge. Le emozioni, appunto, giocano un importante ruolo nei processi cognitivi legati alla memoria, in quanto la forza dei ricordi dipende dal grado di attivazione emozionale indotto dall’apprendimento, per cui eventi ed esperienze vissute con molta partecipazione emotiva vengono catalogati nella nostra mente come importanti e hanno una buona probabilità di venire successivamente ricordati. La riattivazione di ricordi ci porta a provare le stesse emozioni che abbiamo provato quando vivevamo quel particolare ricordo. Il video con connotazione negativa che è stato utilizzato per la sperimentazione raffigurava la guerra di Pearl Harbor. Nel gruppo di partecipanti anziani, un discreto numero aveva vissuto in prima persona la tragedia della seconda guerra mondiale, e non è difficile ipotizzare che il video proiettato li abbia riportati indietro con la memoria fino a far rivivere quei tragici momenti. Le emozioni suscitate, qualsiasi esse siano, dal video negativo, hanno prodotto in generale un ricordo più accurato a sostegno del fatto che le informazioni cariche emotivamente vengono ricordate meglio di quelle neutre. Negli anziani, le emozioni negative hanno generato un maggior numero di errori nella condizione fuorviante, per cui possiamo attestare che gli anziani con un cattivo umore siano più inclini alla distraibilità e alla suggestionabilità. I giovani, contrariamente agli anziani, non presentano modificazioni di performance in base all’umore. Inoltre possiamo affermare che gli anziani sono più inclini al post-event misinformation effect, ossia all’effetto di un’informazione fuorviante fornita dopo l’evento, in quanto i risultati della ricerca mostrano appunto che gli anziani commettono più errori nella condizione fuorviante rispetto alla condizione di controllo. Nella sperimentazione si è potuto osservare, in accordo con quanto sostenuto da Ratti e Amoretti (1991) sul rallentamento della velocità della prestazione degli anziani in compiti complessi, come gli anziani abbiano impiegato più tempo rispetto ai giovani per completare la prova, circa un’ora per i giovani e un’ora e mezza per gli anziani. Inoltre, la diminuita capacità dell’anziano nell’ignorare le informazioni irrilevanti, potrebbe spiegare in parte il fatto che siano stati commessi più errori nella condizione fuorviante (potrebbero non essere riusciti ad inibire le informazioni fuorvianti ricevute successivamente).