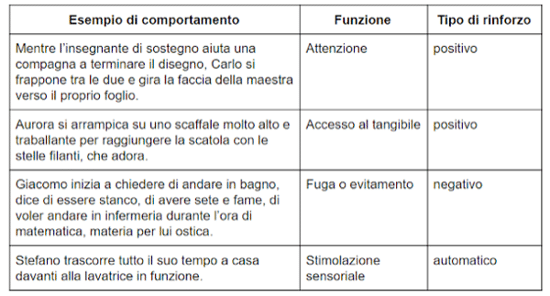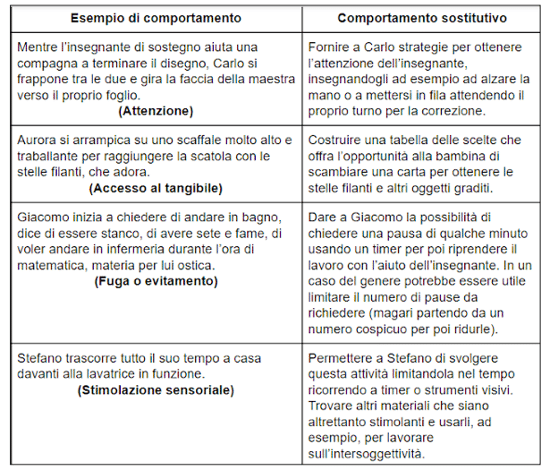Di cosa parliamo quando parliamo di mindfulness
Ogni nuova tecnica, compresa la mindfulness, attraversa una serie di fasi: dopo la fase iniziale di innesco della novità segue la fase delle aspettative gonfiate, cui succede la disillusione. Dopodiché può avere inizio un approccio più costruttivo alla tecnica che fa approdare alla successiva fase di applicabilità e produttività del nuovo strumento.
Commento all’articolo Dove sono le prove dell’efficacia della Mindfulness? che riprende Mind The Hype: A Critical Evaluation and Prescriptive Agenda for Research on Mindfulness and Meditation (Van Dam N. T. et al. 2017), pubblicato su Perspectives on Psychological Science nell’ottobre 2017. Lo studio è citato su Le Scienze (edizione italiana di Scientific American), più conosciuta come Mente & Cervello.
Interessante notare come la stessa rivista nel gennaio 2013 pubblichi l’articolo I sentieri della meditazione: effetti benefici di una pratica millenaria sull’equilibrio del cervello e la salute del corpo.
Un team composto da 15 psicologi e ricercatori facenti capo dall’australiano Nicholas Van Dam afferma che i potenziali vantaggi della mindfulness sono messi in ombra dalle affermazioni iperboliche e dalle speculazioni economiche. Meditazione e allenamenti di mindfulness sono un’industria da 1,1 miliardi di dollari nei soli Stati Uniti.
La dott.ssa Ruth Baer, professoressa di psicologia presso la Kentucky University ed associata all’Oxford Mindfulness Centre dell’Università di Oxford, che ho avuto il piacere di conoscere in occasione del Master in Clinical Mindfulness, spiega questo fenomeno con la teoria sul ciclo dell’iperbole (Hype Cycle): ogni nuova tecnica attraversa una serie di fasi che si intersecano a livello di due variabili, visibilità e maturità.
Dopo la fase iniziale del technology trigger (innesco per così dire della novità), la fase delle aspettative gonfiate (all’apice sull’asse della visibilità) fa assurgere la tecnica in questione allo status di rimedio universale.
Fatalmente, ad eccessive aspettative succede la disillusione, dopodiché può avere inizio un approccio più costruttivo alla tecnica (slope of enlightenment) che fa approdare, con il raggiungimento della maturità, alla successiva fase di applicabilità e produttività del nuovo strumento.
La Mindfulness non fa eccezione.
Il trigger sono le ricerche di Jon Kabat Zinn, che negli anni settanta dimostra l’efficacia delle tecniche di meditazione di tradizione buddhista nel trattamento dello stress e del dolore cronico presso l’Università del Massuchusetts, e la Dialectical Behavior Therapy di Marsha Linehan, che dagli anni ’80 dimostra come mindfulness ed accettazione in sinergia con le strategie volte al cambiamento siano efficaci nel trattamento del Disturbo Borderline di Personalità.
Il crescente interesse sui risultati raggiunge il culmine: la copertina del Time del febbraio 2014 titola Mindfulness Revolution e si iniziano ad intuire i potenziali interessi enormi legati allo sfruttamento della popolarità delle tecniche di consapevolezza, la cui diffusione capillare coincide anche con la sua fase di massima indefinitezza.
E’ necessario attraversare una fase di disillusion per poter prendere contatto con quella che veramente è la potenzialità della mindfulness, attraverso una ricerca rigorosa e quantificabile dei risultati.
Le pubblicazioni scientifiche, una sessantina fino al 2000, nel solo anno 2016 sono 677.
E ci ricolleghiamo al tema dell’articolo, cioè l’indefinitezza delle ricerche.
E’ soprattutto la mancanza di una definizione comune di cosa esattamente si vada a misurare con la mindfulness a creare scetticismo nel gruppo di ricercatori di cui sopra (non sappiamo se questi ricercatori siano a loro volta meditatori esperti, presumo di no). Come hanno scritto Van Dam e colleghi: Non esiste una definizione tecnica universalmente accettata di mindfulness né un ampio accordo sugli aspetti più dettagliati del concetto a cui si riferisce.
Questa affermazione si spiega in parte col fatto che l’esperienza nella tradizione buddhista non è esattamente traducibile per il praticante occidentale.
Inoltre, vi sono diversi tipi di meditazione, ciascuno con proprie caratteristiche.
Le ricerche che andrò a citare riguardano la meditazione di consapevolezza o mindfulness, derivata dalla meditazione Vipassana, alla base delle applicazioni terapeutiche della meditazione a partire dagli anni ’70.
Le due abilità fondamentali che andiamo ad allenare con la mindfulness sono l’attenzione e la consapevolezza, in una maniera peculiare: con volontà, accettazione, gentilezza, non giudizio.
Tutte le definizioni di mindfulness fornite dai principali ricercatori sono sostanzialmente analoghe e riprendono le qualità originariamente contenute nel termine ‘sati’ (lingua indiana Pali utilizzata nella forma liturgica del buddhismo) che connota consapevolezza, attenzione e ricordo.
Westen: la Consapevolezza è il radar della coscienza. Essa monitora continuamente l’ambiente interno ed esterno dell’individuo, il quale può essere consapevole degli stimoli senza che essi siano al centro dell’attenzione. L’attenzione è un processo di focalizzazione della consapevolezza, nella quale viene fornita un’accresciuta sensibilità ad un range limitato di esperienze.
Kabat- Zinn: prestare attenzione, nel momento presente, in modo non giudicante.
Marlett e Kristeller: portare attenzione completa all’esperienza del momento presente con accettazione e gentilezza.
Bishop: autoregolazione dell’attenzione sull’esperienza immediata, con curiosità, apertura e accettazione.
Germer: consapevolezza dell’esperienza presente con accettazione, amichevolezza, non giudizio.
Linehan: focalizzare la mente nel momento presente senza giudizio e attaccamento (o avversione), con apertura e curiosità nei confronti della fluidità del momento.
Per riassumere cito Didonna (2010) che definisce la mindfulness uno stato di coscienza caratterizzato da attenzione consapevole, libera da valutazioni e focalizzata nel presente, verso l’esperienza interna ed esterna e priva di reazioni verso di essa, definizione che chiarisce come sia possibile osservare anche il contenuto della mente: nella psicologia buddhista, la mente è uno degli organi di senso.
Pertanto, il ricercatore (serio) occidentale conosce esattamente il COSA sta misurando, e cioè la capacità di osservare, prestare attenzione, essere consapevoli, e il COME: in modo non giudicante, con apertura, curiosità, accettazione.
Due parole per spiegare cosa si intende per non giudicante: è un approccio alla percezione esperienziale, non concettuale, evitando di mediare l’esperienza la percepiamo nella sua natura essenziale anziché secondo il giudizio che le attribuiamo. Per semplificare, per giudizio possiamo intendere le tre principali modalità di approccio all’esperienza elencate dalla psicologia buddista: l’attaccamento, l’evitamento, l’avversione.
Durante la meditazione, il facilitatore invita spesso i presenti ad osservare le eventuali distrazioni (pensieri, sensazioni corporee, emozioni) prendendo semplicemente atto della loro comparsa e lasciandole andare senza giudicarle e senza giudicare sé stessi per la distrazione, semplicemente tornando a focalizzare l’attenzione sul respiro (utilizzato come ancora al qui e ora, come semplice oggetto di concentrazione).
Nel prosequio del percorso, oltre alla focalizzazione dell’attenzione (meditazione concentrativa) si acquisisce la capacità di ampliare la propria consapevolezza degli stimoli esistenti, e di ridurre la propria reattività alle manifestazioni interne.
L’accettazione è la capacità di stare in contatto con l’esperienza disagevole, creando con essa il rapporto più utile per noi, evitando inutili sforzi per cambiare la sua frequenza o forma, soprattutto quando tale esperienza non è modificabile o quando fare questo incrementerebbe il disagio psicologico.
E’ un atteggiamento attivo, mentre la rassegnazione è passiva.
La mindfulness è uno strumento attentivo, non spirituale, anche per i buddhisti.
E’ vedere le cose nel modo in cui esse sono. La psicologia buddhista è affascinante e complicata, per cui non cercherò di approfondire perché non utile in questa sede.
Mi limito a ciò che interessa al ricercatore occidentale (il meditatore buddhista dice state cercando di dimostrare quello che noi sappiamo da 2.500 anni).
Ciò che il ricercatore è interessato a misurare è se le persone più mindful nel senso indicato dalle definizioni di cui sopra godono di maggiore salute.
Se sì, gli interessa scoprire se la capacità di mindfulness aumenta con l’allenamento, e in quale modo funziona tale allenamento.
Prima di parlare dei benefici della mindfulness, vorrei mettere in luce una importante condizione di base, e cioè che l’osservazione del momento presente è utile solo se non giudicante: se la consapevolezza dei propri contenuti mentali è giudicante e reattiva si rischia di amplificare eventuali vissuti depressivi.
E’ pertanto molto importante la cura del training: durante le otto settimane standard di trattamento dei vari protocolli (MBSR e MBCT i più conosciuti) viene posta molta attenzione alla corretta esecuzione degli esercizi (per semplificare) e soprattutto alla condivisione in gruppo dei vissuti legati all’esperienza personale.
Non ci sono evidenze di effetti avversi peculiari agli interventi mindfulness based rispetto ad altri tipi di intervento, sebbene vi siano dei parametri da rispettare nella scelta dei soggetti (stiamo parlando della popolazione clinica) da inserire nei protocolli.
La misurazione delle capacità viene effettuata soprattutto attraverso questionari di autovalutazione, integrati con un test comportamentale che corregga la tendenza a dare risposte non corrispondenti alla reale percezione.
I principali questionari di autovalutazione sono:
- Mindful Attention Awareness Scale (MAAS)
- Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS)
- Freiburg Mindfulness Inventory (FMI)
- Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), soprattutto nella sua versione abbreviata, che misura le sottoscale osservazione, descrizione, consapevolezza nell’agire, non-giudizio, non-reattività con 15 item invece dei 39 della versione estesa.
Molti degli studi su mindfulness e meditazione, contestano Van Dam e colleghi, sono mal progettati, indeboliti da definizioni incoerenti della mindfulness e spesso privi di un gruppo di controllo per escludere l’effetto placebo.
Una recente meta analisi (Khoury et al. 2013) valuta l’efficacia di 209 studi, per un totale di circa 12.000 partecipanti trattati con MBSR (riduzione dello stress basata sulla mindfulness), MBCT (trattamento delle ricadute depressive), MBRP (trattamento delle dipendenze basato sulla mindfulness), MBCP (trattamento mindfulness genitori e bambini).
Svariate le patologie oggetto delle ricerche: disturbi dell’umore, ansia, abuso di sostanze, psicosi, disturbi dell’attenzione, della personalità e altri; dolore fisico, cancro, obesità, artrite ecc.
Sono stati usati quattro gruppi di controllo: nessun trattamento, trattamento con terapie supportive o tecniche di rilassamento, trattamento con terapia cognitiva, trattamento farmacologico.
Le ricerche sono significative rispetto al gruppo di controllo che non è stato trattato, soprattutto per quanto concerne l’ansia e la depressione, modesta efficacia sul dolore; si rileva una modesta efficacia anche rispetto agli altri gruppi di controllo.
La meta-analisi quantifica le effect-size in small (risultati dell’ordine dello .20), medium (.50), large (.80).
Gli effetti positivi sono presenti al follow-up per diversi mesi.
Una seconda recente meta analisi (Goldberg et al., 2018), simile alla prima per quanto concerne la durata del trattamento (8 settimane) e la numerosità del campione, ma effettuata solo su depressione, ansia e dipendenze (non generico stress), presenta una comparazione con cinque gruppi di controllo: non trattati, trattamento breve, placebo, trattamento non specifico, trattamento evidence-based.
I trattamenti basati sulla mindfulness dimostrano un effetto large rispetto ai trattamenti ‘informali’ (soprattutto per quanto concerne i disturbi d’ansia), e un effetto small rispetto agli altri trattamenti evidence-based.
Si può quindi concordare con Van Dam e colleghi sui piccoli numeri, tuttavia l’interpretazione di tali risultati stabilisce che un trattamento basato sulla mindfulness ha (almeno) la stessa efficacia degli altri interventi, compreso il trattamento farmacologico. Ognuno tragga le proprie conclusioni.
Nello specifico, il protocollo MBSR si mostra efficace per la riduzione dello stress in popolazione non clinica (professionisti della salute mentale, studenti) e nella riduzione di stress e sintomi psicologici in pazienti affetti da malattie invalidanti tra cui cancro e dolore cronico.
Il protocollo MBCT ha effetti importanti sulla prevenzione delle ricadute depressive (pazienti che hanno avuto 3 o più episodi) , mostrando efficacia pari all’assunzione di farmaci antidepressivi. Ci sono ricerche anche in merito al limite di tale trattamento, cioè la sua applicabilità ai pazienti in fase di remissione: si sta testando la sua efficacia anche su persone nella fase attiva della patologia.
Una citazione a parte per quanto concerne gli studi basati su DBT (Dialectical Behavior Therapy) o ACT (Acceptance and committment therapy), non inclusi nelle meta-analisi citate.
Il protocollo DBT ha mostrato risultati importanti nel trattamento del Disturbo Borderline di Personalità, e promettenti appaiono le ricerche per quanto concerne i disturbi dell’alimentazione e da abuso di sostanze.
Il protocollo ACT mostra evidenze consistenti su un’ampia gamma di disturbi, in particolare sulle dipendenze.
Infine, una meta analisi del 2015 (Gu, Strauss, Bond & Cavanagh, 2015) compara le ricerche sui meccanismi che permettono di migliorare benessere e salute mentale attraverso la partecipazione ad un protocollo basato sulla mindfulness.
I risultati di tali ricerche evidenziano un aumento della salute psicologica e fisica attraverso l’incremento di capacità che riguardano l’aumento della consapevolezza, la riduzione della reattività cognitiva che si traduce in minore ruminazione depressiva, la minore reattività emozionale o capacità di recupero più veloce dopo uno stress, l’aumento della capacità di autocompassione, il mantenimento della propria capacità valutativa anche in situazione di stress.
Nel considerare i risultati finora esaminati, di per sé incoraggianti, si tenga presente che si riferiscono ad osservazioni della durata di otto settimane (salvo eccezioni).
L’efficacia della mindfulness è direttamente proporzionale alla pratica quotidiana a casa, e questa è difficilmente misurabile.
Sarebbe interessante poter avere un ipotetico database in cui le migliaia di persone che praticano regolarmente da anni la meditazione riportassero i loro risultati anche solo soggettivi.
Recentemente le tecniche di neuroimaging hanno iniziato ad avvalorare la tesi secondo cui il cervello dei meditatori esperti presenterebbe modifiche strutturali legate alla maggiore o minore attivazione di aree specifiche.
Obiettivo della ricerca neuroscientifica è comprendere i sistemi neuronali utilizzati per raggiungere gli stati meditativi e determinare gli effetti di una pratica regolare di mindfulness sull’attività e sulla struttura del cervello.
La meditazione è associata sia agli effetti di stato che di tratto, vale a dire che le modifiche non sono limitate allo stato meditativo, ma si stabilizzano con la pratica prolungata nel tempo (vale a dire otto settimane come minimo):
si ritiene che gli effetti di tratto siano la conseguenza di trasformazioni stabili e durature nell’attività e nella struttura del cervello. La comprensione degli effetti di stato chiarirà il motivo per cui la mindfulness possa essere utile in terapia per affrontare ricordi dolorosi o reazioni emotive improvvise, mentre la comprensione degli effetti a lungo termine aiuterà a comprendere il motivo per cui la mindfulness si rivela utile nel trattamento di condizioni croniche quali la depressione e l’ansia generalizzata (Treadway-Lazar, 2008).
La complessità stessa della meditazione rappresenta una sfida, perché afferisce a circuiti neuronali differenti che si alternano in un tempo molto limitato: si passa in pochi istanti dall’essere concentrati sul proprio respiro alla distrazione per un pensiero, allo sforzo per riportare l’attenzione dove era, al perdersi in un’immagine legata all’infanzia…
Vi sono pertanto risultati contraddittori nelle ricerche che a partire dagli anni ’60 utilizzano l’EEG per esaminare le modificazioni nell’attività cerebrale durante la meditazione: le differenze sono ascrivibili in buona parte al fatto che pratiche meditative diverse possono produrre pattern di attività cerebrale peculiare a seconda che siano incentrate sul rilassamento (aumento di attività theta e delta) oppure sulla concentrazione intensiva (alfa e beta).
Lo stesso accade per quanto riguarda gli studi di neuroimaging, anche se vi sono alcuni riscontri coerenti a tutti gli studi: durante la meditazione vi è attivazione della corteccia prefrontale dorso-laterale (associata all’attenzione e alla presa di decisioni esecutiva) con cambiamenti di tratto di maggiore ispessimento corticale (particolarmente visibile nei meditatori esperti); una maggiore attivazione della corteccia cingolata anteriore (integrazione di attenzione, motivazione, controllo motorio); attivazione dell’insula (enterocezione) con implicazioni interessanti sul ruolo che anomalie nella funzionalità insulare risultano avere in numerosi disturbi psichiatrici.
L’utilizzo di ricerche longitudinali potrà aggiungere informazioni interessanti sulle applicazioni cliniche della mindfulness, che viene già utilizzata nel trattamento di diverse patologie tra le quali anche quelle di area psichiatrica.
Ora, non so cosa ne pensiate, ma credo che la moltitudine di persone che pratica la meditazione (che, ricordiamo, esiste da oltre 2.500 anni anche se ancora non veniva chiamata mindfulness e non era soggetta a tentativi di standardizzazione) non sia particolarmente interessata a valutarne la portata scientifica: godono dei benefici, quali che essi siano, in termini di qualità della vita, e questo pare sufficiente.
Vorrei terminare con una citazione del Dalai Lama che, con la consueta ironia, concede agli scienziati occidentali (con cui ha un dialogo aperto) la facoltà di dimostrare scientificamente l’inefficacia della psicologia buddhista, nel tal caso smetteremo di insegnarla.
Quindi, che ne dite di spegnere il pc, e provare a sperimentare di persona?
Se volete ci sono le mie tracce audio sull’album Sediamo Assieme alla pagina facebook dedicata.