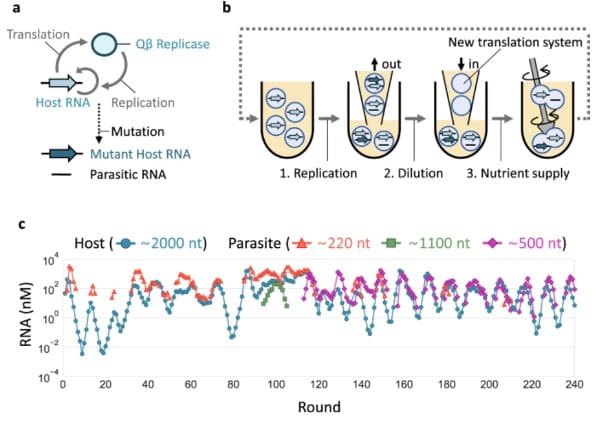Il disagio giovanile contemporaneo: NEET e Hikikomori
La gioventù contemporanea si trova ad affrontare pressioni sociali ed economiche estranee alle generazioni precedenti: Hikikomori e NEET sono l’esempio di come l’oppressione sociale e le difficoltà occupazionali possano condurre i giovani a vivere condizioni di disagio.
Sempre più spesso non ci si rende conto di come la gioventù contemporanea sia costretta ad affrontare una serie di pressioni sociali ed economiche estranee alle generazioni precedenti. La percezione di dover essere quanto più produttivi ed efficienti possibili per entrare nel mondo del lavoro, può aumentare una sensazione di ansietà tale da condurre ad un immobilismo sociale. Hikikomori e NEET sono l’esempio di come l’oppressione sociale e le difficoltà occupazionali possano condurre i giovani a vivere condizioni di disagio.
Introduzione
La cultura occidentale ha sempre sperato in una storia dell’umanità che andasse inevitabilmente progredendo: la tecnologia e le scienze continuano inesorabilmente a migliorarsi e ad accrescere il bagaglio di conoscenze attraverso nuove scoperte. Nonostante ciò, però, queste conoscenze sono incapaci di sopprimere la sofferenza umana, alimentando la tristezza e il pessimismo. Viviamo in un eterno paradosso: mentre le tecnoscienze progrediscono nella conoscenza del reale, continuiamo a essere incapaci di superare le nostre incapacità e i problemi che ci minacciano, a causa di un progresso che non è completamente in grado di darci felicità. Il sentimento di incertezza che caratterizza la società contemporanea, vessata da tensioni geopolitiche o crisi economiche, non ha fatto quindi altro che rendere il futuro imprevedibile e noi persone succubi di un’impotenza assoluta (Benasayag & Schmit, 2003).
Il fenomeno NEET
Il mondo del lavoro attuale è sempre più competitivo e richiede sempre più certificazioni e competenze. Coloro che non hanno questi attributi di “capitale umano”, ritenuto importante dai datori di lavoro, affrontano difficoltà non solo per trovare lavoro, ma nel sostenere qualsiasi tipo di carriera soddisfacente. Tale polarizzazione tra “chi ha” e “chi non ha” in termini di capitale umano, aumenta l’esclusione sociale di una sempre più sostanziale minoranza di persone.
In questa situazione già di per sé difficile, in cui è richiesta anche una sempre maggiore esperienza sul campo prima dell’assunzione, vivere una condizione di NEET (“Not in Employment, Education or Training” cioè giovani che non sono impegnati in attività lavorative, educative o formative) non fa che aggravare una storia di fallimento educativo, riducendo ulteriormente le prospettive di occupazione o di acquisizione di capitale umano attraverso l’istruzione o la formazione. In questo senso l’esperienza NEET può diventare una situazione stazionaria cronica che può aumentare gradualmente la difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro o la possibilità di esclusione sociale (Bynner & Parson, 2002).
I percorsi di carriera sono più individualizzati e meno prevedibili e potenzialmente mettono più responsabilità sui giovani per trovare la propria strada. Tre fattori contemporanei hanno intensificato le preoccupazioni perenni sui giovani NEET: la crisi del 2008 e il successivo aumento di disoccupazione giovanile; la precarizzazione del lavoro; lo svantaggio economico-lavorativo più duraturo con un conseguente impatto dannoso sulla salute mentale (Robertson, 2018).
Sono infatti presenti condizioni in cui giovani NEET si ritrovano ad affrontare una serie di stati psicologici negativi, incluse l’insoddisfazione per la vita e una perdita del senso di controllo su questa, con implicazioni anche sul piano identitario: tali difficoltà psicologiche, che spaziano da una mancanza di benessere psicologico a una sensazione di ansietà e malessere, raramente vengono riconosciute, con una conseguente negazione della loro esistenza (Bynner & Parson, 2002).
Nel 2020 in Italia abbiamo assistito ad un aumento della percentuale di NEET, raggiungendo il 23,3% (+1,1% rispetto al 2019). Il trend risulta essere accentuato al Sud, con una media di NEET del 32,6% nella fascia 15-29 anni, e colpisce maggiormente le donne a livello nazionale con una media che aumenta all’aumentare dell’età, arrivando a superare il 60% nella fascia 30-34 anni (IlSole24Ore, 2022).
Questo a testimonianza di come i giovani NEET rimangano una preoccupazione per i governi e l’obiettivo per gli interventi di politica attiva del mercato del lavoro. In Italia, per esempio, è stato a tal proposito introdotto il “Piano Neet 2022” (Dipartimento per le politiche giovanili, 2022) anche se la mancanza di chiarezza sulla loro natura può ostacolare l’efficace targeting delle politiche pubbliche (Robertson, 2018).
Fattori psico-sociali e individuali negli Hikikomori
La frequente situazione di incertezza che caratterizza la società contemporanea, è constatabile anche dall’analisi del fenomeno degli Hikikomori. Esploso negli anni ’80 in Giappone, nonostante un iniziale tentativo di ignorare la questione, il governo si sentì costretto ad avviare uno studio che potesse riconoscerli ufficialmente.
Una prima definizione di Hikikomori venne offerta nel 2003 quando il Ministero della Salute giapponese pubblicò lo studio, indicando i criteri secondo i quali questi soggetti erano in casa da almeno 6 mesi, non avevano relazioni intime se non con i familiari e il ritiro sociale doveva essere da qualsiasi attività sociale e non associato a disturbi psicotici (Saito, 2007).
Studi successivi hanno evidenziato come la sfiducia nelle persone o l’incapacità di fidarsi siano un tratto caratteristico di questi soggetti. Senza fiducia, i pazienti tendono a sentirsi insicuri o non protetti e sopprimono sentimenti o pensieri autentici nelle relazioni interpersonali per paura del rifiuto o di ricevere critiche. Hattori (2008) collegò tutto ciò alla possibilità che queste persone potessero aver subito un trauma emotivo per l’inibizione di un Sé autentico finalizzato ad assumere un ruolo adattivo in famiglie disfunzionali: ciò significherebbe aver ignorato i propri autentici sentimenti e pensieri in cambio delle cure genitoriali, ricoprendo un ruolo accondiscendente con genitori violenti o di caregiver di genitori bisognosi. La loro incapacità di fidarsi o di sentirsi al sicuro potrebbe essere quindi legata al senso di sfiducia verso i genitori, che ha creato una condizione di abbandono emotivo; questo renderebbe a sua volta difficile un intervento terapeutico gruppale, in quanto la soppressione emotiva che i soggetti effettuerebbero non farebbe che alimentare un’identità di pura facciata.
Quando questi giovani non vengono considerati malati, sono etichettati come giovani viziati che hanno abbandonato lo spirito di gruppo e il senso del dovere. Gli Hikikomori sono differenti da altre realtà adolescenziali come i NEET o i Freeter – coloro che rifiutano un posto fisso, preferendo lavori parti-time o freelance. Negli Hikikomori il rifiuto diventa totale, come totale è il ritiro che praticano o la forma di disagio e ribellione che stanno provando e, sebbene NEET e Freeter siano realtà accettate poiché in un certo qual modo si mantiene una qualche forma di interazione o partecipazione, l’Hikikomori è visto con una disapprovazione sociale per il suo voler evitare il gruppo (Ricci, 2008).
Spesso infatti l’Hikikomori è associato a patologie con le quali non ha nulla a che fare, generando grande confusione. Questa realtà è associata a una dipendenza da internet, ma va considerato che il fenomeno esplose quando internet non era ancora parte della vita quotidiana delle persone. In questo caso non è il computer o il videogioco a impattare negativamente sulla vita del soggetto o a creare una mancanza di interesse: la perdita di senso o significato è a monte e internet va solo a colmare un vuoto. Tolto quello, il vuoto rimane. Altra informazione fuorviante è che la condizione di Hikikomori sia associabile alla depressione: sebbene ci siano sintomi depressivi, queste persone si isolano per fuggire dalla sofferenza che provano nella società. Preferiscono una condizione di isolamento alla vita sociale. Non sono nemmeno dei fobici o degli schizofrenici: stiamo parlando infatti di soggetti con una visione molto critica e negativa della società (arrivando al punto da scegliere di non farne parte) che risultano capaci di operare ragionamenti approfonditi e complessi su di sé e gli altri (Crepaldi, 2019).
Osservando la questione da un’ottica psicosociale, il comportamento di questi giovani può essere interpretato come un modo per evitare le pressioni della società, della scuola e dei genitori o la difficoltà di accesso al mercato del lavoro causata dai cambiamenti economici che penalizzano le giovani generazioni. Il comportamento degli Hikikomori sarebbe quindi un atto di ritiro dai vincoli di tempo e spazio socialmente condivisi tali da raggiungere una forma di protesta silenziosa contro la società, che li porterebbe a rinunciare al proprio status sociale (Ranieri, 2018).
Nel contesto giapponese, si è notato come famiglie troppo protettive siano diventate disfunzionali nel preparare i propri figli ad affrontare i moderni contesti sociali ed economici. In un contesto nel quale si richiede una maggiore resilienza individuale da parte dei giovani, le famiglie offrono un sempre maggiore sostentamento socio-economico ai figli a causa di una mancanza di sostegno statale per i giovani, che costringe loro a dipendere da altri fino a tarda età.
I periodi di transizione e di crescita già di per sé comportano un dover ritrovare un senso di orientamento: nel contesto di incertezza contemporaneo in cui i percorsi di vita non sono sempre così chiari, i giovani possono perdersi nel cercare di ristabilire un senso di orientamento, rischiando di ristagnare nella loro età e andare alla deriva senza superare un vero e proprio processo di crescita personale. I cambiamenti del mondo del lavoro ai quali abbiamo assistito possono essere una componente del fenomeno-hikikomori che, per assenza delle tradizionali opportunità che creano insicurezze, si ritirano dalla vita sociale ed economica per evitare l’ansia che ciò comporterebbe (Furlong, 2008).
Da un punto di vista individuale, gli Hikikomori sembrano aver vissuto periodi di mancata integrazione nel gruppo dei pari, con altrettanti episodi di bullismo che condurrebbero i soggetti a ritirarsi volontariamente per evitare l’accentuazione del senso di angoscia e irritazione. Proprio per la difficoltà ad entrare in contatto con gli altri, a causa del fallimento di reali rapporti personali, coinvolgere in una relazione terapeutica il giovane può rappresentare una vera e propria sfida. Il ritiro è dunque vissuto come un meccanismo di difesa che consente di creare uno spazio mentale (e fisico) dove poter rimanere calmi, dove l’assenza di rapporti con altri evita situazioni di allerta e dove la possibilità di creare un ambiente sul quale avere un controllo onnipotente può ridurre la frustrazione e i rischi di frammentazione dell’Io e di ansie depressive (Ranieri, 2018).
Una modalità di attaccamento genitoriale di tipo ambivalente può inoltre condurre il soggetto a difficoltà ad affrontare nuove sfide o situazioni sociali, anche a causa della loro paura di fallimento e rifiuto. Il loro essere concentrati eccessivamente sul mantenimento della vicinanza dei caregivers non li rende pronti a relazioni che vanno al di là della relazione genitore-figlio, con minori comportamenti esplorativi ed adattivi in situazioni con i pari. Questa incapacità ad entrare in contatto con i pari può essere vissuta come traumatica, specialmente se immersi in un contesto culturale collettivista (come le società orientali), per la maggiore importanza che viene assegnata all’appartenenza al gruppo (Krieg & Dickie, 2011).
L’inadempienza dei genitori all’educazione emotiva dei figli non ha fatto altro che aumentare i problemi emotivi di questa generazione. Per questo i giovani d’oggi si sentono più soli, più depressi, più rabbiosi, più impulsivi e quindi più impreparati alla vita, perché privi di quegli strumenti emotivi indispensabili per avviare comportamenti di autoconsapevolezza, autocontrollo, empatia, senza i quali non sapranno mai risolvere i conflitti (Galimberti, 2007).
La perdita dell’attaccamento sicuro si è vista anche collegata ad un’inibizione del Sé con i genitori: descrivendo la propria infanzia come oppressa, i partecipanti ad uno studio hanno dichiarato che non erano in grado di mostrare la loro vera identità ai loro genitori per paura del rifiuto. Questo comportava una mancanza di supporto o di richiesta di aiuto in momenti in cui si affrontavano angosce, traumi scolastici o altri tipi di preoccupazioni. A causa di ciò, il rapporto con i caregivers era caratterizzato da sentimenti di rabbia che, particolarmente in adolescenza, veniva sfogata con veri e propri attacchi fisici. Questi agiti, per quanto violenti, potevano però rappresentare una modalità di comunicare ai genitori un malessere che altrimenti non avrebbero colto, poiché il rapporto familiare era incentrato maggiormente sull’ossessione del tornare il prima possibile a scuola o a lavoro e non era finalizzato a comprendere la difficoltà in un modo che fosse più emotivamente disponibile (Hattori, 2008).
In base a quanto detto, l’Hikikomori sembra essere al centro di un circolo vizioso che coinvolge non solo lui in quanto membro di una famiglia, ma anche il suo rapporto con la società. Approcciarsi ad essi in un modo meno coercitivo, evitando di accusare il giovane di inoperatività, potrebbe quindi rappresentare un primo tentativo di ristabilire una comunicazione significativa affinchè possa espandere i suoi contatti prima con la famiglia e poi con la società, attraverso un graduale superamento delle difficoltà (Saito, 2014).
In Italia
Nel 2017 nasce l’associazione Hikikomori Italia: dopo una stima di circa 100.000 giovani italiani in auto-reclusione, l’associazione si è posta l’obiettivo di far aumentare la presa di coscienza del fenomeno alla popolazione nazionale, superando l’idea che questa fosse una condizione vissuta esclusivamente da giapponesi. L’associazione guarda al giovane Hikikomori non come un singolo che vive una difficoltà individuale, quanto un problema che coinvolge anche il nucleo familiare e la società alla quale appartiene. Intervenire sul singolo, quindi, non può che rivelarsi uno sforzo inconcludente in quanto si andrebbe ad agire solo su una variabile del problema (Crepaldi, 2019).
L’etichetta Hikikomori
Diversi autori considerano la condizione di Hikikomori come una sindrome psicopatologica: alcuni psichiatri attribuiscono il ritiro a categorie diagnostiche preesistenti; per altri la condizione di Hikikomori è una forma di depressione dei giorni nostri; per altri ancora, poiché non è possibile classificarla come un disturbo psichiatrico già incluso nel DSM-5 o nell’ICD-10, sarebbe necessario valutare se sia opportuno inserire questa condizione in una sindrome legata alla cultura o definirla come una nuova forma di disturbo psichiatrico (Ranieri, 2018).
Circa la necessità di etichettare qualsiasi tipo di condizione che “devii la norma”, Cipriano (2016) parla di come questa esigenza venga dal contagio del fascino nosografico, che fa correre il rischio di costruire l’identità altrui attraverso le etichette che vengono poste alle persone, senza comprendere in che modo queste vivano nel mondo. Si va così perdendo una figura medica di riferimento che non sia attenta tanto al caso che la persona porta con sé, quanto alla relazione io-tu con l’altro.
Per dirla con le parole usate da Basaglia nell’intervista di Sergio Zavoli, si deve essere interessati più al malato che alla malattia (Zavoli, 1968).