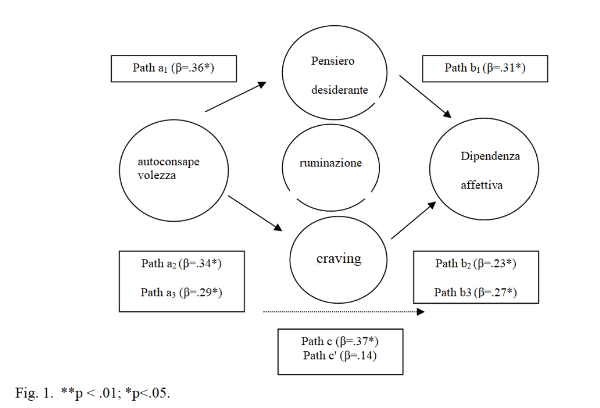La difficoltà nei rapporti interpersonali dei Disturbi di Personalità: il ruolo della fiducia negli altri e della sensibilità al rifiuto
Un disturbo di personalità viene definito come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo, pervasivo e inflessibile, con esordio nell’adolescenza o nella prima età adulta, stabile nel tempo e che determina disagio o compromissione.
In accordo con il modello alternativo dei disturbi di personalità riportato all’interno della quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (Diagnostic and Statistic Manual of Psychiatric Disorders, Fifth Edition, DSM-5, American Psychiatric Association [APA], 2013), la compromissione del funzionamento personale e interpersonale costituisce il nucleo fondante di tali patologie.
Disturbi di personalità e difficoltà nei rapporti interpersonali
I rapporti interpersonali nello specifico rivestono un ruolo critico all’interno di questi disturbi: spesso, infatti, questi pazienti esperiscono lo stabilire e il mantenere interazioni sociali come sopraffacente e tendono a gestire tali emozioni negative attraverso modalità controproducenti che possono compromettere la qualità delle loro relazioni interpersonali. Una review recentemente pubblicata su Current Psychiatry Report (Poggi et al., 2019) si concentra nello specifico sull’approfondimento delle difficoltà di questi pazienti nella messa in atto di comportamenti cooperativi, analizzando due dimensioni fondamentali per lo sviluppo di tali comportamenti: la sensibilità al rifiuto e la fiducia negli altri. La review è stata condotta compiendo inizialmente due ricerche rispetto alla letteratura sull’argomento tramite i database PsycINFO e PubMed.
Nella prima ricerca sono state utilizzate le parole chiave sensibilità al rifiuto e disturbo di personalità, mentre nella seconda ricerca fiducia e disturbo di personalità. Al termine delle ricerche sono stati selezionati solamente gli studi pubblicati negli ultimi 5 anni, con l’aggiunta di studi meno recenti nel caso in cui questi costituissero contributi di particolare rilevanza o fossero i più recenti.
Disturbi di personalità e sensibilità al rifiuto
Poggi e colleghi hanno evidenziato la presenza di un numero maggiore di studi inerenti la sensibilità al rifiuto e la fiducia negli altri per il Disturbo Borderline di Personalità e per il Disturbo Narcisistico di Personalità, in quanto tali disturbi hanno ricevuto maggiore attenzione e approfondimento nel corso degli ultimi anni da parte dei ricercatori. La sensibilità al rifiuto è una disposizione cognitivo-affettiva di processamento dell’informazione che porta l’individuo ad avere aspettative ansiose, rapida percezione e spiccata reazione emotiva rispetto alla sola possibilità di un rifiuto all’interno di relazioni interpersonali.
Una elevata sensibilità al rifiuto può portare a pattern di interazione sociale disfunzionali come eccessiva ostilità, ritiro sociale o eccessivo accomodamento degli altri. Tale dimensione risulta particolarmente critica nel Disturbo Borderline di Personalità, nel Disturbo Narcisistico di Personalità e nel Disturbo Evitante di Personalità, ma si declina in modo differente in ognuno dei disturbi.
Per quanto riguarda il Disturbo Borderline di Personalità, condizione caratterizzata da spiccata instabilità in ambito emotivo, relazionale e del controllo degli impulsi, è emersa una relazione significativa con un’elevata sensibilità al rifiuto: questi pazienti tenderebbero infatti a reagire con risposte emotive negative e comportamenti maladattivi a situazioni di esclusione effettive o percepite e, in particolare, a sentire un minore senso di appartenenza anche in condizioni in cui vengono effettivamente inclusi.
Gli individui con Disturbo Narcisistico di Personalità, caratterizzati da un pattern pervasivo di grandiosità, necessità di ammirazione e mancanza di empatia, hanno maggiori probabilità di provare emozioni negative e di reagire in modo aggressivo nel momento in cui, tramite il rifiuto sociale da parte degli altri, percepiscono minacce rivolte al sé. Per quanto riguarda il Disturbo Evitante di Personalità, caratterizzato da bassa autostima e senso di inadeguatezza, è stata evidenziata un’associazione tra scarsa autostima ed elevata sensibilità al rifiuto: la tendenza di questi pazienti a sentirsi inferiori rispetto agli altri rafforza le preoccupazioni relative a possibili esperienze sociali negative quali il rifiuto, causando ritiro sociale con funzione preventiva rispetto al rifiuto stesso.
Disturbi di personalità e fiducia
La seconda dimensione sottendente il comportamento cooperativo presa in esame nella review è la fiducia, la quale emerge da un processo di valutazione dell’affidabilità dell’altro, con un conseguente adattamento del proprio comportamento nei suoi confronti. Una valutazione disfunzionale soggetta a bias cognitivi rispetto all’affidabilità degli altri potrebbe essere una possibile causa delle difficoltà relazionali nei disturbi di personalità. La dimensione relativa alla fiducia negli altri è risultata compromessa nel Disturbo Borderline di Personalità, nel Disturbo Narcisitico di Personalità e nel Disturbo Paranoide di Personalità. Nei pazienti con Disturbo Borderline di Personalità, la presenza di esperienze precoci negative con le proprie figure di attaccamento può portare alla formazione di modelli operativi interni basati sulla sfiducia, compromettendo il loro funzionamento sociale futuro. Questi pazienti presentano infatti bias cognitivi rispetto alla valutazione di affidabilità degli altri, che risultano associati alle preoccupazioni relative alla possibilità di essere abbandonati o rifiutati tipicamente presenti nel disturbo.
Per quanto concerne il Disturbo Narcisistico di Personalità la ricerca si divide tra pazienti che presentano un narcisismo vulnerabile o un narcisismo grandioso: per i primi la sfiducia nei confronti degli altri è una delle caratteristiche che ha maggiori possibilità, di concerto alla ruminazione rabbiosa, di portare a reazioni aggressive mentre, per quanto riguarda i secondi, tali reazioni si verificherebbero solo negli individui caratterizzati anche da forte antagonismo. Infine, i pazienti con Disturbo Paranoide di Personalità, caratterizzato dalla tendenza, persistente ed ingiustificata, a percepire e interpretare le intenzioni, le parole e le azioni degli altri come malevole, umilianti o minacciose, presenterebbero una progressiva diminuzione della fiducia negli altri all’aumentare del livello di scetticismo.
Gli studi presi in esame nella review di Poggi e colleghi (2019) evidenziano che differenti disturbi di personalità sono caratterizzati da difficoltà specifiche rispetto alla sensibilità al rifiuto e alla fiducia nei confronti degli altri. Criticità rispetto a tali dimensioni risultano avere un ruolo centrale nel mantenimento delle relazioni disfunzionali nei disturbi di personalità, e necessitano quindi di ulteriori approfondimenti futuri, con l’obiettivo di portare a trattamenti specifici più mirati e informati per questi disturbi.