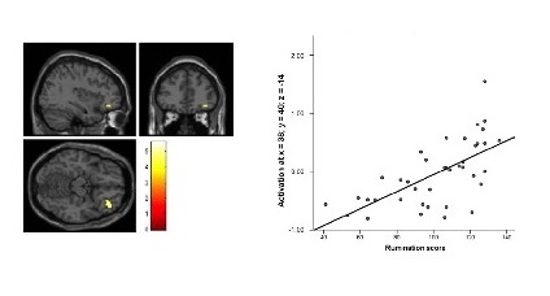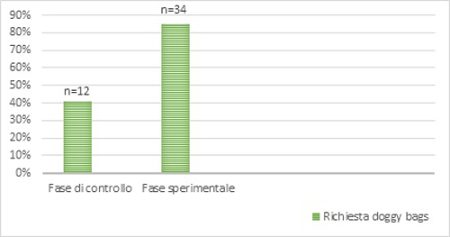ADHD negli adulti: cosa ne sappiamo oggi? Diagnosi, valutazione e trattamento di una condizione clinica largamente sottostimata
I clinici sono sempre più convinti che i sintomi dell’ ADHD possano proseguire per l’intero ciclo di vita, dall’infanzia all’età adulta (Brown, 2000). Secondo studi epidemiologici internazionali, l’ADHD colpisce tra il 3% ed il 4,5% della popolazione adulta. Inoltre non soltanto una parte dei sintomi tipici del disturbo in età infantile tendono a riproporsi, ma nuovi tratti fanno la loro comparsa e vanno a caratterizzare l’ ADHD nell’ adulto, che risulta associata ad una costellazione variegata di problemi psico-sociali (Young, Toone e Tyson, 2003).
Capolongo Manuela, Tramontano Martina, OPEN SCHOOL Studi Cognitivi Milano
Nel corso degli ultimi anni la maggior parte dei servizi di salute mentale rivolti a bambini e adolescenti ha riconosciuto l’esistenza e la necessità di trattamento rispetto ad una condizione caratterizzata da una sintomatologia poliedrica riconducibile a tre aree principali: attenzione, impulsività e iperattività. Tale quadro di difficoltà prende il nome di Disturbo da Deficit dell’Attenzione ed Iperattività (ADHD). Di conseguenza l’attenzione della maggioranza dei clinici è stata impegnata nella valutazione, diagnosi e cura di tale patologia e nell’implementazione di centri multidisciplinari in grado di aiutare tali pazienti. Su tale scia oggi, all’interno del mondo clinico, sono sorti degli interrogativi sulla presenza di tale disturbo non soltanto in età evolutiva, ma in tutto il ciclo di vita. Se la diagnosi viene formulata in età pediatrica e adolescenziale perché dovrebbe scomparire in età adulta?
Esistono molti adulti che potrebbero aver avuto la vita condizionata negativamente dall’ ADHD, ma non aver mai ricevuto una diagnosi. Come si presenta l’ ADHD nell’ adulto? Come viene effettuata la diagnosi? Quali strumenti? Quali possibili trattamenti?
L’ADHD nell’infanzia: una panoramica generale
Il disturbo da Deficit dell’Attenzione ed Iperattività (ADHD) colpisce il 3-5% dei bambini in età scolare, con un rapporto di 3 maschi per 1 femmina; esso rientra nel capitolo dei disturbi del neuro-sviluppo dell’ultima edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5, 2014) e si configura come un gruppo di disturbi con esordio infantile, caratterizzato da una compromissione funzionale a livello personale, familiare, sociale, scolastico o lavorativo. Si tratta quindi di un problema che coinvolge tutti gli ambiti di vita del bambino e che non può esimere nessuno dall’impegno per la cura, la terapia e la riabilitazione di questi pazienti, soprattutto in virtù del fatto che la prognosi favorevole del soggetto ADHD è fortemente legata alla diagnosi precoce e all’intervento qualificato della scuola e degli operatori socio-sanitari.
L’ADHD non si esprime attraverso evidenti e chiari sintomi fisici, ma si manifesta con problematiche comportamentali, che possono variare da persona a persona, in bambini dotati di un QI normale o superiore alla media. Questo è il motivo per cui il pensiero comune li etichetta come bambini “poco educati”, “senza motivazione”, o “prodotto di un ambiente familiare poco strutturato”. Anche se probabilmente un ambiente disfunzionale potrebbe comunque favorire l’espressione fenotipica di una disturbo geneticamente preordinato, non è stata trovata nessuna chiara relazione tra la vita familiare, l’ambiente e l’ADHD. Invece tale disturbo rappresenta un deficit dovuto ad un alterato sviluppo dei circuiti cerebrali che sottendono importanti funzioni cognitive; infatti, i ricercatori, hanno trovato importanti differenze tra le persone che hanno l’ADHD e quelle che non sono affette da tale patologia: le aree che governano le emozioni e la motivazione risultano essere più piccole rispetto alla popolazione generale.
L’ADHD è quindi una patologia di complessa gestione; i comportamenti maggiormente comuni sono la disattenzione, l’iperattività e l’impulsività, che concretamente si manifestano con: comportamento negativista e provocatorio; crisi di collera; frequenti litigi con i coetanei e gli adulti; incapacità a rispettare le regole; violazioni delle regole sociali; comportamenti aggressivi; tendenza a porsi in situazioni di rischio; difficoltà di adattamento sociale; scarso rendimento scolastico.
Sulla base di tali caratteristiche possiamo dedurre che i bambini affetti da ADHD faticano molto a mantenere la loro mente su attività che richiedano concentrazione focale e prolungata nel tempo, per cui si annoiano e si distraggono anche dopo pochi minuti; hanno difficoltà a focalizzare consapevolmente l’attenzione al fine di pianificare, organizzare e completare attività o imparare qualcosa di nuovo; sono iperattivi, sempre in movimento, non riescono a stare seduti a lungo; posseggono scarse capacità di controllare gli impulsi e di pensare prima di agire; non tollerano la frustrazione, l’attesa prima di ottenere ciò che desiderano e non sanno rispettare i turni sia nei giochi che in una conversazione.
Per poter effettuare diagnosi di ADHD, però tale modello di comportamento deve essere confrontato con un insieme di caratteristiche proprie del disturbo, espresse in principi contenuti nel Manuale diagnostico dei disturbi mentali di riferimento chiamato il DSM, quello americano, (IV edizione) o ICD (edizione X) quello europeo. Inoltre bisogna fare attenzione, perchè spesso i comportamenti tipici dell’ADHD possono essere il risultato di altre situazioni o condizioni morbose. Infatti una delle difficoltà nel diagnosticare l’ADHD, è che spesso essa è accompagnata ad altri problemi e/o disturbi specifici: circa due terzi dei giovani con ADHD sono affetti da comorbilità, tra cui disturbi della condotta, tic, syndrome di Tourette, disturbi dello spettro autistico, ansia, depressione e difficoltà dell’apprendimento.
Anche se la maggior parte dei pazienti non supera l’ADHD con la crescita, mediante un’ottimale combinazione tra farmaci, psicoterapia, training e supporto emozionale essi possono sviluppare modalità di controllo dell’attenzione e dell’impulsività, minimizzando i comportamenti disgreganti. Nello specifico, crescendo, con un appropriato aiuto da parte dei genitori e dei clinici, i bambini con ADHD diventano maggiormente capaci di reprimere l’iperattività e incanalarla in comportamenti maggiormente accettabili socialmente.
L’ ADHD nell’ adulto: sintomatologia, diagnosi e problematiche
I clinici sono sempre più convinti che i sintomi dell’ ADHD possano proseguire per l’intero ciclo di vita, dall’infanzia all’età adulta (Brown, 2000). Secondo studi epidemiologici internazionali, l’ADHD colpisce tra il 3% ed il 4,5% della popolazione adulta. Inoltre non soltanto una parte dei sintomi tipici del disturbo in età infantile tendono a riproporsi, ma nuovi tratti fanno la loro comparsa e vanno a caratterizzare l’ADHD nell’adulto, che risulta associata ad una costellazione variegata di problemi psico-sociali (Young, Toone e Tyson, 2003).
Il quadro clinico si caratterizza in una variegata serie di problematiche che limitano la maggioranza delle aree di vita di questi soggetti. Nel dettaglio le caratteristiche che più frequentemente si presentano nell’adulto sono:
– disattenzione cronica esplicabile in diverse forme (distraibilità, scarsa capacità nel prestare e mantenere a lungo l’attenzione e nel portare a termine i compiti affidati, propensione ad evitare impegni che richiedono uno sforzo mentale protratto nel tempo, incapacità di mettere a fuoco la tematica principale, dimenticanze ecc..);
– impulsività comportamentale e verbale (agitazione, difficoltà a stare seduto, fare le cose senza pensare alle conseguenze, non rispettare i turni di parola all’interno di un dialogo, essere logorroici ecc…);
– disorganizzazione (caos e casualità nella pianificazione di pensiero e azione);
– scarse capacità sociali e di mentalizzazione;
– sensazione di noia e difficoltà ad essere soddisfatti con lo svolgimento del proprio lavoro o di altri aspetti della vita quotidiana;
– frustrazione immediata di fronte a circostanze di ritardo;
– labilità emotiva.
In aggiunta a tali caratteristiche sintomatologiche è stato visto che se un individuo ha convissuto con l’ ADHD per la maggior parte della sua vita senza mai essere diagnosticato, potrà aver sviluppato altre forme di disagio: una storia di scarso rendimento scolastico, un eccesso di separazioni e divorzi, maggiori probabilità di difficoltà lavorative, sfavorevoli condizioni socioeconomiche, maggior rischio di andare incontro sia ad incidenti stradali che ad eventi traumatici in genere. Inoltre gli adulti che presentano questa patologia lamentano un eccesso di condotte suicidarie e tassi particolarmente elevati di comorbidità con altri disturbi della sfera mentale ed emotiva. Particolarmente problematica è l’associazione dell’ ADHD nell’ adulto con i disturbi della dipendenza da alcol e sostanze. Proprio l’uso di sostanze è largamente corresponsabile dell’ aumentata probabilità di commettere reati di vario genere e di conseguenza di andare incontro a problemi giudiziari.
L’analisi del quadro clinico appena descritto mette in evidenza la difficoltà nel riconoscere e diagnosticare l’ ADHD nell’adulto. Come ogni “nuova” diagnosi è affrontata con incertezza sia dai professionisti che dal pubblico e rappresenta un compito delicato, perchè si configura come una diagnosi “non pulita” data la vasta sovrapposizione con altri problemi e disturbi di cui abbiamo già discusso.
La competenza diagnostica è dello psichiatra. Lo psicologo può effettuare tutta la valutazione con la supervisione dello psichiatra che grazie alla sua esperienza con le patologie mentali può distinguere l’ADHD dagli altri disturbi e fare anche una corretta diagnosi differenziale.
L’ ADHD nell’adulto: valutazione e trattamento
La valutazione della presenza dell’ ADHD nell’ adulto è un processo sistematico, che ha lo scopo di evidenziare la durata dei sintomi e il livello di invalidità che causano alla persona.
Secondo la dichiarazione del consenso europeo sulla diagnosi e trattamento dell’ ADHD nell’ adulto, questo processo valutativo deve individuare una molteplicità di elementi e non limitarsi ad una singola impressione clinica.
Gli elementi di interesse diagnostico consistono nell’esordio infantile del disturbo, i sintomi presenti nell’età adulta e la presenza di invalidità in almeno due campi di vita, tra cui la famiglia, la scuola, il lavoro e le relazioni interpersonali.
E’ necessario evidenziare anche le caratteristiche associate al disturbo come la labilità dell’umore, scoppi di rabbia e collera e i disturbi da comorbilità.
Infatti è davvero fondamentale focalizzarsi sulla diagnosi differenziale, in quanto i sintomi che spesso coesistono con la sindrome di ADHD nell’ adulto, come instabilità dell’umore, incessante attività mentale e tendenza ad evitare situazioni di attesa se esse generano frustrazione, possono essere confusi con quelli di una comorbilità separata, come l’umore, l’ansia, disturbi psicotici, organici, da sostanze, disturbi di personalità, tic e disturbi da autismo.
Gli aspetti che mostrano spesso gli adulti con ADHD, per esempio la bassa autostima, cattivo umore, labilità emotiva ed irritabilità, possono essere sovrapposti alla distimia, ciclotimia, disturbo bipolare e disturbo di personalità borderline, quindi il rischio è quello di far confusione fra i disturbi.
Altri elementi importanti ai fini della valutazione diagnostica sono l’anamnesi dei trattamenti somatici e psichiatrici e la storia familiare dei disturbi psichiatrici e neurologici, vista l’ereditarietà del disturbo.
Uno degli strumenti per condurre la valutazione diagnostica dell’ ADHD nell’adulto è il colloquio clinico, nel quale le aree da indagare sono le seguenti: il matrimonio, rapporti interpersonali, funzionamento sessuale, funzionamento lavorativo, attività quotidiane, genitorialità, maneggiamento economico ed eventuali problemi legali.
La scala di classificazione generalmente usata per lo screening comprende, oltre alla scala riferita ai criteri dettati dal DSM-5, le voci della World Health Organisation Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) Symtom Checklist (2005).
Sono a disposizione per la raccolta delle informazioni significative delle interviste diagnostiche strutturate, come la Conners Adult ADHD Diagnostic Interview (CAA – DID, 1994, 1998), e quella più recente la DIVA, ossia la Diagnostic Interview for ADHD in Adults (2007).
La prima è un’intervista strutturata a supporto della diagnosi di ADHD nell’ adulto ed è divisa in due parti: la prima parte è il questionario della storia del paziente (presentata come intervista clinica o come questionario di autocertificazione), che indaga la storia demografica del cliente, il corso dello sviluppo dei sintomi e dei problemi di attenzione e i fattori di rischio associati, includendo anche domande sulla comorbilità; la seconda parte invece, consistente nell’intervista clinica diagnostica , ha lo scopo di formulare la diagnosi clinica in base ai criteri del DSM e di raccogliere informazioni circa l’età di insorgenza, la pervasività e il livello di compromissione per ogni sintomo di ADHD indicato.
Il secondo strumento, sviluppato da J. J. S. Kooij e M. H. Francken, è la versione seguente dell’intervista Semi-Strutturata per l’ ADHD nell’ adulto: essa è divisa in tre parti, ognuna delle quali si riferisce all’infanzia/fanciullezza e all’età adulta, e comprende i criteri per il Deficit di Attenzione, i criteri per l’Iperattività/Impulsività, e infine l’età di insorgenza e il disfunzionamento causato dai sintomi. La DIVA prende in considerazioni solamente i sintomi dell’ADHD, e non include invece quei sintomi, sindromi e disturbi psichiatrici presenti in comorbilità, perciò, se si utilizza questo strumento, è necessario accompagnarlo ad una valutazione psichiatrica completa.
Un altro strumento utilizzato nella valutazione della diagnosi di ADHD nell’ adulto è la Brown ADD Scale Diagnostic Form (BADDS, 1996), che misura specificatamente i comportamenti relativi al funzionamento esecutivo e all’attenzione ed include un protocollo di raccolta della storia clinica del paziente, costituita da quaranta domande a scelta multipla, indaga la capacità di:
– Attivazione
– Sostenere l’attenzione
– Mantenimento dello sforzo
– Interferenza affettiva
– Memoria di lavoro e capacità di recuperare l’informazione.
Nel processo di valutazione sono utili anche gli strumenti self-report da somministrare ai familiari, partner e amici del paziente, in modo da ottenere una descrizione esterna del problema della persona: alcuni degli strumenti appena citati presentano versioni destinate a loro.
Importanti sono anche i test cognitivi usati nel processo di valutazione dell’ ADHD nell’ adulto:
– Cognitive Assessment System (CAS, Naglieri e Das, 1997): questo strumento si basa sulla teoria neuropsicologica PASS (Das et al., 1994), secondo la quale ci sono quattro processi cognitivi base dell’intelligenza umana, gli stessi misurati dalla strumento, ossia Pianificazione, Attenzione, Simultaneità e Successione;
– Scale Wechsler: Wisc III e IV, WAIS (Wechsler, 1949): soprattutto in riferimento all’indice di attenzione e concentrazione, e all’indice di velocità di processamento;
– Woodcock Johnson III (CHC, R. Woodcock e M. E. Johnson, 1977), di cui l’ultima versione del 2014 è chiamata WJ IV: esso è un test di abilità cognitive, basato sulla teoria di Cattel-Horn-Carrol, che si basa su nove abilità di livello, dalle quali possono essere ottenuti due indici, cioè un’Abilità Generale Intellettuale (GIA) e una Breve Abilità Intellettuale (BIA).
Per quanto riguarda il trattamento dell’ ADHD nell’ adulto, la soluzione ottimale è quella di utilizzare un approccio multimodale, ossia che unisca insieme diversi interventi diversi, in modo da rendere il trattamento stesso più efficace possibile e una prognosi più favorevole. Questo tipo di trattamento multimodale comprende:
– La farmacoterapia per i disturbi dell’ ADHD e i sintomi in comorbidità;
– Psicoeducazione sui sintomi dell’ADHD e quelli in comorbidità;
– Psicoterapia cognitivo-comportamentale.
Il trattamento farmacologico risulta fondamentale per lavorare sui sintomi nucleari dell’ADHD: il trattamento farmacologico più studiato e più efficace è quello basato sugli stimolanti (metilfenidato e dexamfetamina). Il trattamento con stimolanti ha effetti positivi sulla sintomatologia e sui comportamenti invalidanti dell’ADHD, ma migliora anche altri aspetti correlati come la bassa autostima, scoppi di rabbia, sbalzi d’umore, problemi cognitivi e rapporti familiari. Nonostante sia riconosciuta l’efficacia degli stimolanti nel trattamento di ADHD nell’ adulto, il loro ruolo è ancora controverso e studiato.
Trattamenti farmaco terapeutici di seconda linea prevedono l’atomoxetina non-stimolante, che può essere indicata per quei pazienti con disturbi in comorbidità da abuso di sostanze, disturbi emotivi o fobia sociale.
Anche la psicoeducazione è un tassello importante nel trattamento dell’ ADHD nell’ adulto, in quanto permette l’educazione del paziente ed eventualmente del partner e dei suoi familiari sui sintomi e invalidità dell’ ADHD, sulla prevalenza nei bambini ed adulti, la possibilità di comorbilità, l’ereditarietà, le disfunzioni del cervello coinvolte e le possibilità di trattamento. Il fornire al paziente queste informazioni lo può aiutare a comprendere più approfonditamente la sua condizione ed aiutarlo ad affrontare le difficoltà causate dal disturbo. Spesso la psicoeducazione ha buoni effetti anche sulle relazioni familiari, in quanto queste informazioni vengono condivise tra i membri della famiglia, e anch’essi diventano consapevoli e riescono a dare una spiegazione dei comportamenti e sintomi del paziente.
Infine è necessario anche ingaggiare il paziente in un percorso di psicoterapia cognitivo-comportamentale, dal momento che i pazienti sviluppano ulteriori problematiche a seguito del disturbo (credenze negative, bassa autostima, comportamenti di evitamento e disturbi dell’umore) e inoltre esiste un alto grado di comorbilità con i disturbi d’ansia, i disturbi dell’umore, il controllo degli impulsi e l’abuso di sostanze.
E’ stato dimostrato che la CBT è maggiormente efficace se affiancata a interventi comportamentali che mirino all’apprendimento e alla pratica di strategie compensatorie, non tralasciando l’intervento cognitivo sulle credenze disfunzionali e le emozioni che ne conseguono, che incentivano l’evitamento e la procrastinazione.
Un altro obiettivo della CBT è quello di focalizzarsi sull’autostima, problemi di ansia e abbassamento dell’umore.
Anche la DBT (DialecticL Behavior Therapy), la Terapia Metacognitiva e la Mindfulness sono risultate efficaci per il trattamento di questo tipo di pazienti.
In generale le tecniche utilizzate sono: cognitive (ristrutturazione cognitiva, problem solving, gestione della rabbia, riduzione procrastinazione, ecc…) ed emotive (gestione e regolazione delle emozioni, tecniche di controllo degli impulsi e dell’autoregolazione, aumento autostima, ecc…).
Il trattamento infine risulta efficace se tutti questi interventi sono applicati insieme in un sistema multimodale, così da fronteggiare il disturbo da diversi punti di vista ed aiutare il paziente su diversi fronti e con differenti tecniche.