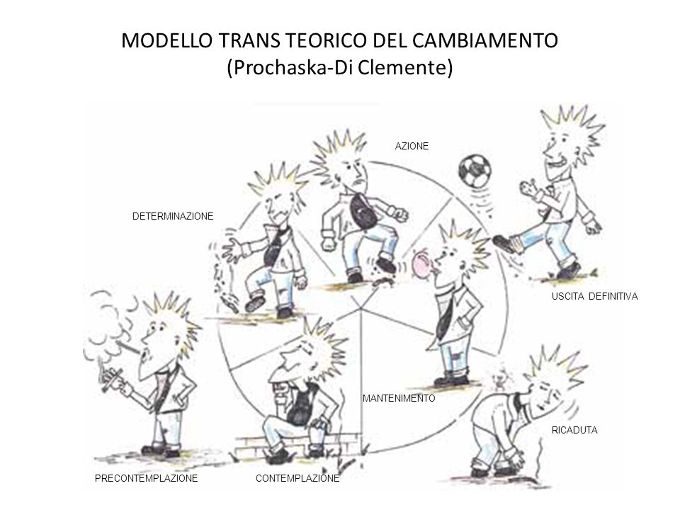Le alterazioni del tono dell’umore nel paziente afasico
L’ afasia è definibile come un disturbo della formulazione e della comprensione di messaggi linguistici, conseguente a lesioni focali cerebrali. L’ afasia provoca disturbi più o meno gravi, a seconda della grandezza della lesione, nel parlare, nel capire, nel leggere e nello scrivere.
Francesca Maria Fumagalli – OPEN SCHOOL Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Milano
…Immagina che improvvisamente tutte le persone intorno a te – le persone a te più care, gli amici, gli estranei – si mettano a parlare una lingua a te sconosciuta; non sei più in grado di capire cosa ti dicono e non riesci a far loro capire quello che dici tu. Vedi il quotidiano che leggi regolarmente da anni e ti accorgi che anche quello, pur sembrando il solito giornale, è scritto in una lingua a te ignota.
Sei spaventato, non sai cosa fare e inoltre ti rendi conto di essere in ospedale. Perché? Cosa è successo? Ti si avvicina gente ignota (apparentemente un medico, infermieri), ti fanno delle cose, ti parlano ma tu non sei in grado di chiedere, di capire cosa ti dicono. Finalmente arriva tuo figlio; ti bacia, ti guarda… e parla anche lui questa nuova lingua a te ignota!! Piano piano ti rendi conto che non è il mondo che è cambiato, sei tu a essere cambiato. (Basso Anna (n.d.) in “L’ afasia – La persona afasica e la riabilitazione”)
La comunicazione interrotta: cos’è l’ afasia?
La
comunicazione tra individui di una specie animale è fondamentale per lo scambio di informazioni necessarie alla sopravvivenza come singoli e come specie. Tuttavia, esclusivamente gli esseri umani comunicano utilizzando simboli convenzionali, arbitrari, altamente diversificati tra popolazioni ed etnie e in evoluzione costante (Vallar & Papagno, 2007). Il linguaggio ci permette quindi di parlare di cose presenti, passate o future, di cose vere o inventate, utilizzando solo alcune decine di suoni con i quali vengono formate migliaia di parole collegate tra di loro da regole grammaticali.
Un atto comunicativo in quanto tale necessita che vi sia un individuo che produce un messaggio, ossia codifica un pensiero in una forma linguistica, e un soggetto destinatario che decodifica il messaggio, comprendendone quindi il significato.
L’ afasia è definibile come “disturbo della formulazione e della comprensione di messaggi linguistici, che consegue a lesioni focali cerebrali, in persone che avevano in precedenza acquisito un uso normale del linguaggio” (Vallar & Papagno, 2007). L’ afasia provoca disturbi più o meno gravi, a seconda della grandezza della lesione, nel parlare, nel capire, nel leggere e nello scrivere.
Il deficit consegue solitamente a una lesione cerebrale nell’emisfero sinistro, coinvolgendo le diverse unità del linguaggio, sia a livello orale che scritto. Nella maggioranza dei soggetti destrimani il linguaggio è lateralizzato nell’emisfero di sinistra; una localizzazione del linguaggio a destra è rara e riguarda circa il 5% dei casi: un disturbo del linguaggio causato da una lesione cerebrale emisferica destra in soggetti destrimani è detto afasia crociata. Nel caso dei soggetti mancini, nel 60% si ha una lateralizzazione a sinistra, mentre nel restante 40% esso si trova localizzato a destra o in entrambi gli emisferi.
Inizialmente era stata proposta una dicotomia diagnostica che contrapponeva deficit in produzione ai deficit in comprensione. Essa origina dal diagramma di Wernicke e Lichtheim, contrapponente deficit di linguaggio conseguenti a lesioni temporali a quelli da lesioni frontali sinistre (Làdavas, 2012). Tale classificazione è risultata incongruente con i dati derivanti dall’osservazione clinica: produzione e comprensione del linguaggio sono solitamente compromesse in modo relativamente congruente. La dicotomia produzione/comprensione venne quindi sostituita da una differenziazione tra aspetti qualitativi della produzione orale: si parla quindi di deficit fluenti e non fluenti.
Un deficit fluente (conseguente a lesione cerebrale posteriore) è caratterizzato da eloquio abbondante, emesso senza significative difficoltà articolatorie, frasi relativamente lunghe e sintatticamente complesse ma che possono esitare in una produzione incomprensibile a causa di errori quali sostituzioni di funtori e morfemi grammaticali.
L’ afasia non fluente, conseguente a lesioni anteriori, è caratterizzata da un eloquio lento e scandito, con produzione articolatoria laboriosa, frasi brevi e frequenti omissioni di funtori e morfemi grammaticali. A tale principio diagnostico si affianca ora una descrizione dei deficit di linguaggio che tenga conto della principali componenti della linguistica descrittiva (fonologia, lessico, morfosintassi) e delle unità di elaborazione della psicolinguistica cognitiva. Molti studi ora sono in direzione di individuare con maggior dettaglio forme afasiche in cui i deficit dissociano per categoria o per classe grammaticale (Vallar & Papagno, 2007). Dal punto di vista eziologico, la maggioranza delle afasie sono su base vascolare, seguite da patologia traumatica o neoplastica.
Afasia e alterazioni del tono dell’umore
Già da tempo vi sono evidenze del fatto che alterazioni del tono dell’umore e disturbi depressivi possano considerarsi conseguenze frequenti di lesioni cerebrali sia in fase acuta che cronica, fino a 1 o 2 anni di distanza dall’onset (Robinson et al., 1983;1984;1987). Ulteriori studi individuarono una maggior presenza di alterazioni di natura depressiva in seguito a lesioni dell’emisfero sinistro (Robinson et al., 1984). Per primo Gainotti (1972) osservò difatti che pazienti affetti da lesioni cerebrali sinistra manifestavano reazioni emozionali di tipo “catastrofico” ai fallimenti rispetto ai test cognitivi o sintomatologia ansioso-depressiva.
Herrmann e colleghi (1993) in un campione di soggetti afasici a seguito di ictus cerebrale, individuarono differenze significative nel profilo dei sintomi depressivi: i soggetti con afasia in fase acuta riportavano punteggi superiori per quanto riguardava gli indicatori fisici di depressione, mentre i soggetti con afasia in fase cronica sentivano con maggior peso le alterazioni delle funzioni cicliche.
Negli ultimi decenni la ricerca sta orientando la propria attenzione allo studio delle alterazioni del tono dell’umore a seguito di eventi neurologici acuti come l’ictus, sia per la comprensione dei meccanismi sottostanti sia con finalità riabilitativa (Herrmann, Bartels & Wallesch, 1993). Tuttavia, l’utilizzo di strumenti di misura e indicatori di patologia mutati dagli studi sulle patologie psichiatriche ha reso spesso i risultati molto eterogenei e poco generalizzabili. È difatti discutibile la proposta di valutare in maniera valida e affidabile pazienti con importanti deficit linguistici utilizzando scale o procedure di valutazione standard che si basino su di una intensa comunicazione verbale. Alterazioni del tono dell’umore, stati depressivi o sintomatologia ansiosa sono frequenti conseguenze di patologie quali stroke. Le persone con afasia sono escluse tipicamente dagli studi sulle conseguenze psicologiche della patologia neurologica, ciò a causa della loro difficoltà nel rispondere a scale self-report indaganti il tono dell’umore o interviste cliniche strutturate (Hilari et al., 2010).
La qualità della vita è fortemente correlata allo stato di salute: si parla di health-related quality of life (HRQL), intesa come percezione e soddisfazione di un individuo relativamente al proprio funzionamento fisico, mentale, emotivo e sociale (Berzon et al., 1993). L’intervento riabilitativo post ictus ha infatti tra i vari obiettivi lo scopo generale di migliorare il senso di benessere percepito e di qualità di vita (Party, 2012). La capacità di comunicare è quindi fondamentale non solo per il processo di riabilitazione ma anche in vista del reinserimento del soggetto nella propria comunità (Rombough et al., 2006).
Nonostante le difficoltà di inserimento in studi clinici sulle alterazioni del tono dell’umore, soggetti affetti da afasia risultano inseribili in tali studi utilizzando metodologie adattate quali osservazione clinica, uso di informatori esterne, misure basate su informazioni visive (Hilari et al., 2010).
La scala Stroke and Aphasia Quality Of Life scale (SAQOL-39g) è stata adattata per l’utilizzo con soggetti affetti da afasia, con risultati forti in termini di affidabilità, validità e sensibilità (Diaz et al., 2013; Caute at al., 2012). Comprende 39 item che coprono sottodomini fisici, psicosociali e di comunicazione.
In particolare, i risultati di alcuni lavori hanno dimostrato che la capacità di comunicare in maniera funzionale e, in misura minore, le abilità linguistiche generali sono implicati e influenzano la qualità di vita percepita dal soggetto afasico e la partecipazione ad attività sociali e di comunità (Cruice et al., 2003).
Un ulteriore strumento utile è la Visual Analogue Scales (VASs), una misura a single-item verosimilmente poco adatto all’indagine di costrutti complessi quali la qualità di vita, ma che si adegua per semplicità a particolari situazioni, per esempio con soggetti con grave compromissione cognitiva o afasia (Hilari & Boreham, 2013).
In uno lavoro osservazionale prospettico (longitudinale) del 2010 Hilari e collaboratori hanno studiato i fattori predittivi di distress nei primi sei mesi dopo l’ictus in un campione comprendente soggetti afasici. Come elementi di allarme hanno individuato la gravità dell’ictus alla baseline, il basso sostegno sociale a tre mesi; la solitudine e la scarsa soddisfazione nelle relazioni sociali a sei anni mesi. Nonostante la presenza di afasia non poteva essere considerata predittore di disagio, a tre mesi dall’evento acuto il 93% dei soggetti con afasia sperimentava significativo distress rispetto al 50% dei soggetti con ictus e senza afasia. Gli autori hanno concluso quindi che, nonostante i fattori che contribuiscono al distress psicologico dopo l’ictus varino nel tempo, solitudine e scarsa soddisfazione rispetto al contesto sociale risultano particolarmente importanti, contribuendo al mantenimento di disturbi psicologici a lungo termine (Hilari et al., 2010).
Un lavoro del 2000 di Kauhanen e collaboratori individua tra le singole complicanze neurologiche dell’ictus, l’ afasia come un importante fattore predittivo di depressione: nello studio il 70% dei pazienti afasici soddisfaceva infatti i criteri diagnostici del DSM-III-R per la depressione a 3 mesi e il 62% a 12 mesi dallo stroke; la prevalenza della depressione maggiore aumentava inoltre dall’11 al 33% durante il periodo di follow-up di 12 mesi.
Inoltre, le persone con afasia spesso riferiscono di sentirsi ansiosi quando usano il linguaggio durante la comunicazione (Cahana-Amitay et al., 2011). Gli autori sostengono difatti che, qualora le persone con afasia sperimentassero l’uso del linguaggio come un evento stressante, con effetto cumulativo tale da determinare uno stato ansioso, potrebbero esperire l’uso della lingua come una minaccia, con conseguenze comportamentali e fisiologiche nelle situazioni in cui sono tenuti a parlare fino a veri evitamenti. È come se si potesse parlare di uno stato emotivo di linguistic anxiety o ansia linguistica. In particolare, una persona con ansia linguistica presenterebbe ansia anticipatoria rispetto all’errore e paura del fallimento che diventano fattori di minaccia alla produzione linguistica.
Misurare le risposte fisiologiche di stress in questi soggetti (ad esempio la pressione arteriosa) potrebbe offrire una modalità di determinazione della misura in cui l’ansia deve essere regolata in un determinato paziente, e quindi consentire al riabilitatore di “tagliare” un intervento terapeutico “su misura” delle particolari esigenze del singolo soggetto.
Comprendere pertanto l’impatto delle sequele emotive dell’ictus nelle persone con afasia continua a rappresentare una sfida e al tempo stesso una risorsa che faciliterebbe la terapia e riabilitazione (Code, 2003; Damico et al., 2010).