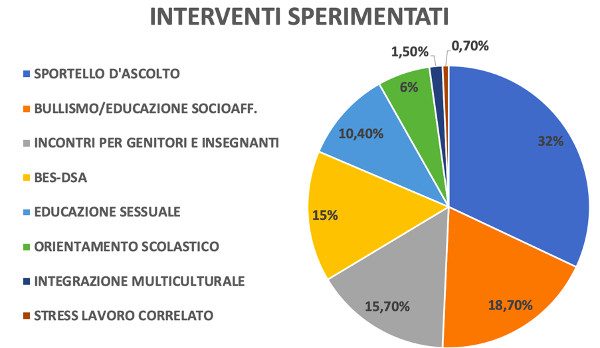La gelosia e il famigliare nel 1700 – Dal corpo famigliare all’anima famigliare
Nel 1700, con l’avvento dell’Illuminismo, si stabilisce la marcata tendenza a razionalizzare le emozioni e i sentimenti e ad attribuire alla ragione un ruolo centrale nella vita interiore dell’uomo. Durante il romanticismo, invece, si assiste a un’inversione di rotta e l’amore diventa il simbolo che può determinare e segnare un’intera esistenza.
Durante tutto il ‘700 il romanzo che tratta di
famiglia, di
amori o di passioni è tutti intriso della vittoria dell’ethos sul pathos. Entriamo nell’era dell’illuminismo per cui le
emozioni, il profondo, i sentimenti devono essere guidati dalla razionalità. La fiducia nella scienza tipica di questo movimento filosofico, porta a distinguere tra la mente dell’uomo e l’universo degli oggetti. Compito dell’uomo è dominare, attraverso la mente, gli oggetti tra cui sono comprese le emozioni. Kant, nella sua risposta alla domanda “che cos’è l’Illuminismo?” dà questa definizione:
L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stessa è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell’Illuminismo.
Sapere aude significa intraprendere una battaglia contro il pregiudizio, il mito, la superstizione, e contro tutte le forze che hanno ostacolato il libero uso dell’intelletto e della crescita mentale dei vari individui. Tra gli elementi ostacolatori vi sono le emozioni che debbono trovare una giusta sistemazione (razionalizzazione) all’interno della ragione. Esse debbono essere controllate.
Il compito principale che si diedero gli illuministi era quello di educare.
Madame de Lambert su questa scia si prese il compito di educare le donne verso l’emancipazione. In Riflessioni sulle Donne pubblicato nel 1727 scrive:
Tanta è la tirannia degli uomini! Loro vogliono che noi non facciamo uso della nostra intelligenza né dei nostri sentimenti, hanno solo un grande interesse a richiamarci ai nostri primordiali compiti. Le donne possono dire agli uomini: “Che diritto avete voi di privarci dello studio delle scienze e delle belle arti? Le donne che si sono dedicate a tali studi, non hanno forse raggiunto risultati più che buoni?”.
Madame de Lambert punta a dare un’istruzione mentale alle donne in modo che possano autodeterminarsi. L’autodeterminazione, così come avviene per gli uomini, deve passare attraverso l’educazione a controllare le proprie emozioni.
Emblematica è la posizione in cui si viene a trovare Giulia nella Nouvelle Heloise di Jean Jacques Rousseau. Il marito Wolmar invita a casa loro Saint-Preux, l’istitutore di cui da sempre Giulia è innamorata, in modo che la moglie possa sperimentare che la virtù può dare pace, felicità e serenità più della passione. Solo nell’atto di morte, avvenuta per salvare la figlia che era caduta nelle acque gelide di un fiume, Giulia confessa, attraverso una lettera, il suo amore, mai cessato, a Saint-Preux.
Rousseau esalta i principi etici del matrimonio e, soprattutto, che i sentimenti possono essere razionalizzati. Vorrei sottolineare la scommessa del marito che può essere concepita come un “dono” in cui nutre la fiducia e la speranza di poter essere ricambiato, così come in effetti avviene. Wolmar razionalizza la sua gelosia trasformandola in un dono. Ciò dimostra che la razionalizzazione non sia di per sé negativa, ma anzi se prendiamo coscienza dei sentimenti negativi possiamo trasformare, far rinascere la relazione.
L’esaltazione dei principi etici la troviamo anche nella Pamela di Richardson. Di Pamela, serva bellissima, si invaghisce il suo datore di lavoro, Mr. B, il quale tenta in tutti i modi di sedurla anche attraverso castighi. La ragazza non cede neanche di fronte ai tentativi di stuprala. Visto che con le cattive maniere non riusciva a farla cedere ed ammirato dalle sue virtù, inizia a corteggiarla intensamente facendo così innamorare Pamela. Anche in questo caso la presa di coscienza comporta una elaborazione che trasforma la relazione.
Le relazioni possono rinascere all’interno di una razionalizzazione dei propri sentimenti.
Anche nella pittura di famiglia, come riportato da Cigoli, prevale l’idea illuministica e la famiglia viene rappresentata nella sua intimità. Il fatto nuovo rispetto ai quadri di famiglia del secolo precedente è l’introduzione della “conversazione” come elemento educativo. Spesso, inoltre, i personaggi vengono ritratti nella pratica delle arti. Un esempio è La famiglia Morzat di Johann Nepomuk della Croce, in cui i fratelli Mozart suonano a quattro mani il clavicembalo con il padre Leopold appoggiato sullo strumento. Il padre ammira la maestria dei figli e, in qualche modo, si compiace della famiglia che è riuscito a tirare su. E’ l’ideale della borghesia che compare sulla scena in contrapposizione ai dipinti della famiglia aristocratica del ‘600. Un altro elemento che compare nel dipinto appeso alla parete è il ritratto della mamma morta a cui il padre è legato, come vedremo in seguito, da un amore eterno.
Il romanzo che mette in crisi i valori ideali dell’illuminismo è Storia del Cavaliere Des Grieux e di Mannon Lescaut di Prévost, in cui la protagonista muore per non essere riuscita a razionalizzare i propri sentimenti, per non aver fatto il proprio dovere. Mannon, nel tentativo di vivere sempre nell’agiatezza, abbandona più volte Des Grieux nel momento in cui quest’ultimo cade in miseria per aver tentato di accontentare le esose richieste dell’amata. Ad ogni fuga corrisponde sempre un incontro tra i due amanti, fino a quando, nel tentativo di truffare Geronte, vengono arrestati con l’accusa di furto e adulterio. Mannon viene espatriata negli Stati Uniti e Des Grieux la segue. Dopo un periodo in cui vivono in pace sono costretti a scappare e durante la fuga Manon muore.
In Manon Lescault ritorna il tema della morte come interruzione, ma anche rinascita dei legami. Vero è che con la morte si interrompe quella che viene considerata una esistenza sconsiderata, ma è altrettanto vero che Manon vive sulla propria pelle il dilemma tra emozioni, sentimenti e razionalità. Le emozioni possono essere ingabbiate all’interno della ragione? La storia di Manon sembra dirci di no.
La morte, inoltre, rende eterno l’amore. Sartre in proposito scrive:
Essendo morta la sua vita, solo la memoria dell’altro può impedire che si avvizzisca tagliando tutti i suoi ormeggi col presente. La caratteristica di una vita morta è di essere una vita di cui l’altro diventa il guardiano.
Si diventa guardiani dell’amore secondo Galimberti. Infatti, analizzando l’angoscia di morte, sostiene che quest’ultima
non riguarda propriamente la morte, ma la perdita degli amori di cui si è nutrita la sua vita …… proprio perché la morte è così incatenata, intrecciata e inanellata all’amore, questo non si estingue con la morte della persona amata.
La morte rinnova il legame in quanto lo rende trasmissibile come afferma E. Severino
La presenza è sempre, e non coincide con l’apparire e lo sparire.
Anzi la morte, essendo un tempo indefinito rispetto alla vita, permettendo la trasmissibilità e l’eredità, rende il legame eterno. Sempre Galimberti arriva a sostenere che
Non è la morte a estinguere l’amore, ma la nostra rimozione che vuol dimenticare tutto ciò che quell’amore in noi ha generato, affidandosi a quel malfamato luogo comune, secondo il quale il tempo porta rimedio. Nel tempo c’è solo infedeltà. Solo nell’amore c’è eternità.
Foscolo, nei Sepolcri, sostiene che soltanto il sentimento, la “corrispondenza d’amori sensi”, sia in grado di garantire all’uomo l’immortalità, attraverso il ricordo dei suoi simili. Ancora una volta la morte tramite la generatività rinnova e rafforza il legame.
I terapeuti che si occupano di elaborazione del lutto conoscono bene la forza del legame, sia in senso positivo che negativo, che lega i vivi con i morti e la grande forza di questo tipo di legame che sembra inscindibile e non rielaborabile. Freud, nel tentativo di consolare l’amico Binswanger per la perdita del figlio maggiore, scrive:
E’ noto che il cordoglio acuto dopo una tale perdita passerà, ma si resta inconsolabili, non si troverà mai un compenso. Tutto ciò che può subentrare, anche se riempisse il posto rimasto vuoto, resta qualcosa di diverso. E, a dire il vero, è giusto che sia così. E’ l’unico modo per proseguire nell’amore da cui non si vuol desistere.
Il posto vuoto trova spazio, così come riportato da Cigoli, anche nella rappresentazione pittorica della famiglia. Nel ritratto di famiglia di Wybrand Hendrik – Jacob Freitama e Elisabeth de Haan – davanti alla coppia c’è una sedia in cui sono deposti dei fiori. E’ la sedia vuota della figlia che, “rifiutando il contratto matrimoniale previsto dalla famiglia e degno del suo rango”, decide di sposarsi con un ufficiale della marina inglese. Sempre Cigoli analizza un’altra opera, esposta allo Staatliche Museen di Berlino, George Clive e la Famiglia con Serva Indiana di Joshua Reynoldys, in cui il tema del lutto generazionale è rappresentato nello sguardo del capofamiglia che guarda al di là della rappresentazione della famiglia. Il suo sguardo sembra ricercare nel vuoto la figlia morta.
Il tema della morte tende a sottolineare le difficoltà in cui si sono trovati gli illuministi di fronte alla razionalizzazione dei sentimenti. Il tema della gelosia, affidandosi solo ai temi etici della relazione è totalmente scomparsa. Anzi, esso è trattato solo come razionalizzazione, come descritto da Rosseau attraverso il personaggio di Wolmar.
L’amore e i sentimenti riprendono a diventare il nodo centrale dell’esistenza umana con i pre romantici. Così scrive Werther all’amico Guglielmo nei Dolori del Giovane Wherter di Goethe:
Wilhelm, cosa è mai il nostro cuore, il mondo senza l’amore? È come una lanterna magica senza luce! Ma appena tu vi introduci la lampada, le più belle immagini compaiono sulla parete bianca…
Se per gli illuministi l’amore è una categoria spirituale che non può essere indagata e conosciuta, per i romantici diventa il simbolo che può determinare e segnare un’intera esistenza. E’ l’incontro segreto in cui solo la persona oggetto del nostro amore può comprendere il nostro cuore e la nostra anima. Nole, sebbene non potesse ricambiare i sentimenti di Werther in quanto promessa sposa di Alfred, offre al giovane protagonista la possibilità di trasformare il loro rapporto in un’autentica amicizia, una sorta di amore platonico.
Per amore si può scegliere di morire: il giovane Werther, una volta persa la speranza di poter conquistare Nole, si suicida sparandosi alla testa con le pistole del marito della sua amata. Lo stesso fa Jacopo, per amore di Teresa, nelle Ultime Lettere di Jacopo Ortis di Foscolo, uccidendosi con un colpo di pugnale al petto. Anche in questo caso l’amore per una donna che si era promessa sposa ad un altro, porta al suicidio.
Il suicidio si lega indissolubilmente con l’idea della morte. Se la morte rende i legami eterni, il suicidio, di conseguenza, sarebbe l’estremo tentativo per trasportare il legame all’interno di un tempo indefinito come l’eternità. Sia Werther che Jacopo, una volta appurato che non si possono legare per motivi etici con Nole e Teresa, offrono in dono la loro vita in modo da rendere eterno l’amore.
Offrire la propria vita per amore, per gli altri, è un legarsi per sempre, per l’eternità. Gesù, con la morte in croce, offre la sua vita per tutti gli uomini stabilendo un legame che non può essere rotto. Per i cristiani, la morte di Gesù viene considerata un gesto d’immenso amore. I vangeli raccontano che, durante la passione, la domanda e lo sberleffo più frequente per Gesù era
“se sei veramente figlio di Dio, salva te stesso”. Ma proprio perché era figlio di Dio offriva la sua vita per stabilire un legame eterno con gli uomini.
Molti nel corso della storia hanno offerto la loro vita per la patria, per salvare un amico, per inseguire i propri ideali. I fondamentalisti islamici offrono la loro vita per la vittoria di Allah sugli infedeli diventando una potente arma.
Eppure “offrire la vita” non assume lo stesso significato rispetto alle modalità con cui questa offerta viene portata avanti, a seconda se si è uccisi o ci si uccide. Nel primo caso si diventa eroi e meritevoli del paradiso: Ettore sfida l’invincibile Achille nel tentativo di salvare la propria patria. Nel secondo si rischia di finire tra gli sfortunati della vita, così come li sistema Virgilio nel libro VI dell’Eneide. Sono accanto, nei campi lugentes (campi del pianto), a chi è più meritevole della pietà, ai bambini, a coloro che sono stati ingiustamente giustiziati, agli infelici che sono morti per amore come Didone regina di Cartagine.
“Offrire la vita” contiene molte analogie con il gesto della madre che dà la vita. Si tratta, comunque, di un “dare”: la mamma dà la vita a un nuovo essere; chi offre la vita dà la propria vita. Come abbiamo visto precedentemente, sul piano generazionale, i genitori donano la vita per legare l’altro indissolubilmente. Anche dare in dono la propria vita tende ad un legame eterno.
L’azione del donare tende al legame incondizionato e si fonda sulla fiducia e la speranza di poter essere contraccambiati. Ma il dono può anche avere le caratteristiche di perversione quando viene usato in maniera strumentale. Sta nelle differente modalità di utilizzo del dono che possiamo distinguere anche le differenti modalità con cui si offre la vita. Essa può essere offerta in maniera gratuita, nella speranza e nella fiducia di poter essere ricambiati, o, al contrario, cercando di ottenere uno scopo.
Nell’atto del suicidio è insito uno scopo e, quindi, il dono assume caratteristiche di perversione. Goethe descrive in maniera inequivocabile lo scopo di Werther che chiede le pistole con cui poi si ucciderà al marito di Nole e quest’ultima li consegna con mani tremolanti all’ambasciatore del suo spasimante. Nelle mani tremolanti sta la comprensione dello scopo dell’offerta di Werther mi uccido per poterti legare a me nell’eternità.
Cigoli (op. cit.), nell’analizzare il suicidio di Van Gogh, distingue tre vie che gli effetti del suicidio hanno sulle relazioni generazionali:
- Quella dell’onta e della vergogna in cui il suicidio viene tenuto sotto silenzio e nascosto;
- Quella dell’inefficacia in cui il suicidio alimenta l’odio generazionale; tipico è quello raccontato da Omero di Epicasta madre di Edipo. Resosi conto dell’incesto commesso si suicida lasciando Edipo nel rimorso;
- Quella della redenzione in cui il nome del “morto suicida è salvaguardato e onorato”.
Io mi permetto di aggiungere un’altra categoria che è quella della perversione o della vendetta generazionale, come nel caso di Werther e Jacopo. Essi si suicidano per sottomettere e dominare in un tempo indefinito, che è quello successivo alla morte, le due donne, nel tentativo di farle provare sentimenti di colpa e di rimorso. Hillman sostiene che il suicidio non è soltanto una via per uscire dalla vita, ma anche come una via di ingresso nella morte, nel tentativo, per l’anima, di trovare una rigenerazione. Tale rigenerazione comporta il tentativo di ottenere l’amore per sempre e distruggere, nel caso di Jacopo e Werther, i legami con i loro mariti. La relazione che i due tentano di stabilire, attraverso il suicidio, contiene tutte le caratteristiche descritte da Scabini e Cigoli nella relazione patologica di cui ho parlato in precedenza. D’altronde, riguardo alle motivazioni che spingono al suicidio, viene descritto quello per vendetta. E’ la forma di suicidio che tende a colpire la persona che ha fatto soffrire in vita. Si vuole instillare in questa persona il rimorso e la colpa nel tentativo di impadronirsi per sempre dei sentimenti dell’altra o dell’altro. Le motivazioni e gli ideali che sottendono questo tipo di suicidio sono compatibili con la gelosia patologica. Nell’uno e nell’altro caso il presupposto è il possesso.