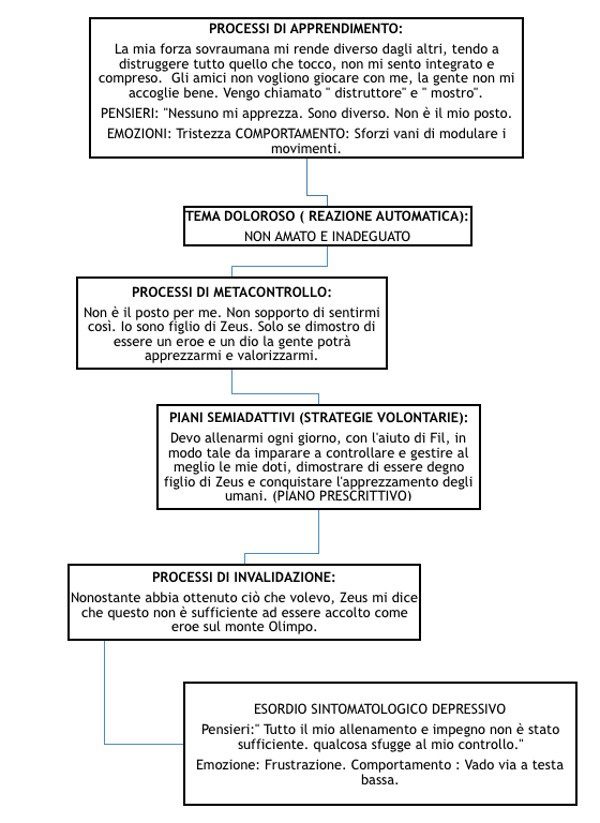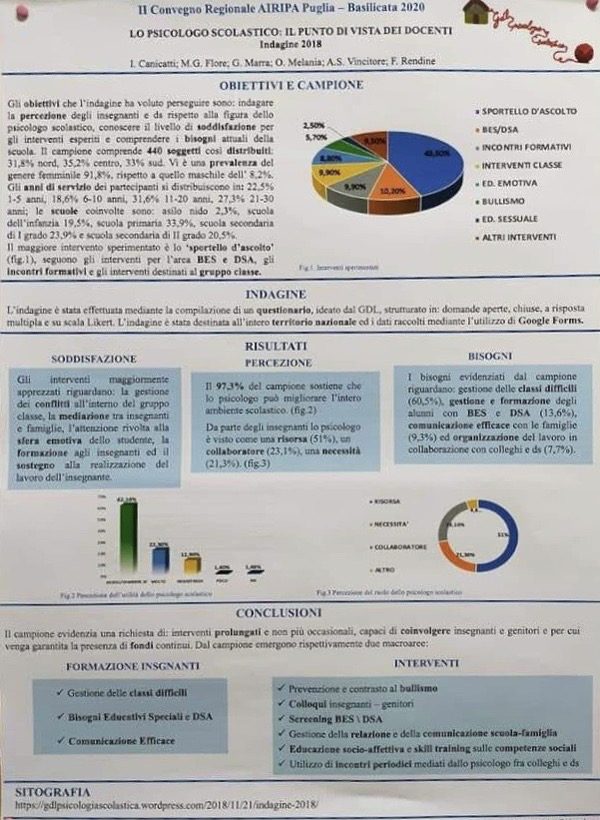Come la musica suscita emozioni: un pomeriggio con Massimo Priviero
Sono diversi gli aspetti della musica che ci portano a provare un’emozione. A cominciare dalla struttura del brano. Per quanto esposto in questo articolo faremo particolare riferimento al testo “Psicologia e musica” e ad un evento musicale organizzato lo scorso 8 febbraio con la presenza di Massimo Priviero, musicista, cantante e scrittore.
Tra tutte le arti la musica è probabilmente quella capace di emozionarci di più e questo è il principale motivo per cui ci piace ascoltarla. Abbiamo già parlato delle
13 emozioni suscitate dalla musica vediamo ora in che modo la musica fa nascere queste emozioni.
Per quanto esposto in questo articolo faremo particolare riferimento al testo “Psicologia e musica” e ad un evento musicale organizzato lo scorso 8 febbraio.
Come la struttura della musica determina le emozioni
Sono diversi gli aspetti della musica che ci portano a provare un’emozione. A cominciare dalla struttura del brano, il variare della sua intensità può mutare la nostra percezione e il livello della nostra emozione ad esempio risultando inizialmente calmo, poi gioioso e infine malinconico.
Senza addentrarci in un’ analisi dell’effetto emotivo prodotto dalle note, che ai non addetti ai lavori risulterebbe complicata, possiamo limitarci a considerare come in generale le note crescenti risultino allegre e quelle calanti vengono percepite come tristi. Una spiegazione è che i suoni calanti sono tipicamente emessi da chi soffre e si lamenta e per questo motivo vengono istintivamente catalogati come tristi, mentre espressioni di gioia hanno tipicamente un andamento crescente e questo viene quindi percepito come allegro.
Tra i fattori strutturali che giocano un ruolo nell’espressione dell’emozione in musica troviamo il tempo. Un tempo veloce, ad esempio, varia considerevolmente la dimensione dell’arousal, ossia la risposta del sistema nervoso ad uno stimolo, che da luogo ad eccitazione e ad un acuirsi del sistema attentivo-cognitivo.
Anche la complessità armonica e ritmica di un brano ha un ruolo importante, musiche troppo dissonanti (come spesso accade nella musica contemporanea, hanno sovente una connotazione negativa e sgradevole.
La musica si sviluppa su un piano temporale (parleremo tra poco delle aspettative), nell’istante in cui ascoltiamo non sappiamo cosa accadrà un attimo dopo e questo genera attesa.
L’attesa è fortemente legata all’emozione ed è frutto di un’elaborazione non cosciente, se così non fosse sarebbe difficile spiegare perché continuiamo a provare emozione anche nell’ascolto ripetuto di uno stesso brano. Un’elaborazione non cosciente del pezzo, al contrario, procede ad ogni ascolto a ricalcolare le attese in modo che la loro conferma o meno dia luogo all’aspetto emotivo del brano.
L’aspettativa
Nella fruizione di un brano l’ascoltatore nutre inconsciamente delle aspettative su come quel pezzo andrà sviluppandosi. In generale, se la sua struttura avrà l’effetto di confermare la nostra aspettativa si verificherà un’emozione positiva, in caso contrario prevarrà un senso di negatività e di sorpresa.
Generalmente le canzoni che preferiamo nel loro andamento sonoro sono una via di mezzo tra la conferma delle nostre aspettative e l’effetto sorpresa. Sono quindi canzoni definite di “media complessità”, con un’incertezza moderata, dove ad uno svolgimento prevedibile si alternano sorprese.
Ma non è sempre così semplice: anche il livello di certezza o meno che raggiungiamo attraverso l’ascolto ha un suo peso. Pare infatti che se ci sentiremo quasi assolutamente sicuri di quale sarà la nota o l’accordo che seguirà, un’eventuale sorpresa ci provocherà piacere, al contrario, se ci sentiremo incerti su come il brano si svilupperà, proveremo più piacere nel non essere sorpresi dall’accordo successivo.
Non va dimenticato poi che la musica viene prodotta con uno scopo. Chi la compone vuole trasmetterci qualcosa, quindi la sua struttura, il contesto, le parole che la accompagnano mirano anche a manipolare le nostre aspettative contribuendo a dar vita ad una specifica emozione. Come per le parole, dove frequenza, intensità e distribuzione dei suoni trasmettono un certo tipo di messaggio, anche nella musica agiscono gli stessi elementi.
Chi parla con rabbia assume un ritmo veloce, un timbro ed un’intensità alta, uguali caratteristiche danno ad un brano musicale il potere di suscitare un’emozione di rabbia e così via.
L’evento
L’evento di cui vi parliamo ha avuto luogo nella struttura avveniristica di Oxy.gen a Bresso (Mi), che ospita attività culturali e formative. Con noi Massimo Priviero, che ha messo a disposizione la sua trentennale esperienza di musicista, cantante e scrittore.
Per coinvolgervi in quanto è avvenuto, vi invitiamo a seguirci in questo racconto.
Immaginate di trovarvi sulle rive di un piccolo lago..

Davanti a voi un ponte in legno, porta ad una bolla d’aria che galleggia sull’acqua. Lo percorrete fino in fondo. Entrate. La struttura circolare vi accoglie, siete in uno spazio astratto, tutto il resto è rimasto a riva.

Con voi altre persone, tante persone, ma c’è silenzio, la luce filtra dalle tende a soffietto che ricoprono le vetrate, in lontananza si sente il verso delle anatre, le ombre degli uccelli in volo si riflettono all’interno.

Inizia la musica. C’è un tema dominante in quello che si ascolta: un messaggio positivo di forza, fiducia, speranza. La capacità il coraggio necessari per superare gli eventi, siano essi difficili o dolorosi, la volontà di rialzarsi sempre e di volare più in alto.

Alcuni stralci
Il pubblico presente si può dividere equamente in persone che già conoscono molto bene i pezzi che si ascolteranno e che avevano già partecipato a rappresentazioni live degli stessi, e persone che ascolteranno questa musica per la prima volta.
Ed ora leggete questi stralci e il senso che si è cercato di trasmettere:
Ringrazio il mio Dio del Cielo,
per la mia anima inespugnabile
Ringrazio ogni uomo vero,
sia mio compagno inattaccabile
Ringrazio le bombe che mi cadono intorno ogni giorno
che mi feriscono ma non mi uccidono mai
Ringrazio la vita che sia paradiso od inferno,
è gioia e fango, ma è tutto quello che hai
E per ogni alba che viene e ogni notte che va
Per il sorriso ed il pianto che volano via
Ringrazio ogni giorno guerriero di vita mia
(da “Orgoglio”, Massimo Priviero)
Questo pezzo è scritto in un momento di forte fragilità. Fragilità non legata ad un fatto specifico ma semplicemente figlia di un modo di essere che vive di alti e bassi. Una forma di terapia interiore, come se fosse una necessità dire a sé stessi che ha un senso essere stati ed essere quanto si è. Pur mettendosi in discussione.
E’ spesso sorprendente come in un tempo difficile si possano scrivere parole che invece prendono forma di forza esistenziale. Ripetere la parola
ringrazio all’inizio di ogni verso è un voler ringraziare di essere vivo pensando che valga la pena difendere il proprio modo di stare al mondo.
Mettersi ad un tavolo e scrivere qualcosa del genere fa nascere quasi una sorta di felicità che un po’ alla volta prende forma e si condivide. A questo punto ognuno può prendere quel che meglio crede, ognuno può trovarci dentro una frase che lo tocca di più, ognuno può sentirci quel che vuole.
E’ come se alzaste gli occhi al cielo e vi venisse da dire “in questo viaggio che è la mia vita, in tante volte in cui pure cado in terra, io qualche volta il cielo lo vedo e, questo, sono felice che accada”.
E ancora:
Dove sei, dove sei dolce angelo mio
Dove sei, dove sei che non ti vedo mai
Sono io la tua voce che saprà gridare
Sono io la tua mano che non può tremare
Sono io la tua forza che saprai cercare
Sono io le campane che ieri han suonato
Sono io la tua vita che non hai venduto
Sono io l’alba nuova che saprai cercare
Sono io insieme a Cristo venuto a salvare
Ma se un uomo domani ti chiederà
Se un uomo domani ti chiederà
Tu digli che sono le ali, io sono le ali, della sua libertà
(da “Ali di Libertà”, di Massimo Priviero)
Le immagini che sono in questo pezzo sono spesso la difesa di chi ha poco altro a cui aggrapparsi che non siano proprio queste ali. Non c’è alcuna cosa che conta di più nella vita di un uomo che essere libero, non c’è nulla al mondo per cui tu possa farne a meno. Cerchiamo di dare un volto a quanto ci spinge avanti, alle ragioni per cui val la pena di vivere, o a qualunque cosa pensiamo che debba avere risposta.
Forse le Ali di libertà sono semplicemente quelle che ci servono per farci proprio queste domande che non hanno risposta. Ma che, ostinatamente ci facciamo. E, forse, in questa necessità arriviamo al bisogno di chiudere gli occhi e di farci trasportare dentro ai suoni e alle parole. E magari in quel momento smettiamo di farci domande a cui non sappiamo dare risposta.
Conclusioni
Ascoltare un disco è certamente fonte di emozione ma andare ad un concerto lo è sicuramente molto di più. Ascoltare musica dal vivo è indubbiamente considerato il modo migliore per sperimentare un coinvolgimento emotivo.
Se fino ad ora abbiamo parlato delle emozioni come di qualità intrinseche della musica, una parte importante dell’emozione in musica è suscitata dall’esperienza personale.
Sul piano percettivo vi è una forte somiglianza sul modo in cui ciascuno percepisce la musica, più difficile affermare la stessa cosa sul piano emotivo perché entrano in gioco fattori quali storia personale, contesto sociale e culturale, stato d’animo.
Per tornare al nostro evento, la definizione più utilizzata a fine spettacolo per descrivere quanto vissuto è stata “una forte emozione”, seguita da “positività” e “forza”.
Alcune canzoni hanno suscitano emozioni perché collegate ad un ricordo, ma è stato confermato che anche canzoni ascoltate per la prima volta sono state in grado di emozionare e, soprattutto, di evocare in ciascuno le stesse emozioni, indipendentemente da età, sesso, cultura, ed esperienze personali.
Durante l’ascolto dal vivo si verifica uno scambio fisico ed emotivo tra chi esegue il brano, il singolo ascoltatore e l’insieme del pubblico. Inoltre, come già detto, in chi produce musica (l’artista che canta o che suona) c’è il proposito e la volontà di trasmettere con quei suoni determinati sentimenti ma lui stesso risente della risposta emotiva che gli arriva dal suo pubblico.
Si ascolta e si produce musica con la propria energia e con il proprio stato d’animo di quel momento ma anche l’insieme di attenzione e partecipazione del pubblico influenza sia la produzione dei suoni che l’effetto che questi producono sul singolo ascoltatore.
Inevitabilmente accade che se siamo tesi, arrabbiati, preoccupati, il nostro livello di attenzione cala e l’ascolto avrà meno possibilità di trasmetterci emozioni. Al contrario, se siamo rilassati, saremo più aperti a favorire uno scambio emozionale con ciò che ci circonda.
Nda: Si ringrazia l’Associazione Il Riccio, Il Comune di Bresso e la Fondazione Zoé-Zambon che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento