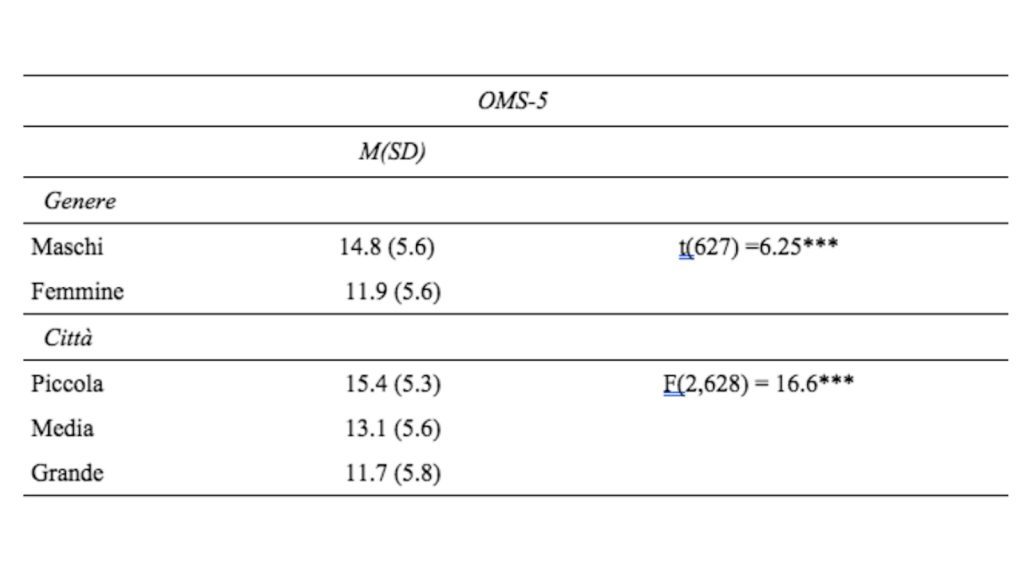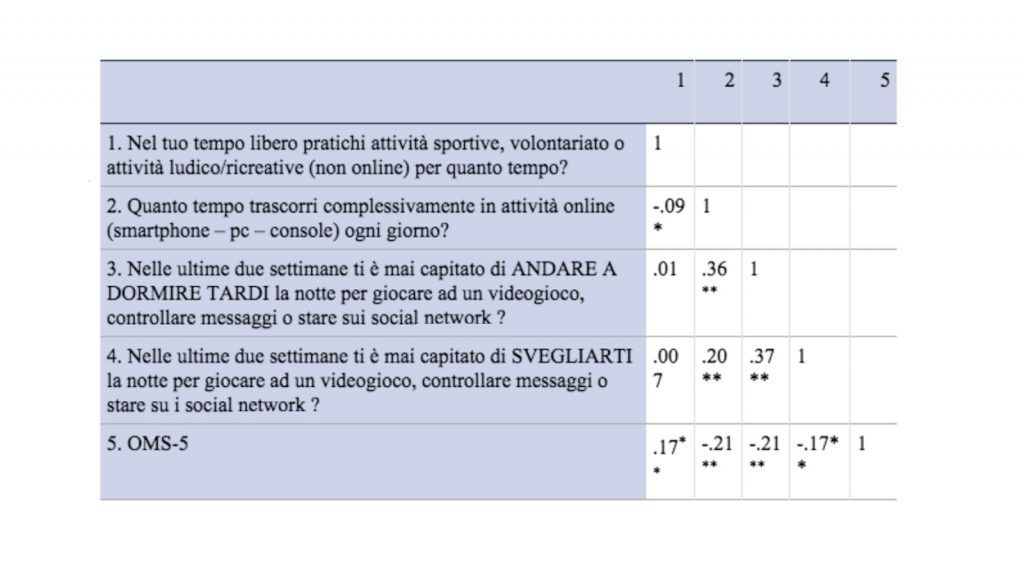Nostalgia del “dica 33”
E’ fondamentale che il personale sanitario, professionisti della cura, eserciti l’arte della compassione, ovvero della sensibilità verso la sofferenza nostra e dei nostri pazienti, dobbiamo parteciparne e sentirci impegnati nel cercare di alleviarla.
Ammalarsi gravemente, ancor più se trattasi della malattia presumibilmente definitiva, rappresenta un evento traumatico nella vita di una persona poiché, in modo non annunciato e frettoloso, siamo messi a confronto con la dissoluzione delle consuetudini, l’annientamento delle abitudini e delle routine familiari e sociali, fondamento identitario.
Lo spazio ed il tempo si disintegrano, l’idea del morire non è più qualcosa su cui magari fantasticare a tempo perso, ma diventa la concreta compagnia di ogni minuto e la si percepisce in modo fisico, immediato, attraverso il dolore mentale e fisico che accompagna la malattia.
Quello che fino al giorno prima era importante, magari fonte di cruccio, di preoccupazione, di rabbia o di dolore viene dimenticato, un’amnesia quasi dissociativa prende il sopravvento e si fa strada la sensazione soggettiva e grave di sentirsi estranei, del tutto estranei al resto del mondo.
Il neo-malato grave si colloca in un limbo in cui i rumori dell’esistenza quotidiana, di cui fino a poc’anzi era partecipe, giungono attutiti e progressivamente sbiadiscono di significato.
La routine della malattia impone suoi tempi e modi di vivere: i discorsi si centrano e ruotano, anche per ore, su quei fatti banali a cui mai prestiamo troppa attenzione, le linee di febbre, l’astenia, le necessità fisiologiche, il cibo troppo o troppo poco, i bisogni primari che diventano imperiosi e dilaganti.
E’ la rivincita del corpo che, forse prima trascurato, si impone prepotentemente con mille rivendicazioni pressanti e inesauribili.
I familiari, i coniugi, le persone care, devono comunque mantenere un rapporto con la realtà, ne sono obbligati, rapporto fatto di interazioni con luoghi, negozi, farmacie, supermercati, uffici o altro, con abilità, guidare la macchina, cucinare, riposare e con ruoli e funzioni sociali, tra tutte il lavoro.
Il malato, al contrario, si trova in una corsia di ospedale, in attesa di intervento, chirurgico o altro.
Sta in un mondo a parte privo di ogni responsabilità, destituito di potere ma anche di doveri se non quello di sottoporsi, docile, alle cure.
Ancora i primi giorni sembra mantenere una sua formale dignità legata alla sua identità precedente ma, con i primi interventi di cura, le prime interazioni con gli operatori sanitari o semplicemente con l’avvento del pigiama ventiquattr’ore il malato trasloca in un ruolo, quello di malato, appunto, che annebbia perfino il proprio nome e cognome o la vita com’era fino al giorno prima. Com’eravamo.
Cominciano con il non chiamarti per nome o per cognome, ma diventi il numero del letto o della stanza; ti appellano con nomignoli di ogni genere, a Roma teso’ che sta per tesoro, oppure cocco nelle sue infinite variazioni diminutive e sempre, invariabilmente, ti danno del tu.
L’ospedale, i suoi orari, il suo funzionamento generale pare sia pensato per essere un luogo quanto più confortevole possibile per gli operatori e questo ha un senso solo nella misura in cui gli operatori sanitari sono quelli che ci passano la vita, al contrario dei pazienti che lo frequentano per tempi più o meno brevi.
Però questa centratura sull’operatore diviene talmente estrema che i malati si sentono di troppo, temporanee intromissioni che interrompono le chiacchiere sui pettegolezzi più recenti, gli accesissimi dibattiti sindacali, i nervosismi quotidiani; un po’ infastidiscono le loro necessità, le lamentele, le attenzioni o le semplici domande che di tanto in tanto trovano il coraggio di porre, con tanta maggior sfiduciata insistenza tanto meno sono ascoltati.
Per non dire dei familiari che, sempre dal punto di vista della routine ospedaliera, sono ancora più fastidiosi, mal tollerati, vengono rapidamente espulsi allo scadere degli orari di visita, senza cogliere per nulla l’opportunità che rappresentano in una situazione, su quello siamo tutti d’accordo, di cronica carenza di personale.
Ogni familiare, infatti, aiuta il proprio congiunto ma anche gli altri malati, per quella solidarietà e comprensione che nasce spontanea nelle situazioni di sofferenza condivisa.
Basterebbe dare loro poche informazioni e consigli, per avere una gran quantità di mano d’opera, certamente scarsamente formata, ma fortemente motivata e, soprattutto, disponibile a ciò che più di ogni altra cosa tutti gli operatori sanitari sembrano fuggire in modo quasi fobico: il contatto, la relazione con il malato che viene trattato, come in ogni istituzione totale, come un numero di letto, una diagnosi, un oggetto su cui praticare degli interventi, il più rapidamente possibile, per correre altrove.
Il o la caposala decide quanto tempo il parente potrà trattenersi, vigila fermamente sulla regola “solo uno nella stanza” e ti rassicura dicendoti che ci sono gli operatori, infermieri e Oss, per le pratiche quotidiane di cui ha necessità il malato. Quando poi arrivi, al minuto spaccato per cui hai avuto il permesso, trovi il tuo caro che ti aspetta come la manna dal cielo perché da ore, troppe, sta aspettando cure, igieniche o sanitarie, per cui ha suonato e risuonato il famoso campanello. Vengono, lo spengono e ti dicono “mo’ arriviamo teso’ ” e rispariscono nel nulla del corridoio, verso cui sono rivolti gli sguardi ansiosi dei pazienti.
Si tratta, certamente, di un tentativo comprensibile di prendere le distanze dal dolore per non esserne contagiati, credendo erroneamente che sia questa la soluzione più giusta per sé, per il proprio equilibrio e benessere, ma si trasforma in disappunto, in irritazione verso chi di tanto dolore è la possibile fonte di contagio e, soprattutto, non funziona e priva completamente l’operatore di un’abilità fondamentale per chi abbia avuto l’ardire di scegliere una professione di cura: la capacità di ascoltare.
Nell’ospedale, in tutte le stanze, i corridoi, gli ambulatori, gli ascensori, dovunque, campeggia un cartello, evidentemente il più recente per la vivacità dei colori e per essere in sovrapposizione a quelli più vecchi e sbiaditi, che recita: “E’ reato aggredire fisicamente e verbalmente il personale sanitario di qualsiasi categoria: i trasgressori saranno puniti a norma di legge”.
Colpisce che ci sia bisogno di un tale cartello come, per parlare di attualità, della scorta alla senatrice Segre.
Forse troppo idealisti, la prima aspettativa che abbiamo di un ospedale è quella di un posto dove i professionisti della cura abbiano l’impellente vocazione di alleviare la sofferenza altrui, magari con il sorriso sulla bocca mentre, di contro, i malati ringraziano, riconoscenti all’infinito, i loro benefattori.
Ma ben presto ci si rende conto che non è così anzi, al contrario, il paziente si trova nel bel mezzo di una doppia guerra: una, che potremmo definire territoriale, tra gli operatori signori dell’ospedale ed i pazienti, con i loro familiari, truppe d’invasione. L’altra, che potremmo definire civile, tra le varie categorie, (caste?) di operatori.
A queste due grandi battaglie si intrecciano le consuete conflittualità personali quotidiane, le antipatie, le piccole ritorsioni che, tuttavia, ovunque presenti nei posti di lavoro, non rappresentano una peculiarità ospedaliera.
Le stesse caste cui in precedenza facevamo riferimento, si definiscono proprio sulla distanza che hanno con il malato: più se ne è lontani, più si è importanti nella gerarchia ospedaliera.
Il primario è un’entità astratta, un “deus ex machina” della cui esistenza si può, talvolta, legittimamente dubitare, che si limita a qualche apparizione settimanale durante la quale attraversa il reparto come una folata di vento, seguito da alcuni medici di ruolo, cioè assunti dal SSN e da una nuvolaglia di specializzandi che lo seguono con i camici svolazzanti, i fonendoscopi a tracolla come pregiatissime sciarpe, una sfilza di penne multicolore nel taschino, perlopiù parlottando tra loro delle faccende tipiche della loro interminabile e ritardata adolescenza sociale.
Passano in rassegna i malati ma comunicano esclusivamente tra loro, mentre il paziente viene del tutto ignorato, al punto che può dubitare di essere presente.
Non si parla direttamente con lui, tanto meno con il familiare, che viene prontamente fatto uscire dalla stanza portando con sé miriadi di domande che si era accuratamente preparato a cui nessuno darà mai una risposta; i medici commentano tra loro gli ultimi esami o le analisi, accennano ad altre possibili pratiche cui sottoporre la persona ma si guardano bene dall’agire quella pratica, evidentemente antiquata, desueta e forse considerata dannosa che si chiamava visita medica.
Sembra essere un vero e proprio tabù, come se visitare un paziente, nel senso di toccarlo, auscultarlo, guardarlo fossero azioni primitive, di altri tempi pretecnologici.
Dopo troppi giorni di polmonite la primaria dichiarò, rimanendo come al solito sulla porta, che ci voleva la consulenza con lo pneumologo. Sollievo, finalmente qualcuno ti visiterà e potrai fare quei grossi respiri a bocca aperta, mentre il tuo polmone viene auscultato per sentire se si riempie dell’ossigeno per vivere. Passa un giorno, la febbre è alta, passa il secondo, stai proprio male e c’è preoccupazione in chi ti sta accanto che, finalmente, ha avuto il permesso dal caposala di occuparsi di te, da sola mi raccomando! per tutta la giornata.
Dopo altri giorni, trovi il coraggio per chiedere alla più buona delle infermiere che hai individuato, che però già si è irrigidita perché te ne stai un po’ approfittando, che fine ha fatto lo pneumologo?
Dopo una serie di ostacoli a catena, tipo devi chiedere al caposala che ti dice devi chiedere al medico che ti dice devi chiedere al medico più importante e così via, finalmente uno ti risponde: “E’ già passato”.
Ti scusi ma, a meno che non sei proprio fuori di testa, tu non l’hai visto, certo che non l’hai visto è passato e ha visto le lastre! Ed ha stabilito la terapia! E tu che un po’ ti stai arrabbiando, perché nessuno ti ha detto niente, finalmente dici “Guardare le lastre equivale a visitare un paziente, professore?” dove la parola professore viene pronunciata con un leggero ma non troppo sarcasmo, che il professore avverte e scontroso ti risponde che hanno troppo da fare per visitarti e va bene così.
Non va bene così.
A volte qualche giovane specializzando mostra un po’ di interesse per la persona sofferente ma, dall’atteggiamento degli altri, capisce rapidamente quanto quella sensibilità sia sconveniente e rappresenti un ostacolo alla professione iperspecialistica a cui si sta avviando.
Si baratta la competenza tecnica con l’umana sensibilità e i giovani imparano rapidamente, a volte sembrano una grottesca imitazione degli anziani, ormai incalliti nel loro gelido distacco; inefficiente protezione contro il dolore e non prevenzione, ma semmai concausa del burnout perché il dolore e l’idea stessa della morte non si possono ignorare, ma semmai elaborare con il risultato di aumentare la propria partecipazione compassionevole al destino di sofferenza di tutti i viventi, nessuno escluso.
I medici dunque non conoscono i pazienti ma esclusivamente i loro esami clinici che portano in genere alla prescrizione di ulteriori accertamenti, con l’unico scopo di essere inattaccabili da un punto di vista medico legale in caso di successivo contenzioso: la medicina difensiva governa sovrana.
I dottori, quando non sono annoiati o sbrigativi, sono spaventati, appesantiti dalle costose assicurazioni che devono pagare, vedono in ogni paziente un potenziale querelante e ciò crea un circuito di diffidenza e timore reciproco che inquina totalmente la relazione di cura che, più che un’alleanza, pare una tregua armata.
Altro effetto non secondario di questa iperprescrizione di esami strumentali, che vengono richiesti per FARE diagnosi, non per confermarla o falsificarla, è la morte della semeiotica medica, il medico che guarda i segni, tocca, palpa, stringe, odora e, talvolta, assaggia il paziente.
Questo sta portando all’impoverimento della professione medica.
Quando la diagnosi sarà il frutto di un algoritmo che mette in sequenza una serie di esami strumentali a cui far seguire un protocollo terapeutico standardizzato, un ulteriore algoritmo, il tutto magari gestito da un’intelligenza artificiale certamente più aggiornata e meno soggetta ad errori ed interferenze emotive di qualsiasi medico, per quanto quest’ultimo si sforzi di assomigliare ad una macchina, di medici non ci sarà più alcun bisogno. Le macchine fanno le macchine meglio degli umani e quando l’umanità sarà vista come un ostacolo saranno le macchine ad esser vincenti.
Il medico si sente minacciato dal paziente, si attiene scrupoloso a linee guida e protocolli, con ciò rinunciando ad una personalizzazione della cura che avvilisce l’intuito clinico e l’unicità di ogni paziente.
Il paziente e i familiari si sentono trasparenti, non visti, mai ascoltati.
A volte c’è una domanda davvero urgente da fare o un momento di crisi del proprio caro, o una difficoltà importante: allora si mette da parte il proprio naturale riserbo, si forza il desiderio di non disturbare e si trova il coraggio di affrontare uno di questi medici svolazzanti. Si chiama, si chiede la presenza.
Il medico entra, il viso è già molto teso, gli occhi sono sfuggenti, si capisce che è stato disturbato ma può concedere qualche minuto. Il non verbale è molto chiaro e il paziente e il parente sono già in uno stato di soggezione, vogliono scusarsi, balbettano.
Il medico non ascolta, dopo le prime parole interrompe sbrigativo, colpisce l’alterigia con cui pensa di sapere già qualcosa che deve essere ancora comunicato, lui sa, tu no, la risposta non corrisponde alla domanda poiché la domanda non si è riusciti a farla ma tant’è, nemmeno il tempo di una debole protesta che lui è già fuori dalla stanza, svanito nel nulla.
Stavi proprio male, quel giorno, il colorito era marrone, faticavi a parlare, non riuscivi ad alzarti in piedi.
Una lunga, interminabile domenica, chiami e chiami perché da un momento all’altro sono comparsi pure i dolori all’addome, ma vengono, controllano i parametri, i parametri sono a posto e se ne vanno.
I parametri saranno pure a posto ma tu stai per morire e quindi ogni tanto chiami e chiami.
In serata uno dei tanti dottori ti apostrofa, anche piuttosto sbrigativo e lui, che è chirurgo, finalmente trova il modo di fare lo psicologo pronunciando la celebre frase “non hai niente, sei stanco di essere ricoverato, devi solo tornare a casa”.
Il giorno dopo operato d’urgenza, finalmente sono d’accordo anche loro sul fatto che stai per morire.
Un tempo accanto al medico c’era l’infermiere, in posizione subordinata per ciò che riguardava la responsabilità della cura ma un vero punto di riferimento per il dottore o il primario e, sicuramente, per il paziente, per quanto riguardava la concretezza della cura.
L’azione dell’infermiere rappresentava la cura trasformata in operatività, segni fondamentali e costanti attraverso i quali veniva applicato il pensiero medico, una sinergia armonica.
Ora c’è una frammentazione da catena di montaggio, persino i parametri vitali (pressione arteriosa, temperatura, glicemia, saturazione…) sono rilevati da operatori diversi che passano quando hanno tempo e mai, proprio mai, rivelano al paziente il valore misurato.
Dopo la lotta di liberazione dai medici, con la nascita di un’apposita laurea che prevede, anche lì, varie specializzazioni, livelli e ruoli dirigenziali, gli infermieri hanno creato una propria catena gerarchica indipendente da quella medica, da cui si differenziano a volte con una malcelata ostilità.
Hanno una loro professionalità, rappresentata da un preciso mansionario, di cui vanno gelosissimi, che consiste specificatamente nella somministrazione delle terapie e poi c’è la mitica figura del caposala, protettivo verso i suoi ed autoritario verso tutto il resto del mondo, che rappresenta la gestione dell’ordine pubblico all’interno del reparto, vale a dire il rispetto delle regole e di ciò che è ammesso o vietato.
E sebbene possa sembrare strano, anche per la somministrazione delle terapie non è assolutamente necessario un contatto diretto con il paziente: si possono mettere e togliere flebo, inserire aghi, misurare pressioni o temperature o quant’altro, senza scambiare una parola, senza guardare negli occhi, senza rispondere ad una domanda, come se l’altro non esistesse.
Di nuovo, la mancanza di una relazione con il paziente, come per i medici, sembra essere diventato un indicatore di importanza nella gerarchia ospedaliera.
Ci si stupisce della capacità, automatica, seppure innaturale, di distogliere lo sguardo mostrando sempre e solo insofferenza, fretta, dopo che un paziente o un parente rivolge timidamente una semplice domanda, magari con un sorriso.
Non è facile non emettere alcun segno verbale o non verbale come se l’interlocutore non esistesse. Watzlawick scriveva, nella sua famosissima Pragmatica della comunicazione umana, che è impossibile non comunicare, dimostrando con ciò di non essere mai stato ricoverato.
Pazienti e parenti hanno l’impressione costante di invisibilità oppure, nel migliore dei casi, di dare un po’ fastidio, intrusi nell’esistenza quotidiana del “villaggio reparto” all’interno del “paese ospedale”.
Bisogna con fatica rammentarsi che, in verità, sono i pazienti i datori di lavoro degli operatori che affollano quel villaggio che è anche casa nostra.
L’alterigia regna sovrana, i medici sono un po’ preoccupati quando, a loro volta, devono fare qualche richiesta agli infermieri, c’è quel fenomeno curioso dello scaricabarile, “questa cosa non tocca a me ma tocca a lui, oppure tocca al prossimo turno, oppure domani, oppure adesso c’ho troppo da fare”, incontri e scontri sempre con il paziente presente, tanto non esiste, è invisibile.
Popper, nel suo La società aperta e i suoi nemici, parlando della scuola scriveva che la prima riforma decisiva a costo zero, vera rivoluzione, sarebbe consegnare direttamente a casa lo stipendio a tutti quegli insegnanti che lavorano solo per avere uno stipendio, proibendo loro di avvicinarsi ai ragazzi.
Forse la stessa cosa potrebbe valere per la sanità, più in generale per tutti quei lavori che hanno in primo piano una relazione interpersonale, ancor più se di aiuto.
Gli ultimi del villaggio sono gli ex portantini, oggi operatori socio-sanitari che, dovendo occuparsi dell’igiene, della pulizia e dei bisogni fisiologici dei pazienti, sono costretti a toccarlo e, con ciò, ad avere una qualche forma di relazione.
Tra loro sopravvive una qualche forma di umanità, fuori dalla dinamica istituzionale del distacco cercato ed esibito.
Ricordiamo che, teorizzata e portata poi avanti dal genio di Franco Basaglia, la riforma psichiatrica prese le mosse primariamente dai portantini dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Roma, il più grande manicomio d’Europa; evidentemente, più dei medici e degli infermieri, imprigionati pregiudizialmente nelle loro procedure scientifiche, avevano mantenuto intatta la capacità tutta umana di indignarsi per i contesti disumanizzanti in cui vivevano i pazienti.
I colori dell’ospedale: dopo le critiche amare e frutto della generalizzazione di un’esperienza personale, una proposta
Per usare la terminologia cromatica del modello di Paul Gilbert e della Compassion Focused Therapy pensiamo che occorra puntare ad un ospedale sempre più green, un luogo dove tutti, operatori, che lavorano anche con fatica, e pazienti, che soffrono, possano sentirsi tranquilli, calmi, in connessione e sicuri.
Come operatori sanitari dobbiamo uscire dall’assetto difensivo del distacco a tutti i costi, che si traduce nel vissuto pregiudiziale “più sono distaccato e mi difendo, più vivo bene” perché questo assunto è falso proprio e soprattutto per il benessere dell’operatore, prima ancora che per i pazienti.
Come professionisti della cura dobbiamo esercitare l’arte della compassione, ovvero della sensibilità verso la sofferenza nostra e dei nostri pazienti, dobbiamo parteciparne e sentirci impegnati nel cercare di alleviarla.
Essere compassionevoli comprende quelle emozioni e pensieri che si traducono in comportamenti finalizzati a prendersi cura, soccorrere, proteggere, sentire la sofferenza altrui ed essere in grado di tollerarla.
La nostra cultura attuale, al contrario, sta privilegiando sempre più le formule competitive e aggressive come terapia per vivere meglio, un sistema red dove le persone reagiscono con rabbia, ansia, disgusto o paura ad una realtà esterna vissuta come perennemente minacciosa e popolata di spietati competitor.
Difendiamo i nostri confini personali come se fossimo perennemente in guerra, ma è una guerra tutta interiore perché siamo così impegnati a difenderci che non abbiamo il tempo né di ascoltare né di guardare chi o cosa abbiamo davanti.
Siamo convinti che se reagiamo per primi siamo vincenti, se manifestiamo indifferenza siamo liberi, abbiamo paura della nostra umanità e quindi ci chiudiamo nelle gabbie della protervia e dell’ira.
Pensiamo ad un ospedale aperto, che integri ed utilizzi volontari e, soprattutto, familiari e sia in più forte continuità con l’assistenza domiciliare, con il day hospital e il day surgery.
La formazione degli operatori sanitari ai concetti di compassione ed empatia ridurrebbe il disagio dei pazienti, ma forse ancor di più il burnout degli operatori.
L’ospedale deve interagire col paziente, ponendolo al centro come protagonista delle sue cure e dei suoi interventi.
In tal modo si potrà arginare l’iperspecializzazione, la frammentazione del malato in un insieme di organi affidati a diversi specialisti e la conseguente, comprensibile fuga verso la medicina alternativa, che ancora prova interesse per la persona, oltre che per la malattia di cui quella persona è portatrice.
Si tratta in primo luogo di riparare l’alleanza terapeutica tra paziente e curante.
In tal senso ci piace immaginare una grande iniziativa che, a partire dalla sollecitazione delle società scientifiche e dalle scuole di psicoterapia, che possiamo considerare esperte della materia, venga fatta propria dal Ministero della Salute che convochi gli Ordini delle Professioni di cura e le Associazioni dei malati ad una specie di “Stati generali della relazione di cura” allo scopo di lavorare insieme per elaborare una sorta di Patto per la cura in cui curanti e curati esprimano richieste ed impegni, diritti e doveri, in un confronto/contratto reciproco.
Crediamo che la psicologia e la psichiatria possano essere promotrici di questo urgente cambiamento, per la riflessione approfondita sull’importanza della relazione terapeutica e che questo sia ovviamente utile ai pazienti ma ancor più agli operatori sanitari che potrebbero forse trasformare, in parte, un lavoro indubbiamente faticoso e oneroso in gratificante.
Già in passato la psichiatria è stata avanguardia e modello per il resto delle branche mediche: la famosa legge 180/76 che eliminò la centralità dell’ospedale psichiatrico, avviando la psichiatria territoriale fu il modello sul quale, pochi mesi dopo, fu varata la riforma del Sistema Sanitario Nazionale, legge 833/76.
Finalmente a casa dopo più di un mese di degenza. Sei ancora un malato, molto malato, ma sei nel tuo luogo sicuro. Ti riprendi la dignità, ti riprendi il diritto di soffrire senza colpa.
E ti commuovi quando la tua dottoressa, il tuo medico di base, viene a visitarti a casa, tira fuori il fonendoscopio, ti alza la maglietta e ti tocca pure. Respiri, respiri profondi a bocca aperta, col dito a martelletto ti batte sulla schiena e dice il proverbiale “dica trentatrè” che credevamo perduto.