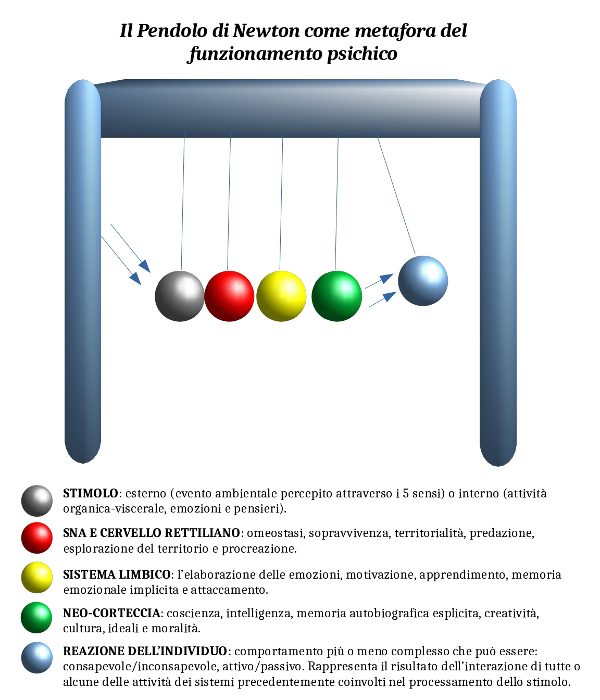Alla scoperta del neurone: dalla “reazione nera” di Golgi alla sinapsi di Sherrington
La scoperta della ‘reazione nera’ di Golgi e le sue implicazioni sull’osservazione del tessuto nervoso ebbero una portata scientifica enorme. Dal perfezionamento di essa, ebbero inizio le moderne ricerche sulla struttura istologica del sistema nervoso e delle unità di cui è composto.
Eliana Berra – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi Milano
Che spettacolo inaspettato! Filamenti neri sparsi, lisci e sottili, oppure cellule nere spinose, spesse, triangolari, stellate o fusiformi si possono vedere su uno sfondo giallo perfettamente traslucido! Si potrebbe quasi paragonare le immagini a disegni di inchiostro cinesi su carta giapponese trasparente […] questo è il metodo di Golgi. (Cajal)
Così ricordava nei suoi scritti un medico spagnolo rievocando la sua prima osservazione, avvenuta nel laboratorio rudimentale allestito a casa di un collega, del tessuto nervoso trattato con la “reazione nera” ideata qualche anno prima dall’italiano Camillo Golgi.
Il medico spagnolo era Santaigo Ramon y Cajal. Colui che avrebbe condiviso, proprio con Camillo Golgi, il premio Nobel per la medicina del 1906. Colui che avrebbe individuato nel neurone l’elemento costitutivo essenziale del tessuto nervoso, portando alla ribalta la teoria cellulare del sistema nervoso.
La “teoria cellulare”, secondo cui le cellule sono i componenti elementari degli organismi viventi, era stata proposta nel 1600, ma venne formalizzata solo nel 1800 dal botanico Matthias Schleiden e dallo zoologo Theodor Schwann e ulteriormente validata, per ciò che riguarda gli organi che compongono il corpo umano, dal patologo tedesco Rudolph Virchov. Sino all’inizio del ‘900, fu dibattuto tuttavia se tale teoria fosse applicabile anche al sistema nervoso; infatti, il tessuto nervoso appariva strutturalmente più complesso rispetto a quello di altri organi e i metodi di indagine dell’epoca non consentivano di distinguere le cellule rispetto alle fibre nervose. A prevalere era la teoria secondo cui il sistema nervoso fosse l’insieme di una fitta rete di sottili filamenti che si univano per formare le fibre nervose, collegate le une alle altre. Tale teoria, descritta dal tedesco Josef von Gerlach nel 1871, prendeva il nome di “teoria reticolare” ed era abbracciata dalla maggior parte degli studiosi dell’epoca. Tra questi, vi era Camillo Golgi.
Camillo Golgi si laureò in medicina nel 1865 all’università di Pavia sotto la guida di un professore la cui fama è tuttora nota: Cesare Lombroso. Tuttavia, gli studi di carattere istologico sul tessuto nervoso ebbero inizio per il neolaureato Golgi, quando entrò a far parte del laboratorio di Pavia diretto da Giulio Bizzozero, e si sarebbero interrotti da lì a qualche anno se la sua determinazione non avesse prevalso e aggirato le difficoltà che si trovò ad affrontare. Fu infatti nominato primario presso un ospedale di provincia, le Pie Case degli Incurabili di Abbiategrasso, ove non era previsto che venisse effettuata attività di ricerca, non vi era alcun laboratorio e i mezzi a disposizione erano rudimentali. Particolari trascurabili per lo studioso che trasformò la cucina dell’ospedale in laboratorio e proseguì i suoi studi con l’appoggio dei colleghi di Pavia.
Golgi desiderava studiare il tessuto nervoso e per farlo voleva osservare il tessuto cerebrale come sino ad allora non era stato possibile. I microscopi ottici, utilizzati per la ricerca scientifica sin dal 1600, avevano avuto un ulteriore sviluppo nell’800, ma erano ancora viziati da alcuni artefatti ottici e cromatici. Inoltre, per poter osservare al microscopio i tessuti nervosi, essi dovevano essere sezionati in “fette” sottilissime e trattati con fissanti, che all’epoca erano principalmente alcol e acido cromico, e coloranti, come il carminio. Tali tecniche, tuttavia, non permettevano risultati ottimali. A rivoluzionare l’osservazione del tessuto nervoso sarebbe stata proprio la “reazione nera” di Golgi, “ricetta” elaborata in seguito ai numerosi tentativi condotti nella cucina/laboratorio di Abbiategrasso.
Mi valsi ancora dell’acido osmico, che è, massime pel sistema nervoso, uno dei reagenti più preziosi, perché senza indurre alterazioni di forma e di rapporto degli elementi, indura in poche ore i tessuti, colorando altresì in nero intenso il grasso e le fibre nervose, ed in bruno più o meno carico, gli altri elementi, ed esclusi l’alcol, il quale per lunga esperienza si è dimostrato affatto inopportuno per lo studio dei tessuti nervosi.
ricorda il ricercatore pavese nei suoi scritti. Non fu sufficiente. Solo dopo numerose prove, Golgi capì che poteva ottenere l’agognato risultato immergendo il tessuto nervoso in una soluzione di bicromato di potassio e, in successione, di nitrato d’argento. Al microscopio, era finalmente possibile osservare le cellule e le fibre nervose, che si stagliavano con il loro profilo nero su fondo chiaro.
Su tale scoperta si sono diffuse svariate leggende, secondo le quali la “reazione nera” sarebbe stata frutto di uno straordinario colpo di fortuna. Alcune fonti raccontano che il ricercatore, con una gomitata, rovesciò per errore la soluzione d’argento sui campioni di tessuto cerebrale; altre, che un inserviente buttò per sbaglio un campione di tessuto cerebrale nella spazzatura dove qualche ora prima era stato gettato un campione di nitrato d’argento. In entrambi i casi, Golgi avrebbe deciso di riutilizzare ugualmente i campioni, osservando con grande stupore lo spettacolo che si palesava alla sua osservazione al microscopio. Non è possibile essere certi della veridicità di tali episodi che, per quanto suggestivi, sono abbastanza improbabili. Ciò che è certo è che, indipendentemente da come tale scoperta sia realmente avvenuta, la sua portata scientifica era enorme: nessun’altra metodica dell’epoca consentiva una tale osservazione del tessuto nervoso. Dal perfezionamento di essa, ebbero inizio le moderne ricerche sulla struttura istologica del sistema nervoso e delle unità di cui è composto.
Annunciata per la prima volta nel 1873, la scoperta della “reazione nera” venne descritta più dettagliatamente l’anno successivo sulla Gazzetta Medica Italiana.
Benché Golgi fu il primo ad avere l’occasione di osservare distintamente le cellule nervose, tinte di nero, e le loro ramificazioni, che solo decenni più tardi sarebbero stati battezzate con il nome di assoni e dendriti, ne trasse alcune conclusioni errate. Con i limiti della metodica, i dendriti e gli assoni erano ben visibili, ma sembravano formare intrecci ininterrotti, senza alcuna soluzione di contiguità l’uno con l’altro. Era, per il ricercatore pavese, una conferma alla teoria reticolare del sistema nervoso.
A dare una svolta, affermando l’individualità delle cellule nervose come elementi costitutivi del tessuto cerebrale sarà proprio il ricercatore spagnolo Cajal, che per molti anni diventerà per Golgi un avversario, seppur stimato, nel panorama scientifico europeo.
Cajal, medico reduce da un’esperienza militare nella guerra di Cuba, rientrò nel 1875 in Spagna e proprio allora iniziò a dedicarsi alla ricerca scientifica. Caratterizzato sin da giovanissimo da un’indole creativa, impulsiva e appassionata, decise di comprare l’attrezzatura necessaria per l’attività di laboratorio con la paga da militare, dividendosi negli anni successivi tra le università di Madrid e Barcellona.
Non facevo altro che curiosare senza metodo. Mi si offriva un campo meravigliosamente ricco di scoperte ed esplorazioni, pieno di grandi sorprese. Con questo spirito ho esaminato i globuli del sangue, le cellule epiteliali, i corpuscoli muscolari e i nervosi, fermandomi qui o là per disegnare o fotografare le scene più accattivanti della vita degli infinitamente piccoli.
ricorda Cajal nei suoi scritti. Fu nel 1887 che, per la prima volta, nel rudimentale laboratorio allestito nella casa di un collega e amico, lo psichiatra Dott. Simarro, osservò alcuni campioni di tessuto nervoso trattati con la reazione nera di Golgi.
A partire da quell’osservazione, Cajal iniziò a usare il metodo di Golgi nel suo laboratorio, effettuando via via delle modifiche. Variò la durata di immersione del tessuto nella soluzione a seconda della struttura nervosa che desiderava studiare e delle caratteristiche dell’animale a cui apparteneva il tessuto.
Fu grazie a tali modifiche che poté osservare il tessuto nervoso con una definizione ancora maggiore. Grazie al suo talento artistico, ostacolato in giovinezza dalla famiglia che nutriva per lui l’aspirazione di una carriera medica, poté riprodurre fedelmente ciò che osservava al microscopio in centinaia di splendidi disegni effettuati a mano. Con il perfezionamento della ”reazione nera” di Golgi, Cajal osservò che alcuni assoni, benché molto vicini a quelli contigui, terminavano liberamente, senza connessione diretta con altre fibre nervose. Nel 1889, il ricercatore concluse che le cellule nervose, cosi come quelle di altri tessuti, erano unità indipendenti tra loro. Era la conferma della teoria cellulare del sistema nervoso.
I risultati dei suoi studi, tuttavia, faticavano a espandersi oltre i confini spagnoli. Pertanto, nel 1889, Cajal decise di partecipare ad un prestigioso congresso a Berlino, pagando di propria tasca le spese poiché l’università rifiutò di finanziarlo. Tra gli organizzatori dell’evento, vi era un autorevole studioso dell’epoca: Wilhelm von Waldeyer, direttore dell’istituto di anatomia dell’Università di Berlino. Impressionato dagli studi di Cajal, Waldeyer si dedicò a condurre una rassegna della ricerche sino ad allora effettuate sulle cellule nervose. Ne scaturì, nel 1891, la pubblicazione di una lunga opera in sei parti, in cui, per la prima volta, le più importanti cellule del sistema nervoso venivano battezzate con il nome con cui le conosciamo: neuroni. Essi venivano definiti come unità elementari e indipendenti le une dalle altre. La teoria cellulare, grazie agli studi di Cajal e all’opera di Waldeyer, diventava la “teoria del neurone”. Ben presto, anche le ramificazioni di fibre nervose che originavano dal corpo del neurone ebbero un nome: Wilhelm His denominò nel 1890 col nome di “dendriti” le fibre che conducono l’impulso nervoso dalla periferia verso il corpo cellulare; nel 1896 Albrecth von Kolliker denominò “assoni” quelle che lo conducono dal soma cellulare alla periferia. Nonostante le evidenze a supporto della teoria del neurone e l’ampia adesione da parte della comunità scientifica, alcun fieri oppositori continuavano ad osteggiarla. Golgi, che nel frattempo aveva fornito altri autorevoli e poliedrici contributi alla ricerca scientifica, descrivendo cellule gliali come gli astrociti, identificando il “reticolo di Golgi” all’interno della cellula, i recettori muscolo-tendinei denominati “organi di Golgi” e quelli cutanei denominati “corpuscoli Golgi–Mazzoni”, chiarendo alcuni aspetti della struttura anatomica del rene e del ciclo di replicazione del Plasmodium responsabile della malaria, su una questione non transigeva: a suo parere, gli assoni erano uniti gli uni agli altri e per anni continuò a battersi per far valere la teoria reticolare.
La diatriba non si placò neppure quando venne annunciato che i due studiosi antagonisti, Golgi e Cajal, avrebbero condiviso il premio Nobel per la medicina, l’uno per l’invenzione del metodo della “reazione nera”, l’altro per averla sfruttata stabilendo la struttura e funzione del neurone.
Che crudele ironia del destino da accoppiare, come gemelli siamesi uniti alle spalle, avversari scientifici dai caratteri così contrastanti.
commenterà Cajal nei suoi scritti. La cerimonia si svolse nel 1906, lo stesso anno in cui anche l’italiano Giosuè Carducci ritirò il premio Nobel per la letteratura. Persino tale occasione diventò pretesto per i due studiosi per difendere le rispettive teorie, sferrando attacchi a quella antagonista nei rispettivi discorsi di ringraziamento.
Se la teoria cellulare del neurone era ormai predominante, vi era un grosso interrogativo a cui doveva ancora rispondere. Se l’informazione nervosa viaggia lungo dendriti e assoni e questi non sono uniti tra loro, come può il segnale passare da un neurone all’altro in breve tempo, trasferendo l’informazione anche su lunghe distanze? La teoria reticolare, proclamando la continuità delle fibre nervose l’una con l’altra, su questo aspetto era in vantaggio. Entrambe, tuttavia, non rispondevano a un’altra spinosa questione: come nasce e si propaga il segnale nervoso?
A dare una risposta a entrambe le domande, sarebbe stata un’altra coppia di studiosi che, ironia della sorte, condivisero a loro volta il premio Nobel per la medicina nel 1932: si trattava dei britannici Edgar Douglas Adrian e Charles Scott Sherrington. Il primo identificò nell’attività elettrica il meccanismo alla base della trasmissione dell’impulso nervoso del neurone, il secondo chiarì come tale impulso venisse trasmesso tra due o più neuroni.
L’idea che l’attività elettrica rappresenti la modalità di trasmissione dei segnali nervosi era già presente dal 1700 e seguiva la lunga tradizione scientifica italiana di studiosi come GianBattista Beccaria, Luigi Galvani, Leopoldo Nobili. Le loro teorie, tuttavia, furono in gran parte criticate e ignorate dagli altri autorevoli ricercatori europei per oltre due secoli. Fu necessario attendere sino al 1928 affinché, grazie ad Adrian, l’attività elettrica potesse essere legittimamente riconosciuta alla base dell’impulso nervoso. Nel suo celebre esperimento, il medico inglese isolò pochi assoni da un nervo del collo di un coniglio e pose un elettrodo a contatto con essi. L’elettrodo, ogni volta che il coniglio emetteva un respiro, registrava attività elettrica, che veniva convertita in un segnale sonoro simile a un crepitio mediante un amplificatore. Ogni crepitio corrispondeva all’ impulso elettrico utilizzato dal neurone per trasmettere il segnale e “dialogare” con i neuroni vicini: il potenziale d’azione. Oggi sappiamo che il potenziale d’azione si crea poiché ciascun neurone ha una carica elettrica sempre presente, il “potenziale a riposo”. Il potenziale a riposo è garantito dalla struttura del neurone che, come una batteria, presenta da un lato una carica elettrica positiva fuori dalla membrana che lo riveste, e dall’altro una carica negativa, all’interno della cellula. La carica positiva o negativa è data dal prevalere di atomi dotati di carica elettrica, gli ioni, tra i due lati della membrana. Quando arriva uno stimolo al neurone, si verifica un cambiamento della concentrazione degli ioni dai due lati della membrana e, di conseguenza, della carica elettrica. In particolare, se lo stimolo è eccitatorio, la differenza di carica elettrica si riduce: si ha così il fenomeno chiamato “depolarizzazione”. Superato un determinato valore “soglia” di depolarizzazione, si ha il “potenziale d’azione”: manifestazione elettrica dell’impulso nervoso, rappresenta la modalità con cui i neuroni diffondono i loro messaggi.
In uno studio successivo sul rospo, Adrian registrò gli impulsi elettrici, li amplificò e li convertì graficamente, visualizzandoli come “picchi” appuntiti. Osservando i picchi, scoprì i potenziali d’azione di un dato neurone erano tutti uguali per ampiezza e durata, indipendentemente dall’intensità dello stimolo: ciò che variava era la loro frequenza.
Adrian descrisse pertanto come gli impulsi nervosi, così generati ad alta o bassa frequenza, si propagano lungo l’assone, a partire dal corpo cellulare del neurone sino alla sua estremità, “come una fiamma lungo una miccia accesa”. La “miccia” percorre l’assone per tutta la sua lunghezza e può viaggiare anche per percorsi piuttosto lunghi. Tuttavia, se come sostenuto dalla teoria del neurone, gli assoni non sono uniti l’uno all’altro, com’è possibile la loro propagazione tra diversi neuroni?
La risposta verrà fornita da quello che per molti viene riconosciuto come il “filosofo del sistema nervoso”, Charles Scott Sherrington, ed ha un nome preciso: sinapsi.
Sinapsi, termine utilizzato per la prima volta proprio dal medico inglese, significa “giunzione”, “unione”, e rappresenta la connessione funzionale tra due neuroni attraverso la quale viene trasmesso il segnale nervoso. All’epoca di Sherrington, si parlava di struttura “funzionale” poiché l’esistenza dello spazio sinaptico fu confermata e osservabile strutturalmente solo nei decenni successivi, in seguito all’avvento del microscopio elettronico.
A livello della sinapsi, i neuroni dialogano tra loro mediante una stupefacente trasformazione del messaggio, che da impulso elettrico diventa segnale chimico.
Come era accaduto per la teoria cellulare e la teoria reticolare, anche la teoria elettrica e chimica del segnale nervoso furono per lungo tempo dibattute e apparivano inconciliabili alla maggior parte degli studiosi.
A conciliare tali teorie sarebbe stato il contributo scientifico di una terza coppia di scienziati e premi Nobel per la medicina nel 1936: Otto Loewi e Henry Dale. Gli esperimenti di Loewi sul cuore di rana evidenziarono come ad uno stimolo elettrico, veicolato lungo l’assone, seguiva il rilascio di una sostanza chimica in grado di trasmettere il “messaggio” tra due neuroni e tra neurone e muscolo con conseguenze tangibili: il cuore di rana, a seconda dello stimolo elettrico e della sostanza chimica rilasciata di conseguenza, accelerava o rallentava il suo battito. Henry Dale, identificò due sostanze coinvolte nella comunicazione a livello sinaptico: la noradrenalina e l’acetilcolina. Essi vennero definiti neurotrasmettitori, per il loro ruolo nella trasmissione dell’informazione nei tessuti nervosi. A seguire, tra gli anni ’30 e gli anni ’50, furono identificati altri neurotrasmettitori e chiarite le loro funzioni: il glutammato e la glicina, ad effetto eccitatorio; la serotonina, coinvolta nel tono dell’umore; l’acido gamma-amino butirrico (GABA), inibitorio; la dopamina, coinvolta nel circuito del piacere e del movimento. I segnali, che viaggiano attraverso differenti circuiti cerebrali coinvolgendo numerosi neuroni e differenti sinapsi, vengono veicolati mediante una sequenza di impulsi elettrici e di neurotrasmettitori, che, come in una somma algebrica a cascata, vanno a sommarsi o a sottrarsi tra loro, in una miriade di configurazioni differenti.
Nei decenni che seguirono tali scoperte, nuovi studi hanno ulteriormente chiarito i meccanismi che regolano la comunicazione tra neuroni e i loro circuiti a livello del sistema nervoso, mettendo in luce, d’altro canto, una inaspettata complessità, che ancor oggi non è stata completamente decifrata.
Intuendo il fascino e la grandiosità di tale complessità, lo stesso Sherrington scrisse poeticamente:
Come una Via Lattea che entri in una specie di danza cosmica, il cervello è come un telaio incantato, in cui milioni di spolette lampeggianti intessono una configurazione che si dissolve, sempre significativa, ma mutevole, una mobile armonia di subconfigurazioni.