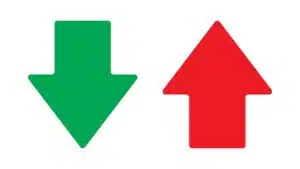Qualche mese fa eravamo in compagnia di due colleghi comportamentisti e a uno dei due scapparono le parole “alleanza terapeutica” e “relazione terapeutica”. Prontamente l’altro lo corresse, dicendo che era preferibile utilizzare “formulazione del caso”. La puntualizzazione del secondo collega potrebbe sembrare una pedantesca difesa identitaria. Oppure no. Vediamo perché.
Sandra Sassaroli, Gabriele Caselli e Giovanni M. Ruggiero
Le terapie cognitive comportamentali hanno sempre intrattenuto con i concetti di alleanza e relazione terapeutica un rapporto pragmatico, preferendo chiamarle spesso con altri nomi più operativi (Bruch, 1998, 2015). Tra questi, il termine più significativo e coerente con il paradigma cognitivo-comportamentale è quello di “formulazione del caso” oppure -sottolineando maggiormente gli aspetti di relazione terapeutica e alleanza terapeutica– di “formulazione condivisa del caso”. Oggi questo strumento è ormai ampiamente praticato nel campo delle terapie comportamentali e cognitive (Eells, 2007, 2009; Sturmey, 2008, 2009).
La formulazione del caso comportamentista di Monte Shapiro
In realtà il termine “formulazione del caso” è stato definitivamente introdotto solo nel 1985 grazie a Turkat (1985, 1986), ma esso era presente nel lavoro della maggior parte dei pionieri delle terapie cognitive e comportamentali: ad esempio in Monte B. Shapiro (1955, 1957) (Shapiro & Nelson, 1955), Lazarus (1960), Meyer (1960), Wolpe (1960) e Yates (1960). Tra tutti spicca il contributo di Meyer. Perché? Perché negli altri autori, e in particolare in Shapiro, la formulazione del caso non conteneva in sé alcun elemento di accordo e condivisione con il paziente, ovvero –volendo usare una terminologia psicodinamica- la formulazione era relazionalmente vuota e non portava a un’alleanza di lavoro. Shapiro realizzava la formulazione del caso dapprima intervistando i pazienti per ottenere una descrizione precisa del loro comportamento problematico. Successivamente, sulla base di modelli teorici di apprendimento si formulavano delle previsioni sulle reazioni comportamentali dei pazienti a determinati stimoli, previsioni che erano testate in esperimenti clinici e che portavano infine alla formulazione di un piano terapeutico fatto di ripetuti esperimenti comportamentali. Insomma, Shapiro otteneva dati dal paziente ma non li riformulava al paziente, non cercava il suo assenso ne gli chiedeva di utilizzare la formulazione come base per un lavoro comune. Un simile metodo poteva effettivamente esporsi all’accusa, fatta varie volte ai comportamentisti, di trattare i pazienti come cani ammaestrati.
La formulazione del caso condivisa con il paziente di Victor Meyer
Completamente diverso l’approccio di Victor Meyer (1975). Il suo intenso impegno clinico con i pazienti affetti da disturbo ossessivo compulsivo gli consentì di comprendere il ruolo cruciale dell’intervista col paziente come esperienza individuale. Era critico nei confronti di schemi standardizzati come ad esempio quello di Kanfer e Saslow (1969). Secondo Meyer, invece di aderire rigidamente a uno schema, i terapeuti devono essere incoraggiati a sviluppare ipotesi sulla natura del problema e a discuterli e condividerli con il paziente (Meyer, 1975, p. 22). In altre parole, Meyer pone l’enfasi sulla comprensione e sulla condivisione del problema del paziente, spiegandogli la logica, cercando la cooperazione e quindi costruendo la risoluzione e la motivazione per il programma di trattamento. È chiara quindi la stretta relazione tra approccio di Meyer e relazione terapeutica, però da un punto di vista rigorosamente cognitivo e comportamentale che nulla deve al modello psicodinamico, come spesso accade nei modelli integrati cognitivo-interpersonali (Meyer e Liddell, 1975, p. 237).
Insomma, Meyer condivideva la formulazione del caso con il paziente. Dopo aver raccolto i dati sulle situazioni problematiche del paziente, egli formulava il caso nei suoi termini di antecedenti, risposte comportamentali e conseguenze e lo proponeva al paziente, discutendolo con lui. Questa discussione non era una trasmissione unidirezionale di informazioni dal clinico al paziente, ma avveniva su un piano paritario ed entrava a far parte del contesto terapeutico. La condivisione delle informazioni con il paziente diventa quindi essa stessa parte della modificazione ambientale e comportamentale perseguita dal clinico comportamentale per ottenere il cambiamento terapeutico. Questa modificazione, però non avveniva all’insaputa del paziente, ma coinvolgendolo, ovvero coinvolgendo i suoi stati mentali. È chiaro che, in tal modo, si agisce non solo in maniera esterna sulle reazioni comportamentali ma in maniera condivisa, alleata e relazionale. Esprimendoci nel linguaggio comportamentale, si agisce sui rule-governed behaviors.
Formulazione condivisa del caso vs relazione terapeutica
Si potrebbe obiettare: se è così, perché non adottare i termini di “alleanza terapeutica” e di “relazione terapeutica”? Perché ostinarsi su un termine più pragmatico e operativo come “formulazione condivisa del caso”? “Formulazione condivisa del caso” non è solo un termine tradizionale da usare distrattamente per abitudine ma fornisce informazioni pratiche sulla concezione cognitiva e comportamentale dell’alleanza terapeutica.
Invece “relazione terapeutica” è un termine estremamente ampio. I suoi difetti sono due: un rischio di vaghezza e di genericità, poiché “relazione” può indicare qualunque evento interpersonale che accade tra paziente e terapista; il secondo è la possibilità che in fondo esso non sia un termine neutro ma che invece esso sia più adatto a indicare le componenti più ambigue della relazione, meno sensibili al controllo volontario e meno accessibili all’alleanza esplicita. Insomma, la “relazione terapeutica” non è l’alleanza terapeutica.
Alleanze e sabotaggi: i presupposti teorici che orientano le terapie
Non si tratta di una differenza solo tecnica ma teorica: la formulazione del caso di tradizione comportamentale parte dal presupposto che l’alleanza è sempre possibile e che essa si stipuli a partire dai suoi aspetti pratici e operativi, appunto la condivisione della formulazione. In altri paradigmi, come forse in alcune forme di terapia psicodinamica, si parte dal presupposto che il paziente tendenzialmente saboti la terapia e che il lavoro terapeutico consista proprio nella analisi e nella gestione relazionale di questo sabotaggio, che è interiore ma che si manifesta soprattutto nella relazione. Seguendo questo paradigma, la concettualizzazione del caso non è mai davvero onestamente condivisibile da parte del paziente e la sua formulazione esplicita è sempre un inganno. Una rassegna esaustiva di questo paradigma si può trovare nel bel libro “I sabotatori interni” di Francesco Gazzillo (2012).
In una versione meno estrema il paziente non sabota la terapia e non inganna il terapista, ma comunque non ha, almeno inizialmente, le capacità relazionali per riuscire a eseguire un’alleanza soddisfacente. Il paziente è ritenuto un tipo difficile, ma non è un ingannatore. In questo caso il lavoro terapeutico non consisterebbe nel gestire i sabotaggi e gli inganni del paziente, ma le sue mancanze e i suoi deficit costruendo un compenso emotivo che andrebbe a coprire un deficit relazionale di base. Si tratta effettivamente di una teoria del deficit. Quello che colpisce è che in entrambi i casi il terapista lavorerebbe soprattutto nella relazione e la utilizza in una maniera non condivisa –o almeno non completamente condivisa- con il paziente, ovvero senza comunicare del tutto il senso del suo lavoro. Tutto accade prima nella relazione e nella costruzione dell’alleanza. Nella formulazione comportamentale condivisa del caso e quindi dell’alleanza terapeutica, invece, tutto inizia con la stipulazione onesta del patto terapeutico.
Inoltre ci sembra innegabile che una visione che privilegia la relazione prima dell’alleanza rischierebbe di scivolare in una relazione non paritaria tra un soggetto che agisce in modo implicito sulla relazione da una posizione di supremazia di esperto conoscitore della relazione che non spiega e condivide del tutto cosa sta facendo e a quale scopo.
Naturalmente è innegabile che esistano pazienti che sabotano la terapia o con i quali occorre effettuare un lavoro più di supporto che di vera terapia, in attesa che si creino le condizioni per effettuare il lavoro terapeutico. E comunque nel nostro approccio anche questo aspetto può essere onestamente esplicitato. L’aspetto dirimente è considerare questo lavoro preparatorio o semmai necessario in casi speciali con pazienti molto sofferenti con gravi deficit di mentalizzazione, oppure il vero centro di ogni terapia. Si tratta di visioni della mente, dell’uomo e del mondo differenti.