Giochi evergreen: le motivazioni sociali dietro al successo senza tempo di RiSiKo! Lego e Monopoli
Un articolo di Giancarlo Dimaggio, pubblicato sulla “Lettura” del “Corriere della Sera” di domenica 9 marzo 2014

Alcuni giochi, come RisiKo!, Monopoli, Lego, continuano a impegnare le nostre giornate, malgrado la concorrenza spietata dei videogame. Li ricordiamo nella nostra infanzia. I figli ce li chiedono. Ci giochiamo insieme. Mi chiedo: cosa ha permesso loro di resistere nel tempo? Di mantenere tenacemente il loro posto nell’immaginario? Di ampliarlo anche.
Il messaggio è giunto. Invaderò il Congo. Ho l’Africa Orientale, ma voglio espandermi, le mie risorse di coltan sono insufficienti. Mi braccano, sveleranno presto le mie intenzioni. Fingo di attaccare la Scandinavia. Lì sono ricchi, hanno civiltà, servizi sociali che funzionano. Che io voglia conquistarla è credibile. La strategia paga. Gli avversari ci cascano. Presto avrò quello in cui altri – miseri – hanno fallito: possedere Nord America e l’Africa tutta.
L’adrenalina pompa, ho bisogno di ingrandirmi. Sono pronto all’azione. A carri armati schierati, tiro i dadi. Il mio volto è impassibile. Formo alleanze mute, destinate da lì a poco a rompersi. Tradirò, sarò tradito, me lo aspetto. Giocare a RisiKo! ti fa ragionare così. Ti prende quella voglia di invadere paesi e dominare il mondo. Per inciso, se sapete cos’è il coltan, o fabbricate cellulari, o siete ricercati dalla polizia, o avete letto Il leopardo di Jo Nesbø.
Sabato pomeriggio. Mio figlio protesta. Ritiene le pressioni della sorella maggiore a cederle Largo Colombo ingiuste, prepotenti. Mia figlia, testarda, insiste. Cerca di blandirlo, lo accusa di immaturità ma lui niente, non vende. Intervengo. Non per interesse personale. Che mia figlia non acquisti Largo Colombo conviene anche a me, ma non è questo ad influire sulla mia decisione. Semplicemente, disapprovo che forzi la volontà del fratello, mi schiero apertamente con lui. Costruisco la seconda casa su Viale Giulio Cesare.
Ora, avete diritto di pensare che: uno, chi scrive sia un pessimo genitore (possibile). Due, sia patriarca di una famiglia di palazzinari. Entrambe le vostre ipotesi però dimostrano irrefutabilmente che: avete vissuto fuori dal mondo e non conoscete il Monopoli. Vi manca quindi la consuetudine con la sensazione inebriante di possedere case, alberghi, quartieri interi. Accumulare denaro. Il piacere di incassare pacchi di soldi quando gli altri passano da Parco della Vittoria con tre case già su.
Papi, prendi la pedana. Sì, amore. Quella verde. Sì amore, quella verde. Costruiamo un recinto. Mattoncini gialli e blu diventano un lago. Un elefante beve, tranquillo malgrado i leoni. La zebra passeggia. Amore, ma la zebra dovrebbe essere preoccupata. No, papi, il leone ha già mangiato ed è buono, mi dai la parete? Quella con la finestra? Sì. Mia figlia aveva due anni. Con i Lego abbiamo costruito uno zoo in Africa – della quale ormai sono proprietario –. La casa del guardiano è pronta, gli animali parlottano. Pochi anni dopo. Il progetto si fa difficile, alta ingegneria. L’astronave di Star Wars. Ci sono i pezzi trasparenti, vetri di plastica azzurra. Da piccolo me li sarei sognati. Qui c’è meno da inventare. I pezzi sono per dita da bambino, ma riesco a maneggiarli. Mio figlio mi fa lavorare. Ogni tanto mette un pezzo lui. È soddisfatto. Un anno dopo c’è da tirare su la stazione di polizia. Caso mai passasse Harry Hole (Avete letto Nesbø? Sapete chi è). Le cose sono cambiate. Segue lui le istruzioni. Non devo interferire, ma mi vuole lì. Ogni tanto mi chiede una mano, poi riprende il comando. Vorremmo mandare un’email in Danimarca e chiedere perché manca quel pezzo. Che in realtà c’è, minuscolo, e non lo avevamo visto.
Dove voglio arrivare? Alcuni giochi, come RisiKo!, Monopoli, Lego, continuano a impegnare le nostre giornate, malgrado la concorrenza spietata dei videogame. Li ricordiamo nella nostra infanzia. I figli ce li chiedono. Ci giochiamo insieme. Mi chiedo: cosa ha permesso loro di resistere nel tempo? Di mantenere tenacemente il loro posto nell’immaginario? Di ampliarlo anche.
Domenica scorsa abbiamo visto Lego Movie. Ha già incassato 300 milioni di dollari (soldi veri, non del Monopoli).
Per rispondere mi appello a Darwin e agli psicologi evoluzionisti. Gli umani agiscono guidati da motivazioni primarie, che hanno permesso sopravvivenza, adattamento alla nicchia ambientale e consolidamento della società. Motivazioni arcaiche quali: sessualità, rilevare i pericoli, difendere il territorio, reagire con attacco/fuga/congelamento all’aggressione. Poi motivazioni sociali, da mammiferi evoluti.
John Bowlby ha descritto l’attaccamento: il bisogno di rivolgersi a figure forti solide e rassicuranti in momenti di paura, fragilità, fame, freddo, sonno. La motivazione complementare: prestare cure a chi, in difficoltà, chiede aiuto con segnali chiari e riconoscibili (pianto, occhioni sgranati).
Studiosi come gli psicoterapeuti cognitivisti Paul Gilbert, Università di Derby, e Giovanni Liotti di Roma, Joseph Lichtenberg, psicoanalista a Washington, e lo psicobiologo Jaak Panksepp, università di Washington, includono tra le motivazioni sociali:
1) agonismo e bisogno di mantenere e accrescere la propria posizione nel rango sociale. La posizione nella gerarchia garantisce priorità di accesso alle risorse limitate – cibo, partner per l’accoppiamento – o quantomeno sicurezza che verrà il nostro turno;
2) esplorazione autonoma del territorio e formazione di un senso di efficacia personale;
3) appartenenza al gruppo;
4) cooperazione tra pari per il raggiungimento di scopi condivisi;
5) giocare!
Vediamo se funziona. I giochi che resistono alla competizione con i videogame (oltre che ben fatti) attivano, nella modalità del gioco di finzione, queste motivazioni primarie.
RisiKo!: difesa del territorio ed esplorazione oltre il confine, definizione del rango, accesso a risorse limitate. Formazione di alleanze per raggiungere lo stesso obiettivo (fare fuori un altro avversario).
Monopoli: in altra forma tocca più o meno le stesse corde.
Per il Lego è diverso. All’interno di interazioni cooperative con l’adulto, quei mattoncini costruiscono le basi di agency, il senso di iniziare con successo un’azione nata da un motore interno, e autonomia.
Michael Tomasello, co-direttore del Max Planck Institute, direbbe che giocando a Lego con i figli consolidiamo l’intenzionalità condivisa, un processo partito già dalle primissime fasi di vita.Funziona così: il bambino ha una meta. Mettere il leone lì. Coinvolge l’adulto. L’adulto esegue, ma introduce una variazione minima. Il bambino discute, ci si accorda. Vicino al leone: una palma che piace a entrambi. Si è formata una rappresentazione cognitiva dialogica che include: il proprio scopo, quello dell’altro e il processo di negoziazione per sintonizzarsi e raggiungere l’obiettivo comune. Se l’interazione ha successo il bambino è contento e si sente capace, attivo. Capisce meglio la mente dell’altro.
Quali giochi innescano attaccamento e accudimento? Facile. Barbie. Polly. Credo che Cicciobello sia in salute. Ancora: l’appartenenza al gruppo? In edicola. Figurine dei calciatori. Infine, per verificare se l’ipotesi darwiniana tiene, mi chiedo: cosa mancava ai giochi estinti? Le ipotesi alternative sono molte.
Mentre tento una risposta accendiamo la Wii. Super Mario. I miei figli mi battono spietatamente. Ma anche il loro Mario, saltando da un dado all’altro tra le nuvole, cade nel vuoto. Non celo un sorriso di soddisfazione.
ARGOMENTI CORRELATI:
BIBLIOGRAFIA:
- John Bowlby. Attaccamento e perdita. Bollati Boringhieri.
- Paul Gilbert. La terapia focalizzata sulla compassione. Franco Angeli.
- Joseph Lichtenberg. Psicoanalisi e sistemi motivazionali. Raffaello Cortina
- Giovanni Liotti e Fabio Monticelli. I sistemi motivazionali nel dialogo clinico. Raffaello Cortina.
- Michael Tomasello. Le origini della comunicazione umana. Raffaello Cortina





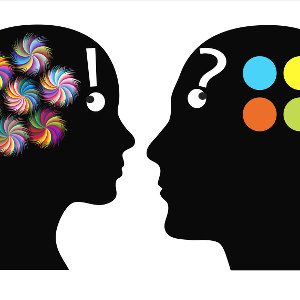 Dopo anni e anni di ricerca volta ad individuare le differenze esistenti tra l’uomo e la donna ora ci sono le prove!
Dopo anni e anni di ricerca volta ad individuare le differenze esistenti tra l’uomo e la donna ora ci sono le prove! Resta infine da delineare quali sono gli stati mentali che orbitano intorno all’attaccamento rigido a un sogno. Questi possono essere considerati degli stati transitori che assumono coloriture differenti in relazione al periodo di vita o talvolta anche al momento della giornata.
Resta infine da delineare quali sono gli stati mentali che orbitano intorno all’attaccamento rigido a un sogno. Questi possono essere considerati degli stati transitori che assumono coloriture differenti in relazione al periodo di vita o talvolta anche al momento della giornata. La selettività nel consumo dei cibi insieme ad altre difficoltà legate all’alimentazione rappresenta un problema epidemico tra i bambini con disturbi dello spettro autistico.
La selettività nel consumo dei cibi insieme ad altre difficoltà legate all’alimentazione rappresenta un problema epidemico tra i bambini con disturbi dello spettro autistico. Il pensiero di Darwin, Popper e Foucault alla base del metodo scientifico che guida la Psicoterapia Cognitiva, la cui efficacia è empiricamente verificata.
Il pensiero di Darwin, Popper e Foucault alla base del metodo scientifico che guida la Psicoterapia Cognitiva, la cui efficacia è empiricamente verificata.






















 La Teoria della Gestione Coordinata dei Significati (Coordinated Management of Meaning – C.M.M.): gli eventi sociali vengono creati e ricreati attraverso i processi della comunicazione umana ed in cui la
La Teoria della Gestione Coordinata dei Significati (Coordinated Management of Meaning – C.M.M.): gli eventi sociali vengono creati e ricreati attraverso i processi della comunicazione umana ed in cui la

 La rimozione nel cervello: L’area parieto-temporale dell’emisfero destro ha il compito di elaborare le informazioni relative a noi stessi e a ciò che ci circonda, a rivolgere l’attenzione ai nostri vissuti in relazione al nostro contesto, quando questo ponte di collegamento viene interrotto la persona tende ad avere un funzionamento di tipo narcisistico che in situazioni gravi risulta essere nettamente evidente.
La rimozione nel cervello: L’area parieto-temporale dell’emisfero destro ha il compito di elaborare le informazioni relative a noi stessi e a ciò che ci circonda, a rivolgere l’attenzione ai nostri vissuti in relazione al nostro contesto, quando questo ponte di collegamento viene interrotto la persona tende ad avere un funzionamento di tipo narcisistico che in situazioni gravi risulta essere nettamente evidente. Questo libro rappresenta uno strumento molto valido per aiutare l’adulto, sia che si tratti di educatore che di genitore, a trovare le parole: nel linguaggio universale della narrazione condivisa viene regalato al bambino il “c’era una volta” della sua vita, una storia di emozione e di poesia, “la storia della notte in cui mamma e papà ti han fatto nascere sia nel corpo che nel cuore”.
Questo libro rappresenta uno strumento molto valido per aiutare l’adulto, sia che si tratti di educatore che di genitore, a trovare le parole: nel linguaggio universale della narrazione condivisa viene regalato al bambino il “c’era una volta” della sua vita, una storia di emozione e di poesia, “la storia della notte in cui mamma e papà ti han fatto nascere sia nel corpo che nel cuore”. “Un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, inermità, nulla”.
“Un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, inermità, nulla”. 

 Sempre più attuale e di validità euristica è l’integrazione tra le evidenze provenienti dalle
Sempre più attuale e di validità euristica è l’integrazione tra le evidenze provenienti dalle