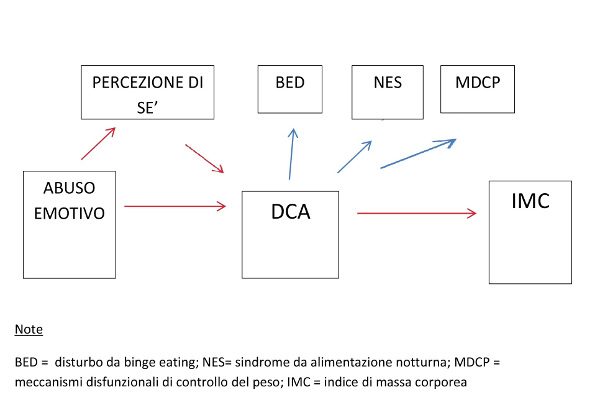Ammalarsi d’amore: la Dipendenza Affettiva
Il desiderio di amare e di essere amati è un bisogno sano e fondamentale, è associato ad emozioni positive e al benessere psicofisico, ma per alcune persone le relazioni affettive possono essere fonte di malessere, diventare una vera e propria droga ed avere delle conseguenze devastanti; quando ciò si verifica possiamo parlare di Dipendenza Affettiva.
Maddalena D’Urzo (Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma)
Il desiderio di amare e di essere amati è un bisogno sano e fondamentale, è associato ad emozioni positive e al benessere psicofisico, e dal punto di vista evoluzionistico consente la sopravvivenza dell’individuo e della specie.
In uno studio recente, pubblicato ad aprile in una rivista di psiconeuroendocrinologia, è stata esaminata la relazione che c’è tra stato civile e livelli di cortisolo (un ormone che aumenta nel nostro organismo quando siamo stressati) in un campione di 572 persone sane (uomini e donne di età compresa tra i 21 e i 55 anni sposate, divorziate, vedove, single). Dai risultati è emerso che le persone sposate hanno livelli di cortisolo più bassi rispetto agli altri soggetti che facevano parte del campione (Chin et al. 2017).
Quindi, in base a questo studio, i legami affettivi stabili hanno un’influenza positiva sulla salute ma per alcune persone le relazioni affettive possono essere fonte di malessere, diventare una vera e propria droga ed avere delle conseguenze devastanti; quando ciò si verifica possiamo parlare di Dipendenza Affettiva.
La Dipendenza Affettiva e i disturbi di personalità
Attualmente la Dipendenza Affettiva non è una patologia inclusa nel DSM V probabilmente perché, come per altre dipendenze comportamentali, mancano ad oggi degli studi che consentano di stabilire dei criteri diagnostici e delle indicazioni sul decorso necessari per identificarla come un disturbo mentale.
Al contrario nella pratica clinica spesso incontriamo pazienti che non riescono a interrompere relazioni intime profondamente distruttive, che generano sofferenza e compromettono la loro vita a vari livelli.
I pazienti con Disturbo Dipendente di personalità sono caratterizzati dalla dipendenza dagli altri, cioè sono incapaci di vivere in maniera autonoma e hanno sempre bisogno di consigli e rassicurazioni. Quando sono soli si sentono indifesi e senza punti di riferimento, vivono costantemente con il terrore di essere abbandonati dal partner.
Pur di scongiurare il temuto abbandono sono disposti a fare cose spiacevoli e degradanti (ad es. si fanno sfruttare economicamente o sessualmente, tollerano l’infedeltà e nei casi estremi la violenza). Ma la Dipendenza Affettiva non è appannaggio solo del Disturbo Dipendente; anche i pazienti con Disturbo Borderline di personalità hanno serie difficoltà a stare da soli e adottano comportamenti dipendenti (ad es. si mettono a completa disposizione del partner e lo idealizzano). Hanno relazioni affettive caotiche caratterizzate da una passione travolgente ma anche da discussioni violente; i pazienti con questo disturbo vivono con il terrore di essere abbandonati dal partner ma temono anche di dipendere da lui e di perdere la loro autonomia.
I pazienti con Disturbo Istrionico di personalità temono la solitudine e sono travolti dall’angoscia davanti alla separazione; hanno costantemente bisogno di attenzione, approvazione e sostegno.
Dipendenza Affettiva: quali analogie con la tossicodipendenza?
Esattamente come avviene nella dipendenza da sostanze anche nella Dipendenza Affettiva con il passare del tempo tutto inesorabilmente ruota intorno al partner; spesso la persona dipendente si chiude o evita volutamente gli altri nel tentativo di proteggersi dalle critiche o dal temuto abbandono.
Solitamente sia gli interessi che gli hobby vengono progressivamente abbandonati e il fulcro dell’esistenza diventa il partner; anche il rendimento lavorativo diminuisce perché la persona ha la mente costantemente occupata dai suoi problemi sentimentali e trascorre molto tempo a rimuginare per cercare di risolverli.
Nei casi estremi, per es. anche quando il partner è violento fisicamente, i pazienti dipendenti tendono a giustificarlo, si isolano, mentono o non chiedono aiuto pur di proteggerlo; spesso purtroppo non riescono a lasciarlo anche quando è a rischio la loro incolumità fisica. Generalmente, i pazienti con Dipendenza Affettiva sono consapevoli degli effetti devastanti che il partner ha nella loro vita, ma esattamente come i tossicodipendenti, non riescono ad astenersi dalla relazione.
Ma l’amore può essere considerato una droga? Effettivamente l’innamoramento e la tossicodipendenza hanno molte analogie; sia gli innamorati che i tossicodipendenti sperimentano:
- Intensa euforia quando vedono il partner simile all’euforia che caratterizza l’uso di una droga
- Craving (che è un desiderio spasmodico e irrefrenabile) per il partner o per la droga
- Tendenza a ricercare sempre più la vicinanza con il partner (fenomeno simile alla tolleranza un meccanismo che spinge i tossicodipendenti ad aumentare progressivamente la quantità di droga assunta abitualmente per ottenere l’effetto desiderato)
- Quando una relazione finisce le persone innamorate hanno dei sintomi d’astinenza che sono simili a quelli che si riscontrano nella sindrome d’astinenza dei tossicodipendenti (depressione, ansia, insonnia o ipersonnia, irritabilità, perdita dell’appetito o abbuffate) che, esattamente come avviene nella tossicodipendenza, portano alla ricaduta; ad es. nella Dipendenza Affettiva avere una ricaduta vuol dire cercare nuovamente il partner nonostante sia stato infedele, violento ecc. (Liebowitz, 1983; Hatfield & Sprecher, 1986; Meloy & Fisher, 2005).
Le analogie tra innamoramento e tossicodipendenza sono confermate anche dagli studi di neuroimaging (che visualizzano l’attività cerebrale in vivo). Questi studi dimostrano che l’innamoramento attiva alcune regioni cerebrali della via mesolimbica che è ricca di dopamina (una sostanza che viene liberata nel nostro cervello ogni volta che facciamo qualcosa di piacevole come per es. mangiare, fare sesso, accudire la prole ecc.). Il piacere che proviamo serve a motivarci a ripetere questi comportamenti e quindi a garantire la sopravvivenza dell’individuo e della specie. Come dimostrano numerose prove empiriche queste stesse regioni vengono attivate sia nella dipendenza da sostanze (Fisher et al. 2010; Acevedo et al. 2011; Xu et al. 2011) che nelle dipendenze comportamentali come lo shopping compulsivo (Knutson et al. 2007) e il gambling (Breiter et al. 2001).
Quindi per concludere le persone che soffrono di Dipendenza Affettiva si sentono inadeguate e non degne di essere amate e vivono costantemente con il terrore di essere abbandonate dal partner.
Sono sempre disponibili, accudenti, pronte a sacrificarsi e s’illudono, così facendo, di rendere la relazione stabile e duratura.
In realtà chi soffre di questo disturbo cerca disperatamente di essere amato da persone anaffettive quindi per definizione incapaci di amare; infatti è proprio il rifiuto che crea e alimenta la Dipendenza Affettiva: più il partner è sfuggente, freddo, distante, più la persona dipendente si sacrifica fino ad annullarsi, si colpevolizza, si mette in discussione e lo rincorre esattamente come fanno i giocatori d’azzardo che ”rincorrono la perdita” e non riescono a smettere di giocare.
A volte, a causa di un torto subito dal partner, la rabbia può momentaneamente spingere chi soffre di Dipendenza Affettiva a dire basta e a chiudere la relazione, ma inevitabilmente, i sintomi dell’astinenza (depressione e incapacità di provare piacere, ansia, sensazione di vuoto ecc.) spingono a perdonare il partner e a giustificarlo rientrando così nel circolo vizioso di una relazione tossica.
Si può guarire dalla dipendenza affettiva?
Il primo passo verso la guarigione consiste nell’essere consapevoli di avere un problema e quindi di avere bisogno dell’aiuto di un esperto per risolverlo.
Il trattamento che attuo con i pazienti con dipendenza affettiva è basato sulla Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) (Dimaggio, Montano, Popolo & Salvatore, 2013).
Il primo obiettivo, a breve termine, della TMI della Dipendenza Affettiva è affrontare e risolvere la sofferenza attuale del paziente in termini di sintomi e disfunzioni comportamentali.
Il secondo obiettivo, a lungo termine, consiste nell’affrontare le esperienze precoci di abbandono, di trascuratezza fisica ed emotiva, di maltrattamenti, abusi ecc. che generalmente sono alla base della convinzione di non valere nulla e di non essere degni di essere amati che caratterizzano i pazienti che soffrono di Dipendenza Affettiva. In parallelo, la terapia mira ad aiutare i pazienti ad avere accesso a quello che provano, ai loro desideri e ai loro scopi e a utilizzarli per compiere delle scelte autonome. In questo modo si ripara uno dei nuclei delle personalità dipendenti che è la carenza di agency, ovvero di portare avanti un piano d’azione che nasca all’interno, anche in condizioni di mancante supporto relazionale o di avversità.
Grazie a questo lavoro si creano le basi perché i pazienti possano da un lato formare relazioni affettive basate sulla reciprocità in cui sentirsi finalmente amati e accettati, o perché possano mantenere un senso di amabilità e valore personale, accompagnati da un senso di attività anche quando tali relazioni mancano.