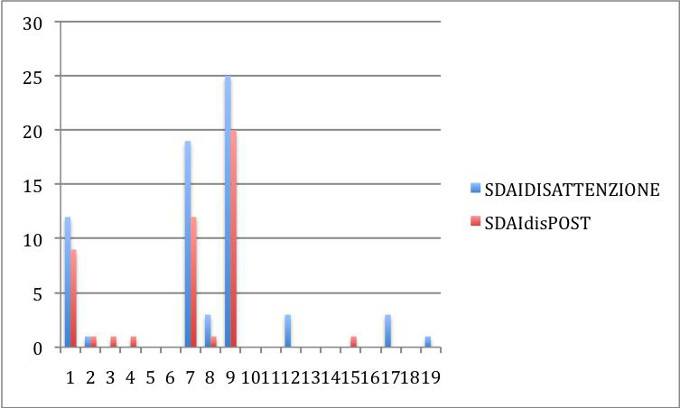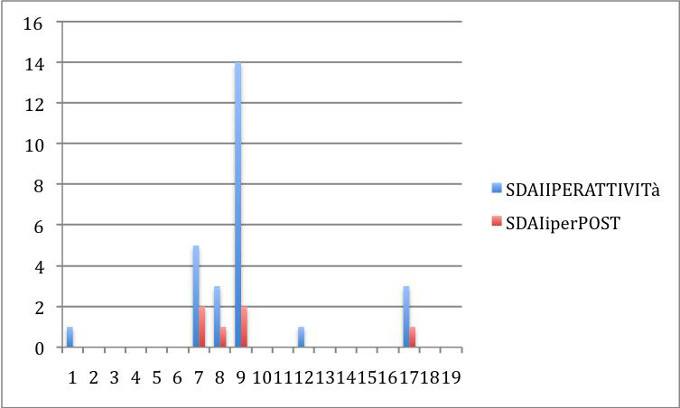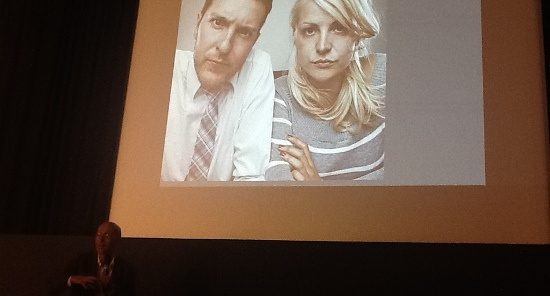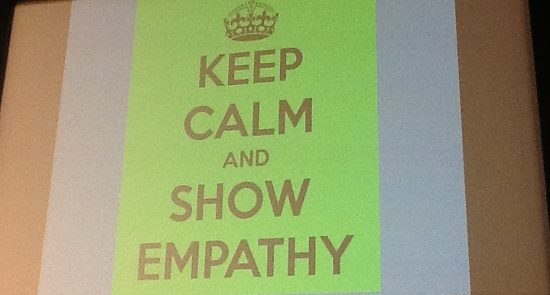L’accettazione dell’invecchiamento: una strategia protettiva in età avanzata
Accettazione dell’ invecchiamento: Un possibile modo per mantenere nelle ultime decadi di vita un’alta percezione di qualità della vita potrebbe essere quello di fare leva sull’accettazione psicologica, uno dei processi al centro dell’Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999, 2012). L’ACT è una terapia comportamentale che appartiene agli approcci emergenti di “terza generazione” della terapia comportamentale e cognitiva e che è stata sviluppata per trattare quei problemi psicologici in cui l’evitamento – strategia di coping fallimentare nel lungo periodo – riveste un ruolo chiave.
Lucia Pomoni, OPEN SCHOOL STUDI COGNITIVI DI MILANO
L’invecchiamento della popolazione ed i suoi effetti
Stiamo invecchiando. Oggi più che mai. Mentre all’inizio del ‘900, donne e uomini occidentali vivevano all’incirca fino a, rispettivamente, 48 e 45 anni (Hansen, 2013; Kinsella, 1992), nel 2014 l’aspettativa di vita alla nascita di una donna ha raggiunto gli 83.6 anni, quella di un uomo i 78.1 anni (Eurostat, 2016a). Questo pattern di longevità prolungata, insieme ai bassi livelli di fertilità degli ultimi decenni, ha dato vita ad un vero e proprio cambiamento demografico (Rossini & Marra, 2014), responsabile di un invecchiamento della popolazione: in Europa, nell’ultima decade (2005-2015), si è verificato un incremento del 2.3 % di persone anziane, ovvero di coloro che hanno 65 e più anni (Eurostat, 2016b).
L’aumento repentino di individui che vivono più a lungo ha spostato l’attenzione alle generazioni di età avanzata. Queste si trovano a dover far fronte a cambiamenti fisici e psicologici che, in aggiunta a fattori ambientali e socio-economici, possono minare la loro efficienza ed il loro benessere (Ajmone Marsan et al., 2014). Il trascorrere degli anni, infatti, è associato ad un peggioramento nella salute fisica e mentale che può però essere rallentato da interventi che promuovono il benessere e migliorano la qualità della vita dei soggetti anziani (Clark et al., 2012; Diener & Chan, 2011).
L’accettazione: costrutto cardine dell’Acceptance and Commitment Therapy
Un possibile modo per mantenere nelle ultime decadi di vita un’alta percezione di qualità della vita potrebbe essere quello di fare leva sull’accettazione psicologica, uno dei processi al centro dell’Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999, 2012).
L’ACT è una terapia comportamentale che appartiene agli approcci emergenti di “terza generazione” della terapia comportamentale e cognitiva e che è stata sviluppata per trattare quei problemi psicologici in cui l’evitamento – strategia di coping fallimentare nel lungo periodo – riveste un ruolo chiave.
Essa mira a incrementare la flessibilità psicologica (capacità di prendere consapevolezza del momento presente e di persistere o modificare il comportamento in vista di scopi valoriali) ed a promuovere un cambiamento comportamentale coerente con valori personalmente importanti mediante l’impiego di una serie di tecniche, tra cui appunto l’accettazione (Hayes et al., 1999). L’accettazione è un’abilità psicologica positiva che favorisce l’azione guidata dai valori e che contrasta l’evitamento esperienziale, coinvolto in numerosi disturbi e problemi clinici (Hayes, Masuda, Bissett, Luoma, & Guerrero, 2004).
Accettare (dal latino “capere”, ossia “prendere”) non significa tollerare o rassegnarsi (Kanter, Baruch, & Gaynor, 2006). Bensì, accogliere ciò che arriva; sperimentare, abbracciare attivamente e consapevolmente i pensieri, le emozioni, le sensazioni, senza modificarli o eliminarli, anche quando risultano spiacevoli e dolorosi (Bricker & Tollison, 2011); vivere evitando di sprecare tempo e risorse mentali nel controllare le memorie ed i pensieri (Butler & Ciarrochi, 2007); approcciarsi in modo impegnato e non giudicante agli eventi personali prima evitati (Kanter et al., 2006).
Tre sono i motivi che fanno pensare che più alti livelli di accettazione si leghino ad una migliore condizione psichica. Primo, l’accettazione rende disponibili più risorse psicologiche per affrontare gli eventi di vita (Bond & Bunce, 2003). Secondo, rispetto all’evitare, l’accettare porta con minore probabilità al pensiero negativo (Feldner, Zvolensky, Eifert, & Spira, 2002; Pennebaker, Kiecolt-Glaser, & Glaser, 1988; Petrie, Booth, & Pennebaker, 1998; Wegner & Gold, 1995). Terzo, l’accettazione consente di vivere molteplici esperienze dal momento che non si ha la necessità di evitare le situazioni che possono generare distress (Butler & Ciarrochi, 2007).
A sostegno di tale ipotesi, l’accettazione ha effettivamente dimostrato di essere significativamente associata ad un migliore funzionamento fisico, emozionale e sociale in ricerche su pazienti con dolore cronico (McCracken & Vowles, 2008) e di correlare positivamente con la salute mentale, il benessere fisico e la performance in ricerche condotte in settings lavorativi (Bond & Bunce, 2003; Donaldson & Bond, 2004). Pertanto, è confortante che gli studi pubblicati finora suggeriscano che l’ACT sia efficace nell’incrementare l’accettazione auto-riportata in svariati problemi (ad esempio, dolore, diabete, fumo, psicosi) (Bricker & Tollison, 2011).
L’ accettazione dell’ invecchiamento
La ricerca che indaga l’efficacia dell’ACT con le persone di tarda età è agli esordi e quindi piuttosto carente. Tuttavia, molteplici sono i fattori che suggeriscono che questo approccio di trattamento sia particolarmente indicato con la fascia di popolazione anziana.
Primo, esso va a bersagliare l’evitamento esperienziale, strategia di coping che ha un’influenza negativa sul funzionamento persino negli anziani (Petkus & Wetherell, 2013). Secondo, l’ACT ha per focus di trattamento i valori, solitamente riscoperti dall’individuo di tarda età grazie alla consapevolezza che il tempo di vita è oramai limitato. Terzo, essa è applicabile a qualunque stadio di vita (McCracken & Jones, 2012) ed è relativamente semplice da apprendere (Lappalainen et al., 2007). Quarto, nell’ACT l’assessment mira a stabilire quanto il problema attuale del cliente sia causato dal processo dell’evitamento. Pertanto, non essendo necessario individuare il disturbo primario che genera sofferenza, l’ACT pare essere in accordo con le caratteristiche che l’ansia e la depressione assumono nell’ultima fase dell’esistenza (Petkus & Wetherell, 2013). Esse si presentano in comorbidità. Differenziarle non è semplice (Gum & Cheavens, 2008). Quinto, l’approccio fondato sull’accettazione e sulla mindfulness sembrerebbe essere migliore della CBT nel trattare anziani con GAD.
Gli anziani hanno per lo più preoccupazioni relative alla salute o a possibili perdite (Diefenbach, Tolin, Gilliam, & Meunier, 2008) che possono non essere del tutto infondate. Di conseguenza, a differenza della CBT che li porterebbe a modificare, a mettere in discussione la validità di tali pensieri, l’ACT risulta di maggior beneficio in quanto insegna loro a focalizzarsi sulle risorse rimanenti (Petkus & Wetherell, 2013). Sesto, oltre alla mindfulness ed all’accettazione, l’intervento ACT impiega tecniche di defusione cognitiva, ossia strategie che tentano di ridurre l’attaccamento alla qualità letterale del pensiero.
Poichè durante l’ invecchiamento, oltre ad un miglioramento nell’abilità di regolare le emozioni (Scheibe & Carstensen, 2010), è presente la capacità di separare le emozioni passate da quelle attuali (Zautra, Reich, Davis, Potter, & Nicolson, 2000), si può ipotizzare che gli individui anziani abbiano più alti livelli di defusione cognitiva e che quindi l’ACT vada proprio a lavorare su una risorsa di questo periodo della vita (Petkus & Wetherell, 2013).
Settimo, considerato che i soggetti di età avanzata mostrano meno consapevolezza dei problemi di salute mentale rispetto alle persone più giovani (Fisher & Goldney, 2003), essi possono avere difficoltà a comprendere l’obiettivo dei trattamenti cognitivo-comportamentali (diminuzione dell’ansia, della depressione o di altri sintomi) (Petkus & Wetherell, 2013) per una scarsa familiarità con l’identificazione dei sintomi dell’ansia e della depressione (Gum et al., 2009; Wetherell et al., 2009).
L’obiettivo del trattamento ACT, ovvero vivere una vita coerentemente ai valori scelti, potrebbe essere invece maggiormente comprensibile e praticabile (Petkus & Wetherell, 2013). Ottavo, il declino dovuto all’età può portare all’impossibilità di ottenere gli obiettivi prefissati. Pertanto, per mantenere il funzionamento c’è bisogno di adottare strategie alternative – come l’accettazione del deterioramento inevitabile e l’identificazione di obiettivi facilmente raggiungibili – che risultano effettivamente adattive.
Gli studi lo dimostrano. Mentre gli anziani che tentano attivamente di eliminare i problemi irrisolvibili tipici dell’ultimo stadio dell’esistenza hanno un maggiore rischio di depressione (Isaacowitz & Seligman, 2002), quelli che sostituiscono obiettivi irraggiungibili con altri più realizzabili godono di un miglior benessere emozionale (Wrosch, Dunne, Scheier, & Schulz, 2006; Wrosch, Scheier, Miller, Schulz, & Carver, 2003). In altre parole, le esperienze che capitano ai soggetti di età avanzata, essendo spesso fuori dal controllo individuale (ad esempio, la morte del coniuge, la malattia), favoriscono l’utilizzo dell’accettazione (Shallcross, Ford, Floerke, & Mauss, 2013), strategia che non a caso si è visto aumentare con l’età (Blanchard-Fields, 2007; Butler & Ciarrochi, 2007).
Oltre agli eventi di vita incontrollabili, due altri elementi spiegano l’incremento dell’accettazione con l’avanzare dell’età. Primo, l’accettazione, non basandosi sulle funzioni cognitive (ad esempio, velocità di processo, memoria di lavoro) che solitamente peggiorano negli anni (Craik & McDowd, 1987; Schloss & Haaga, 2011), può essere adottata come strategia di regolazione emozionale anche in presenza di declino cognitivo (Shallcross et al., 2013). Secondo, dal momento che la saggezza aumenta generalmente con l’ invecchiamento (Clayton, 1982; Grossmann et al., 2010; Tentori, Osherson, Hasher, & May, 2001) e che l’accettazione costituisce una sua componente chiave, è probabile che anche quest’ultima incrementi con l’aumentare dell’età (Shallcross et al., 2013).
L’evidenza empirica preliminare conferma quanto abbiamo appena detto: gli anziani presentano una maggiore volontà a sperimentare le emozioni negative connesse al decadimento fisico e psichico (Butler & Ciarrochi, 2007; Efklides, Kalaitzidou, & Chankin, 2003; Leung, Wu, Lue, & Tang, 2004) e, diversamente dai giovani, impiegano di solito la strategia dell’accettazione a fronte di difficoltà socio-emozionali (Blanchard-Fields, 2007) e di conflitti interpersonali frustranti (Charles & Carstensen, 2008). Dato per assodato che l’accettazione di esperienze emozionali spiacevoli possa giovare durante l’ invecchiamento, bisogna riconoscere che la potenzialità che essa riveste per la popolazione anziana è da ricondurre soprattutto alle prime ricerche condotte impiegando l’ACT con campioni di anziani che suggeriscono che questo trattamento è efficace nel ridurre la depressione, l’ansia ed il dolore cronico (Davison, Eppingstall, Runci, & O’ Connor, 2016; Karlin et al., 2013; McCracken & Jones, 2012; Scott, Daly, Yu, & McCracken, 2017; Wetherell et al., 2011) ed ai recenti studi trasversali che in generale confermano l’esistenza, negli anziani, di un’associazione tra accettazione e migliore funzionamento (Bickerstaff, Grasser, & McCabe, 2003; Butler & Ciarrochi, 2007; Gomez & Madey, 2001; Yong, 2006).
Pertanto, sebbene il venire a contatto con le emozioni negative possa in un primo momento aumentare le sensazioni ad esse associate (Campbell-Sills, Barlow, Brown, & Hofmann, 2006; Hofmann, Heering, & Asnaani, 2009), lo sperimentarle in modo non giudicante – principio cardine dell’accettazione – fa sì che si disperdano rapidamente (Campbell-Sills et al., 2006) conducendo ad una minore affettività negativa (Segal, Williams, & Teasdale, 2002). Riepilogando, l’avanzare dell’età è associato ad un aumento dell’accettazione, il cui incremento correla a sua volta con una minore affettività negativa.
L’accettazione, detto diversamente, mediando statisticamente la relazione tra l’età e l’affettività negativa, rappresenta una strategia di regolazione emozionale fortemente utilizzabile dai soggetti anziani, anche più fragili e malati come quelli istituzionalizzati. Uno studio lo mostra (Alonso-Fernández, López-López, Losada, González, & Wetherell, 2016). Di conseguenza, essa non solo potrebbe divenire un’indispensabile componente terapeutica di trattamenti che cercano di alleviare i disturbi psicologici negli anziani (ricoverati e non) ma sembrerebbe anche spiegare la relazione tra l’età e la più bassa affettività negativa (Shallcross et al., 2013). Quest’ultima affermazione, se si considera che esistono studi empirici che dimostrano che l’ invecchiamento sia unicamente connesso con il deterioramento fisico e cognitivo (Bromley, 1990; Frenkel-Brunswik, 1968; Levy, 1994; Schonknecht, Pantel, Kruse, & Schroder, 2005), è assai rassicurante. Ci fa infatti capire che l’ invecchiamento non porta con sé soltanto conseguenze negative (Shallcross et al., 2013). Piuttosto, come un corpus sempre più crescente di ricerche rivela, esso correla con un miglior benessere emozionale.