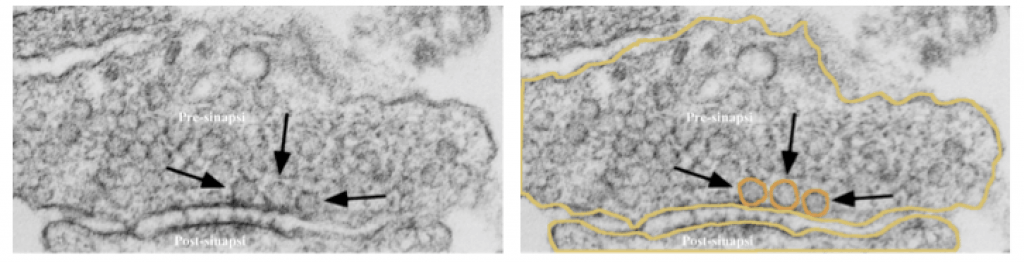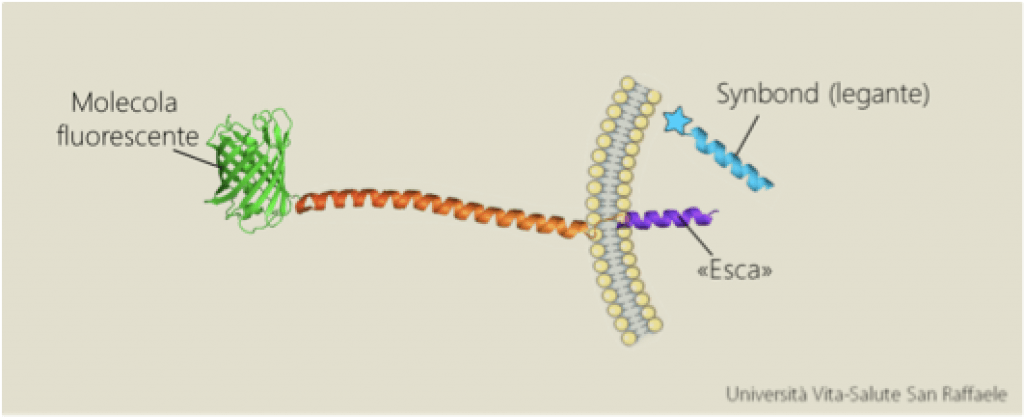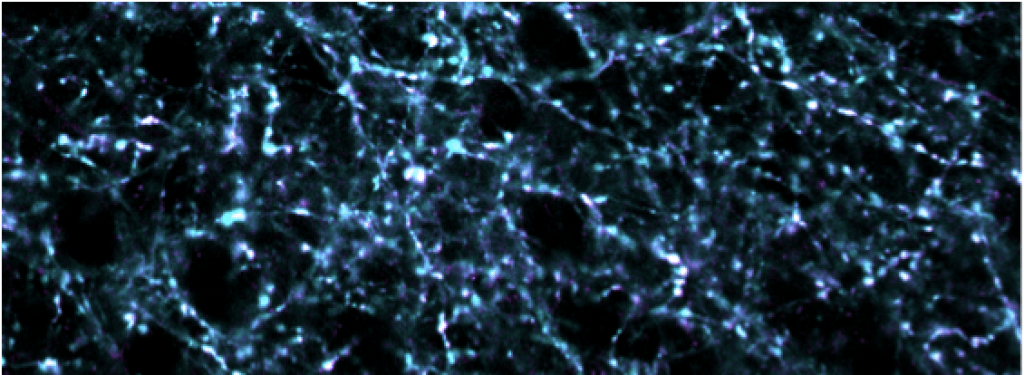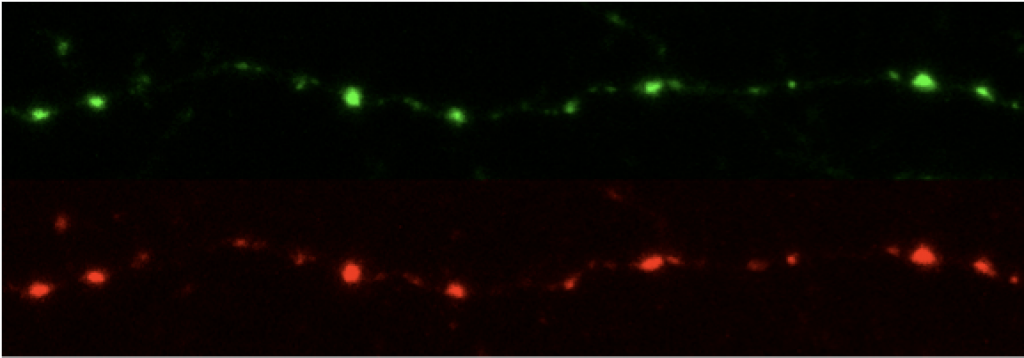Dall’adozione in poi… – L’esperienza di un servizio che prende in carico le famiglie adottanti
La seguente trattazione mira a raccontare la nostra esperienza (nel periodo 2014-2015) relativamente a quanto succede dall’ adozione in poi. La storia di un servizio che ha ri-preso in carico le famiglie adottanti, nel loro processo genitoriale.
Ri-preso nel senso di un’accoglienza in uno spazio dedicato, specifico e sensibile a questa condizione.
Siamo partiti dall’attuale fotografia familiare, per poi connetterci alle radici della decisione dell’ adozione e proiettarci di fronte a noi, nel percorso evolutivo, aprendo uno spazio di ascolto e dialogo reciproco, che ci auguriamo si incrementi nel tempo.
Si tratta di famiglie a vari stadi del percorso, da situazioni di neo adozione, a situazioni ormai strutturate negli anni, ciascuna con bisogni specifici individuali e specifiche fasi evolutive, nonché adottive.
Adozione: linee guida regionali e intenti della presa in carico delle famiglie
Il progetto pensato e strutturato nel corso del tempo dagli operatori della Val di Cornia, in special modo dagli operatori che si occupano di adozione e affidamento a tutti i livelli, nasce sotto lo stimolo delle linee guida della regione Toscana, che norma la valutazione delle coppie aspiranti all’ adozione nazionale e/o internazionale, ma sottolinea anche la necessità di supportare e seguire le coppie che abbiano ricevuto l’idoneità adottiva e che effettivamente abbiano acquisito questo status genitoriale, attraverso l’arrivo di uno o più bambini.
Il proseguimento del contatto con le famiglie, successivo all’abbinamento, è necessario almeno per due ordini di motivi.
Il primo è insito nel processo stesso. Al momento della richiesta adottiva infatti, la coppia è sottoposta ad una serie di accertamenti, di natura legale, sanitaria, sociale e psicologica. Fra queste in particolare, l’indagine psico-sociale viene vissuta con eccessiva pressione, un processo invasivo, “indagatorio”. Ci si sente rimescolati, “giudicati”, messi sotto esame e questo spesso rompe il legame di fiducia con i servizi stessi.
Le coppie pensano sovente che si tratti di un procedimento che potrebbe avere altri toni e livelli, se non addirittura evitato.
E’ necessario quindi rimarginare questa incrinatura, eliminando il vissuto di giudizio e pressione, aggiungendo l’elemento supportivo e strumentale, in un’ottica di fiducia reciproca.
L’altra motivazione che spiega il senso della componente valutativa, riguarda la natura della genitorialità adottiva in sé. Le famiglie non hanno percezione degli elementi emotivi, psicologici, sociali e culturali che dovranno affrontare con i loro futuri figli. La valutazione iniziale, come il corso preparatorio ed il sostegno ad ogni tappa difficile, è fondamentale per poter affrontare le mille complessità della situazione e per evitare la dolorosa esperienza del fallimento dell’ adozione. Dolorosa e traumatica sia per genitori che per i bambini.
Non dobbiamo dimenticarci che, in caso di affido e adozione, si parla di bambini, dal neonato all’adolescente, che hanno vissuto l’esperienza fondamentale del rifiuto e dell’ abbandono della famiglia originaria. Spesso si aggiunge una realtà prenatale costituita da trascuratezza e/o abuso di sostanze, scarsa igiene, malnutrizione, sforzi fisici, tutti fattori che determinano ritardi nello sviluppo, crisi di astinenza, crisi respiratorie, malattie metaboliche, infettive, difficoltà di vario tipo (Baldini, 2009).
Sicuramente non sperimentano il contatto precoce col corpo della madre, tanto meno con quello del padre. La loro primaria esperienza è di solitudine e freddezza.
Dopo la nascita, molti di loro passano da una realtà ad un’altra, facendo l’esperienza più o meno lunga di uno o più istituti, che per quanto buoni, e non sempre è così, non potranno mai offrire lo spazio psico-emotivo di un nucleo familiare caldo.
Non di rado poi nella famiglia originaria, questi bambini subiscono maltrattamenti, violenza subita e/o assistita, abusi e soprusi di ogni genere, che minano profondamente la fiducia in sé e nelle figure di attaccamento.
Sono bambini dunque, che per quanto piccoli, arrivano già con un bagaglio lungo, pesante e costituito da assenze significative.
Le coppie adottanti o aspiranti tali, recriminano spesso la realtà genitoriale in genere, riportando situazioni in cui le famiglie naturali non sono buone famiglie, trovando ingiusta l’indagine rivolta solo a loro, come elemento discriminante. Si sentono messi in discussione a priori.
Nel corso di quest’anno trascorso insieme alle famiglie che hanno affrontato un percorso di adozione, abbiamo discusso e riflettuto molto su questo tema e credo che ancora ci sia da riflettere.
Hanno ragione queste coppie, la genitorialità è un processo difficile, difficile per tutti gli individui non solo per i genitori adottivi, che si acquisisce e si modifica nel tempo. E’ anche una gran risorsa, è il nostro futuro, perché le nuove generazioni rappresentano il futuro, il frutto dell’operato individuale ma anche dell’operato di tutto il contesto sociale. I bambini sono responsabilità e patrimonio di tutta la società.
Crediamo fortemente che come individui, ma anche come istituzioni pubbliche (sanitarie, socio-sanitarie, educative, scolastiche, ecc.) si debba investire molto più e ad un più elevato livello qualitativo sulla genitorialità. Sulla genitorialità in genere, non necessariamente su una genitorialità carente o disfunzionale.
Un progetto di promozione al benessere e di arricchimento ad ampio raggio, costituirebbe un’ottica assai più funzionale di quella riparativa o preventiva (che si focalizza comunque su un problema).
Questo è un processo necessario, ma graduale nel tempo, che probabilmente procede per scalini e sicuramente uno step fondamentale è costituito dall’impegno verso la genitorialità delle famiglie adottive.
Non necessariamente si tratta di situazioni problematiche, ma di uno spazio dedicato, disponibile ad accogliere eventuali difficoltà, ma di fondo uno spazio per affrontare con strategie ottimali, in un clima di serenità e fiducia, la situazione familiare, fase per fase, negli elementi peculiari della realtà specifica e in quelli comuni della realtà genitoriale in genere.
A casa con il bambino
La riflessione parte dalla profonda consapevolezza che il processo di adozione sia un processo in divenire, non un punto d’arrivo e non si esaurisce con l’acquisizione dell’idoneità, successiva alla valutazione dei servizi Sanitari e di Giustizia Minorile, né si esaurisce con l’abbinamento, tanto meno con l’arrivo effettivo del piccolo nella casa dei suoi nuovi genitori.
L’arrivo a casa in realtà introduce una nuova fase evolutiva. Il bambino/a o i bambini e i rispettivi genitori, devono cominciare a “riconoscersi”, come figure familiari, figure di riferimento e di attaccamento reciproco. Devono imparare a riconoscersi.
Riconoscersi è un processo successivo dell’ adozione e più articolato del conoscersi. La conoscenza può avvenire anche velocemente e può essere veicolata dal fare quotidianamente una serie di cose, dal gestire e condividere spazio, tempo, esperienze.
Il bambino viene introdotto nel proprio-spazio familiare-intimo, gli si predispone uno spazio tutto per sé, si condividono spazi comuni, oggetti, abitudini. Il proprio tempo, pensato in due, diventa un tempo che deve includere un terzo (o più).
Nell’usuale processo genitoriale, quando nasce un figlio, l’ordine precedente si sconvolge naturalmente, nonostante costituisca un processo in parte preparato e voluto. Eppure pur sempre un processo nuovo, che ci trova impreparati. Ma il piccolo è in fasce, per cui i genitori hanno modo di inserirlo in modo graduale, anche in base ai propri tempi, modi, capacità, risorse emotive.
Pensiamo ad un figlio adottivo che non è quasi mai in fasce, che ha un suo pensiero, abitudini, una sua storia, esperienze totalmente diverse, un’altra famiglia alle spalle, spesso due (quella naturale e quella dell’istituzione). Ancora più complesso quando si tratta dell’ adozione di un bambino che parla un’altra lingua, mangia un altro cibo e ha vissuto in un ambiente naturale-culturale-sociale completamente diverso (es. villaggio africano, cambogiano, paese indiano, peruviano, ecc.).
Il conoscersi spesso parte già con delle difficoltà oggettive, veicolate dai medium comunicativi che non sono gli stessi.
Rimane il linguaggio dei gesti, il corpo ed il comportamento.
Ma anche questo linguaggio, è connotato culturalmente e ancora di più, psicologicamente. Pensiamo ad un abbraccio, che potremmo valutare come strumento comunicativo universale, in realtà se abbiamo di fronte un bambino che nel contatto con i genitori ha ricevuto solo violenza fisica o non ha sperimentato in alcun modo questa sensazione (es. nel caso del progetto “mamma segreta”), il contatto affettivo, l’abbraccio può costituire una realtà sconosciuta e temuta. E’ il caso dei bambini oppositivi, che resistono all’abbraccio e al contatto, lo rifiutano talvolta in modo anche violento. Per cui, anche i primi contatti sono veri e propri campi di esplorazione sconosciuta.
Nel processo di conoscenza, i genitori adottivi devono veramente mettere in campo tutta una serie di risorse, capacità ad ogni livello, una grande capacità di tolleranza, di flessibilità e accoglienza.
Spesso le coppie, subiscono “violenza” da parte dei piccoli arrivati, capita che il loro spazio debba essere totalmente stravolto e talvolta venga anche distrutto fisicamente. I bambini adottati, nella loro disperata e disperante angoscia, spesso mettono in atto condotte violente e distruttive, aggrediscono cose e persone, feriscono psicologicamente. Mi vengono in mente due esempi: una bambina cilena che ancora in Cile con i nuovi genitori, si è buttata in terra, in mezzo alla strada urlando e sbattendo pugni e calci, oppure il ragazzino indiano che ha freddato la madre dicendo “Voi mi avete comprato”.
Questi genitori dunque, si ritrovano a conoscere e connaturare qualcuno, che sembra “non accogliere la loro accoglienza”. Spesso la loro disponibilità viene continuamente frustrata, svalutata, resa vana.
Per molte coppie è un processo iniziale veramente stressante. Per talune lo è per molti anni o per sempre (come il caso di bambini che non si adattano mai o che hanno gravi handicap).
Se pensiamo poi all’ adozione di più bambini contemporaneamente, di solito fratelli, le cose si complicano ulteriormente. Al loro interno si crea un patto fraterno, che spesso fa muro nei confronti della coppia genitoriale e impedisce ai rispettivi membri, decisioni autonome. Si sperimenta una piccola famiglia dentro la famiglia. Quando il patto fra pari viene meno poi, si innescano gelosie e meccanismi assai potenti, che mirano ad ottimizzare l’attenzione esclusiva degli adulti. L’equilibrio familiare viene costantemente minato dal suo interno.
Questa descrizione per sommi capi e generalizzata, vuole essere esemplificativa dell’estrema articolazione e complessità dello specifico processo di conoscenza, primo passo per un avvicinamento reciproco.
L’incontro effettivo con il piccolo, diverso da noi, avviene unicamente grazie alla capacità di sintonizzarsi ad un livello emotivo profondo, che permette di ri-conoscersi, di sentire la stessa cosa, nonostante una storia diversa, un linguaggio diverso, una cultura totalmente lontana. Se si è capaci di stare nello “stesso sentire”, ci si incomincia ad “appartenere”, a creare un nucleo di appartenenza.
Il riconoscimento è un processo che richiede la sovrapposizione dell’altro rispetto alle orme inconsce, createsi fin dalla nascita, rispetto a ciò che riteniamo “familiare”, una sorta di binario che ci conduce nella modalità relazionale propria. Questa sovrapposizione si crea grazie alla conoscenza che crea elementi comuni, spazi di comunicazione, di condivisione di spazio-tempo, modi di dire, ma soprattutto grazie ad un sentire comune che ci fa appartenere e riconoscere con fiducia, senza vivere l’altro pericoloso o estraneo.
Sia la conoscenza che il riconoscimento sono processi che possono avvenire in tempi relativamente brevi, in tempi lunghi, talvolta in tempi che non si esauriscono mai. Alcuni genitori continuano a dire che non sanno cosa i propri figli hanno vissuto, nel loro paese d’origine. Questa non conoscenza, è come una mancata appartenenza di un pezzo della loro vita. Manca una parte che spesso spiega e rende ragione di quanto loro sono e di quanto potrebbero essere. C’è un vuoto, non facile da significare.
Il processo di riconoscimento ha un suo tempo ed una logica in tutte le relazioni genitori-figli, quelle adottive presentano elementi aggiuntivi e articolati che rendo il tutto più difficile e penoso, in gran parte dei casi.
La qualità dell’attaccamento primario di questi bambini, spesso è caratterizzato da assenza, violenza, maltrattamento, ne consegue una risposta relazionale costituita da evitamento, insicurezza, angoscia, elementi assai complessi e distruttivi, che complicano l’avvicinamento da parte dell’adulto che li accoglie.
Per raggiungere una buona relazione, il bambino deve modificare e correggere il suo binario inconscio che conduce agli altri ed il genitore deve trovare la chiave d’accesso per questa possibilità.
Probabilmente non è possibile modificare quel binario primario, ma una buona relazione, può creare binari paralleli e alternativi.
Il progetto nella sua attuazione
La traduzione del progetto e delle linee guida regionali all’interno del nostro servizio, si è articolato in un iniziale censimento delle cartelle, relative alle coppie in varie fasi, da quelle in attesa di abbinamento adottivo a quelle che hanno adottato da anni.
Le coppie sono state suddivise poi in gruppi, secondo un criterio soggettivo di significanza. Si è creato un primo gruppo di genitori con figli da 0 a 11 anni circa, un gruppo di genitori con figli adolescenti ed un gruppo di genitori che hanno già ottenuto l’idoneità e sono in attesa di abbinamento.
Ciascuna coppia è stata invitata ad un colloquio congiunto con una psicologa e un’assistente sociale, di 90 minuti circa.
La coppia psicologa-assistente sociale era diversa da quella del processo valutativo iniziale. Scelta che si è rivelata importante nella fase iniziale.
Sono poi seguiti gli incontri di gruppo mensile, di confronto sulla genitorialità. Si sono creati due gruppi di 10 coppie ciascuno, di genitori con figli preadolescenti, un gruppo di genitori con figli adolescenti. Successivamente è nata l’esigenza di un gruppo di ragazzi adolescenti e un gruppo di bambini in età scolare (6-10 anni).
I colloqui singoli avevano lo scopo di conoscere le coppie rispetto alla realtà attuale. Si è scelto volutamente di arrivare al colloquio senza aver letto le storie e le relazioni valutative iniziali, lasciando tutto lo spazio di accoglienza e di conoscenza reciproca.
E’ stato un incontro di conoscenza che ha fornito le basi per il processo di ri-conoscimento successivo. Uno spazio con l’obiettivo di ricreare fiducia e riappacificazione con i servizi. Da una parte infatti, le coppie hanno vissuto il processo valutativo come spazio di giudizio ingiustificato, dall’altro si sono poi sentiti abbandonati nelle fasi successive, durante la costruzione della genitorialità.
A tal proposito è importante tener presente che gli operatori che hanno compiuto la valutazione, hanno sempre offerto la loro disponibilità in qualunque fase del processo successivo. Di fatto, quasi mai i genitori hanno accolto tale disponibilità. Quindi, nonostante l’offerta dei servizi, il processo valutativo ha forse innescano processi interni di inadeguatezza e genitorialità mancata, creando una frattura ed una condizione di solitudine da parte delle famiglie.
Questo ambito dedicato, ha assunto la funzione di ricucire lo strappo e di creare uno spazio continuativo di comprensione e di condivisione dell’intero percorso, che va dalla domanda adottiva all’arrivo del bambino, per tutte le fasi successive.
Le tematiche affrontate, sia nel colloquio individuale che nel contesto di gruppo, hanno riguardato aspetti comuni a tutti i genitori e aspetti specifici della condizione adottiva.
Fra queste: il conflitto fra sentirsi genitori comuni-speciali, con tutto quello che comporta essere speciali, la difficile gestione del proprio ruolo rispetto ai genitori naturali e alla storia pregressa del proprio figlio, la difficile gestione di crisi emotive e i comportamenti provocatorie dei figli, le angosce abbandoniche, la compartecipazione con la famiglia allargata (nonni, zii, ecc.), la relazione con l’eventuale presenza di figli naturali, le tematiche relative all’integrazione razziale, l’inserimento scolastico con le difficoltà linguistiche, ecc.
Il percorso di gruppo, rappresentato da uno spazio di due ore, con cadenza mensile, ha costituito prima di tutto il contenitore dove si è creato il “nucleo familiare allargato”, culla per questo nuovo rapporto istituzionale-genitoriale, in senso normativo e affettivo. Il gruppo ha assunto il ruolo di contesto di accoglienza, condivisione e discussione rispetto alla qualità relazionale ma anche alle tematiche su citate, in presenza e condivisione con altri genitori in situazioni analoghe e degli esperti che hanno creato la struttura contenitivo-protettivo, in termini concreti, psicologici, sociali ed emotivi.
Questo percorso si è avvalso, sia della condivisione attraverso il dialogo, sia della condivisione attraverso l’elaborazione grafico-simbolica. Si sono cioè approntati dei lavori mutuati dalla teoria e tecnica gestaltica, nonché da quelli dell’arte terapia, atti a far emergere una capacità creativa-elaborativa di tematiche inconsce. Strumenti utilizzati nel gruppo intero o in sotto gruppi.
I prodotti emersi, hanno avuto un duplice effetto. Da una parte quello di rafforzare e approfondire la conoscenza degli altri genitori, attraverso un clima giocoso. Dall’altra di svelare la propria capacità “generativa”. Ciascun membro in relazione agli altri, attraverso tecniche giocose, che impiegano strumenti non verbali, ha stupito se stesso e gli altri, nei prodotti emersi e nella loro significanza.
L’ adozione è un processo di abbondanza, è un dono reciproco, per il bambino accolto e per il genitore che ha modo di recuperare la propria ferita sulla capacità generativa. E lo strumento simbolico, unito alla verbalizzazione, ha un grande valore riparativo (Basile G., 2006).
I bambini e i ragazzi stessi, all’interno del gruppo di pari, possono trovare e ritrovare un senso e un’origine comune alla propria storia. Il senso di condivisione e di appartenenza può essere anche in questo caso, mediato sapientemente con tecniche strumentali manipolative, come la creta, il colore e la carta di vario genere e formato. Mezzi trasformativi-trasformati in clima ludico, che nella nostra esperienza hanno assunto ruolo di espressione, proiezione e recupero di tematiche individuali, nonché recupero di esperienze perse.
Ci auguriamo che questo percorso parallelo di genitorialità e filiazione possa proseguire costruttivamente trasformandosi in base alle necessità, creando nuove possibilità di riconoscimento ed incontro.
Nel nostro immaginario, andando oltre con i possibili sviluppi, i gruppi potrebbero per esempio allargarsi alle generazioni precedenti, ai nonni, anch’essi coinvolti direttamente nel percorso adottivo e indirettamente come modelli pregressi di genitorialità.
Spesso, l’ adozione costituisce un atto non condiviso o uno spazio dove si rinnovano i precedenti conflitti genitori-figli ed il passaggio alla funzione successiva, ovvero essere genitori di genitori che adottano un bambino non è semplice e lineare. Se per i genitori, approcciarsi ad un bambino diverso (per storia, razza, cultura, lingua) può essere difficile, per i nonni può esserlo ancora di più, innescando talvolta reazioni anche di opposizione e rifiuto.
E forse, riflettendo sul meta-processo, tornando indietro da dove siamo partiti, da noi come servizio che abbiamo offerto uno spazio dedicato, arriviamo alle famiglie adottive come nuclei socio-affettivi che offrono uno spazio-tempo-amore dedicato a sé e ai propri figli, di cui sono genitori a tutti gli effetti.
Dopo quanto detto e sperimentato, concludiamo rinnovando l’importanza di un processo di accompagnamento, che come la genitorialità, non può esaurirsi nel tempo e nello spazio limitato di un inizio, ma deve proseguire costruttivamente ed evolutivamente, allargandosi in tutte le dimensioni (famiglia allargata, scuola, socialità, attività sportive, ecc.).