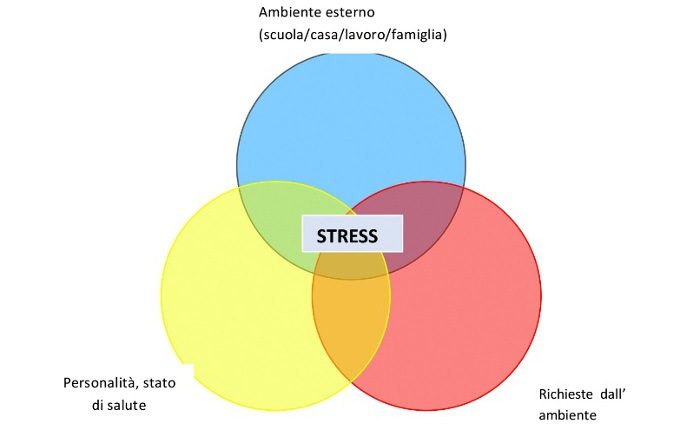Psicoterapia cognitiva della coppia. Dalla valutazione ai percorsi di intervento – Recensione
Psicoterapia cognitiva della coppia: Il manuale si suddivide in tre parti: la prima parte (capp. 1-5) più teorica, la seconda parte (capp. 6-8) più focalizzata sulle specifiche aree di intervento e la terza parte (capp. 9-12) maggiormente dedicata alle metodiche.
Alessia Offredi, Chiara Bellardi
Il libro di Vinai e Rebecchi: un importante contributo alla psicoterapia cognitiva della coppia
“Il clinico che tratta coppie deve essere sapiente, forte, deciso, ma anche capace di risuonare in modo convincente con gli stati emotivi spesso caotici e urgenti che si trova ad affrontare”, afferma Sassaroli nel presentare il volume Psicoterapia cognitiva della coppia, 208 pagine edite da Edizioni Libreria Cortina Milano e curate da Daniela Rebecchi e Piergiuseppe Vinai.
E in effetti il compito dei terapeuti di coppia è decisamente arduo, perché se di solito si ha a che fare con un altro individuo, in questi casi i pazienti nello studio sono tre: i due partner e la loro relazione. Tre situazioni spesso complesse, ognuna con la propria storia e i propri bisogni, che chiedono di ricevere aiuto e supporto dalla stessa persona. Non facile farlo, figuriamoci spiegarlo. Forse anche per questo motivo mancava, nella letteratura di settore dedicata alla terapia cognitiva, un volume sulla coppia. E probabilmente per lo stesso motivo i curatori dell’opera hanno coinvolto numerosi colleghi, operanti nell’ambito o esperti di temi specifici, che hanno contribuito alla stesura del libro. Ne risulta un volume molto chiaro nei contenuti, che non si propone di illustrare nel dettaglio ogni tecnica (spesso già note al terapeuta di formazione cognitiva), ma che offre una struttura definita in cui orientarsi. Complice talvolta la domanda che la coppia porta in terapia, “Il rischio è che focalizzandosi soltanto su aree specifiche, si perda di vista la globalità della problematica, e si finisca per proporre soluzioni a macchia di leopardo, che non tengono conto del complesso intreccio psicorelazionale che sottostà a una difficoltà sessuale o genitoriale”.
La struttura e i contenuti del manuale “Psicoterapia cognitiva della coppia”
Il manuale si suddivide in tre parti: la prima parte (capp. 1-5) più teorica, la seconda parte (capp. 6-8) più focalizzata sulle specifiche aree di intervento e la terza parte (capp. 9-12) maggiormente dedicata alle metodiche.
Il primo capitolo (Pericoli, Rossi, Pasqualetti) passa in rassegna i modelli che nel tempo si sono occupati di formalizzare la terapia rivolta alla coppia. Dalla psicoanalisi all’approccio sistemico, fino ad approfondire le prospettive del panorama cognitivo-comportamentale, gli autori illustrano i passaggi principali avvenuti in quest’ambito, descrivendo l’evoluzione del target di trattamento.
Il secondo capitolo (Nigro, Mancioppi, Possi) affronta uno degli aspetti più difficili da gestire del setting: la relazione terapeutica. La tentazione di “tenere le parti” di uno dei due partner è uno degli aspetti che forse più preoccupano il terapeuta di coppia inesperto, ed è bene che un po’ di questo timore ci sia, per aumentare la vigilanza sui nostri segnali (verbali e non!). In questo capitolo troveremo indicazioni utili, con esempi tratti dalla pratica clinica, su come creare e mantenere una relazione terapeutica sufficientemente flessibile per poter lavorare con i “tre” pazienti, ma al contempo salda e capace di essere base sicura durante il percorso.
Il capitolo dedicato all’assessment e alla valutazione clinica (Rebecchi, Vinai, Boldrini) descrive ciò che accade nelle prime sedute di psicoterapia cognitiva della coppia e quali strumenti è possibile utilizzare in questa fase iniziale. Gli autori analizzano ogni passaggio: dalla richiesta iniziale, alla valutazione della motivazione, all’indagine delle teorie naïf, alla gestione di eventuali sedute individuali, fino ad arrivare alla restituzione. Vengono inoltre illustrate le situazioni in cui la psicoterapia cognitiva della coppia è controindicata, nonché gli elementi che rendono invece possibile procedere con una psicoterapia cognitiva della coppia.
Il quarto capitolo (Rebecchi, Vinai, Framba, Dadà, Gemelli, Sgambati, Boldrini) è dedicato ai percorsi psicoterapeutici e costituisce un compendio di target e interventi dedicati che costituiscono una vera e propria mappa in cui il terapeuta riesce a orientarsi e trovare le soluzioni più adatte alle problematiche che le coppie portano in studio. Nello specifico, vengono analizzati gli interventi rivolti alla modifica di comportamenti disfunzionali nella comunicazione, credenze patogene, emozioni negative e cicli interpersonali disfunzionali, con esempi mirati per ogni sezione. L’ottica integrativa e lo sforzo di sintesi (in senso etimologico) degli autori offre al lettore la possibilità di conoscere prospettive differenti, il cui utilizzo è spesso congiunto in terapia, specie da parte di clinici esperti che sanno adottare interventi diversi senza perdere di vista l’obiettivo e senza farsi trasportare dalla confusione che talvolta caratterizza le coppie problematiche.
Il quinto capitolo (Rebecchi, Caselli e Gemelli) illustra la concettualizzazione delle dinamiche relazionali di coppia attraverso il modello LIBET (Life Themes and Plans Implications of biased Beliefs: Elicitation and Treatment)) di Ruggiero, Sassaroli 2013. Viene proposta una concettualizzazione del funzionamento della coppia attraverso l’individuazione dell’interazione dei temi dolorosi di vita e soprattutto dei piani di vita di ciascun membro della coppia. Tali piani avrebbero una funzione difensiva rispetto al tema doloroso; essi infatti costituiscono “l’insieme degli scopi che l’individuo persegue a lungo termine, che gli consentono di dare una direzione, un senso e un ordine alla sua vita e cha va sotto il nome di self-directedness” (Ruggiero, Sassaroli, 2013). Spesso il motivo del disagio è riconducibile a una rottura del piano, che può avvenire per esaurimento o per invalidazione. Il trattamento consiste nel tentare di fornire alla coppia gli strumenti per individuare ed, eventualmente, flessibilizzare i propri piani. Attualmente i piani identificati dagli autori sono tre: prudenziale, prescrittivo o immunizzante. Nel capitolo sono portati diversi esempi di concettualizzazioni del funzionamento della coppia secondo il modello LIBET, con particolare attenzione ai piani. “Le rotture si verificano quando per eventi interni o esterni il piano di vita di un singolo individuo non è più soddisfacente e funzionale all’interno della coppia. Quando il piano del singolo è inflessibile e rigido, se invalidato, può rompersi. A volte distruggendo anche quello del partner, specialmente se anche questo lo era. […] Finché il piano di vita di coppia è funzionale al singolo, la relazione è “battagliera”, ma non così facile a rompersi. I piani di vita molto simili come tipologia e/o con una interazione fortemente complementare sono generalmente molto prudenziali o controllanti; questo li rende gratificanti a breve termine, ma alla lunga diventano frustranti, perché non arricchiscono l’individuo nel raggiungimento di nuovi scopi”.
Psicoterapia cognitiva della coppia: come trattare i disturbi sessuali e le difficoltà legate alla genitorialità
Con il sesto capitolo dedicato alla domanda sessuologica (Giuri, Rebecchi) si apre la seconda parte, più incentrata sulle specifiche aree di intervento. Le autrici sintetizzano in poche pagine una panoramica che va da un’analisi puntuale dell’inquadramento nosografico secondo il DSM 5 dei disturbi, all’accoglimento della domanda, alla riformulazione della specifica problematica come “sofferenza appartenente alla coppia” e non al singolo, con la comprensione della stessa all’interno dei sistemi di credenze e scopi. Le autrici invitano a lavorare tenendo presente il triplice livello comportamentale, cognitivo e relazionale, cercando di creare dei nessi tra il funzionamento attuale, la storia della coppia e la storia di attaccamento dei singoli individui. Vengono inoltre date indicazioni sugli elementi oggetto del contratto terapeutico: definizione della situazione, degli obiettivi, degli strumenti, del rapporto con il terapeuta. Le autrici forniscono altresì alcuni criteri utili ad individuare quando sia raccomandabile un intervento di terapia sessuologica mansionale, una psicoterapia cognitiva della coppia e/o una psicoterapia individuale. In particolare le autrici asseriscono che “il trattamento della coppia che porta un sintomo sessuale è volto ad aiutare i partner a formulare alternative alle loro modalità di lettura della realtà, a pensare e a metter in atto strategie di soluzione più efficaci alla luce della nuova modalità di leggere e dare significato alla loro sessualità e alla loro vita di relazione sessuale […]. Nel concordare con la coppia un contratto terapeutico è fondamentale che si ridefinisca il problema in termini di “sofferenza appartenente alla coppia” […]. La versione di ognuno è volta alla protezione dell’idea di sé, quanto più questa è rigida, tanto più si faticherà alla ricostruzione che tenga conto invece di entrambi i punti di vista, che ne valorizzi il significato, consentendo una maggiore libertà di costruzione di se stessi, abbandonando la poco sana rigidità […]. La terapia in tal senso dovrebbe aumentare i gradi di libertà con cui il soggetto costruisce se stesso al fine di una costruzione che permetterà attraverso questa esperienza, non solo di progettare un futuro diverso, ma anche di rivedere un passato diverso”.
Il settimo capitolo (Querci) oltre a proporre una meta-analisi della letteratura sul tema della genitorialità in termini di funzioni genitoriali, si concentra sull’assessment, sulla condivisione e sull’alleanza terapeutica. Inizialmente vengono prese in considerazione le funzioni genitoriali (protettiva, affettiva, regolativa, normativa, predittiva, significante, rappresentativa e comunicativa, triadica e transgenerazionali) e i costrutti della genitorialità secondo quanto riportato nel 2009 dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna (adattabilità, empatia, riflessibilità, regolazione, organizzazione, partecipazione, vitalità, qualità della relazione, cogenitorialità, intersoggettività). In seguito vengono prese in considerazione le varie situazioni che possono arrivare all’attenzione del clinico: il figlio ha nuovi bisogni, il figlio ha delle difficoltà ma i genitori non sanno come gestirle, il figlio manifesta un disturbo diagnosticabile, sottolineando l’importanza della interpretazione della problematica e degli obiettivi. In seguito la coppia genitoriale viene invitata ad utilizzare lo strumento dell’analisi funzionale: “i genitori devono riportare la situazione attivante, il comportamento problematico del figlio e le conseguenze emotive e comportamentali del figlio e di loro stessi” (Ruggiero, Sassaroli, 2013). Il coinvolgimento dei genitori può essere di tre tipi: facilitatore, co-terapeutico, come clienti. Si dedica attenzione agli interventi di parent-training e di coping-power.
Nell’ottavo capitolo (De Rosa) viene proposta una meta-analisi della IPV (Intimate Partner Violence), ovvero della violenza di genere all’interno della coppia. Viene offerta una panoramica delle tipologie di violenza (fisica, psicologica e materiale) e della diffusione del fenomeno in maniera trasversale sia in termini geografici che sociografici, con le seguenti specificità secondo il rapporto redatto nel giugno del 2013 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sulla base di uno studio condotto in 161 paesi: “la violenza fisica o sessuale colpisce più di un terzo delle donne nel mondo (35%) e la violenza domestica inflitta dal partner ne è la forma più comune (30%). Nel mondo la prima causa di morte violenta di donne tra i 16 e i 44 anni è l’omicidio a opera di persone conosciute”. Vengono poi prese in esame l’importanza delle conseguenze degli abusi sulle donne in termini di conseguenze fisiche e psicologiche sulle donne stesse e sui figli. Infine vengono analizzati gli approcci dei diversi orientamenti alla questione: cognitivo-comportamentale, psicodinamico e profemminista. In particolare si sottolinea l’importanza del focalizzare l’intervento sull’uomo violento (perpetrator) piuttosto che sulle caratteristiche della vittima. Si fa riferimento al modello Duluth, proposto negli Stati Uniti a partire dagli anni Ottanta e al modello ATV proposto in Norvegia. Mentre il protocollo Duluth di matrice cognitivo comportamentale si focalizza su aspetti specifici (responsabilizzazione dell’autore, stereotipi di genere, empatia, skill-training sulla comunicazione), l’intervento scandinavo si caratterizzerebbe per essere meno strutturato e per tenere maggiormente in considerazione gli aspetti emotivi individuali e la storia di vita del perpetrator.
Le metodiche di intervento della psicoterapia cognitiva della coppia
Con il nono capitolo (Rebecchi, Chiappelli) si apre la terza parte dedicata alle metodiche di intervento. Viene preso in esame l’utilizzo dell’ABC, “il paradigma di analisi di base nella psicoterapia cognitiva. L’ABC è un’espressione ideata da Albert Ellis, ed è un acronimo in cu A sta per antecedente; B per pensieri, C per emozioni e comportamenti”. Vengono poi riferite le domande proposte da Dryden per completare lo schema su tre colonne: qual era la situazione in cui il problema si è manifestato? Cosa ha provato? Cosa ha fatto? Che cosa le passava per la mente in quel momento?
Nel decimo capitolo (Chiappelli, Boldrini) viene spiegato come utilizzare nella psicoterapia cognitiva della coppia lo strumento del genogramma, introdotto da Murray nel 1979. “Ripercorrere la storia familiare in una prospettiva “intergenerazionale” aiuta a comprendere il legame tra questa e la propria storia personale e a riconoscere l’influenza delle modalità relazionali delle famiglie d’origine sulle proprie dinamiche di coppia. Il genogramma può altresì contribuire a portare alla luce segreti familiari a lungo taciuti”. Vengono fornite le istruzioni per compilare lo stesso, al fine di facilitare l’emergere delle dinamiche agonistiche o cooperative strutturatesi nel tempo. Le autrici asseriscono che “nella terapia di coppia è particolarmente indicato “ingrandire l’angolo di osservazione”, legando insieme i due genogrammi, e collegando in questo modo le famiglie dei partner”.
Nell’undicesimo capitolo (Vinai e Speciale), viene descritta la Self- Mirroring Therapy, che si avvale dell’utilizzo di una telecamera per riprendere la persona in due momenti: nel filmato n° 1 la persona viene ripresa durante una seduta di terapia, mentre nel filmato n° 2 la persona viene ripresa mentre guarda la videoregistrazione. Il terapeuta dedica particolare attenzione a far emergere le congruenze e le incongruenze. Nel capitolo viene presentato il background neurofisiologico ed in seguito il protocollo clinico. Gli autori riportano che “un recente studio (Sel, Forster, Calvo-Merino, 2014) ha riscontrato che la visione di volti emozionati induce una più precoce attività nelle regioni somato-sensoriali cerebrali rispetto alla visione di volti con espressioni neutre”.
Nel dodicesimo capitolo (Pasqualetti, Pericoli, Rossi) vengono passati in rassegna i questionari e le scale diagnostiche che è possibile utilizzare a seconda delle aree di maggior interesse, solitamente individuate tra le seguenti: soddisfazione relazionale, comunicazione, credenze, sessualità, abusi/violenze, psicopatologia.
Gli autori concludono asserendo che: “Il modello di terapia che abbiamo descritto in questo volume vuole essere uno strumento quotidianamente applicabile e flessibile, che accompagni nel suo lavoro quotidiano il clinico che già si occupa di terapia di coppia e che stimoli a interessarsene altri cognitivisti che ancora non lo fanno. La nostra speranza è di aver stimolato ricerche di esito e di processo che possano chiarire quali modalità terapeutiche siano più indicate per ciascun tipo di coppia e per ogni dinamica relazionale disfunzionale”.