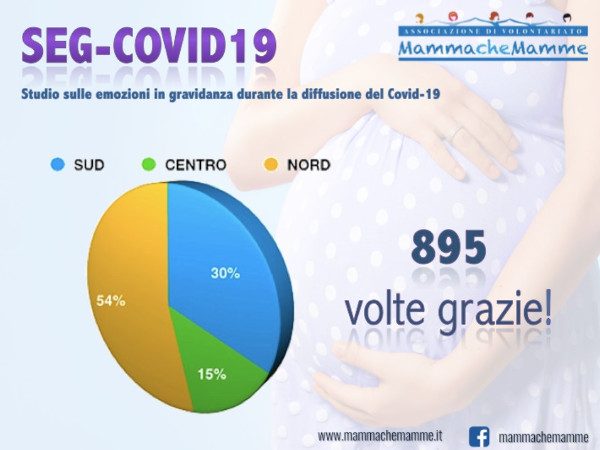Adattamento creativo al “coronavirus”
Le idee luminarie della terza forza della psicologia: la psicologia umanistica, con un accenno cardinale alla psicologia della Gestalt nella delineazione alla reazione ad uno stato di “emergenza”.
Avete mai sentito parlare della teoria della patata? L’ideatore fu Carl Rogers; egli osservò il comportamento delle patate nella credenza buia di casa sua e notò che:
nonostante le condizioni erano sfavorevoli, le patate iniziarono a germogliare: germogli bianchi e pallidi, molto diversi da quelli salutari e verdi prodotti quando erano piantate per terra a primavera. Ma questi tristi, spinosi germogli crebbero di 2 o 3 piedi di lunghezza, tanto da raggiungere la luce lontana della finestra. I germogli erano, nella loro crescita strana e futile, una sorta di espressione disperata della tendenza direzionale che io sto descrivendo. Non sarebbero mai diventate piante, non sarebbero mai maturati, non avrebbero mai raggiunto il loro potenziale. Ma pur nelle condizioni avverse, lottavano per diventarlo. La vita non si arrende, anche se non può fiorire (Rogers,1980, p.118).
Tale metafora è utilizzata dall’autore per spiegare come, in circostanze sfavorevoli all’organismo, l’espressione della tendenza all’attualizzazione, ossia all’autorealizzazione del sé, potrebbe essere influenzata a tal punto che l’organismo diviene distorto, sebbene la tendenza rimanga al massimo della sua costruttività per quelle circostanze. Secondo Rogers anche l’essere umano ha bisogno di tre condizioni fondamentali per la propria realizzazione: assenza di giudizio, accettazione positiva incondizionata ed infine, ma non per ultima, empatia. In virtù di queste potrà sviluppare il suo potenziale, provando l’esperienza della congruenza: in poche parole avendo consapevolezza del suo sentire e agendo in linea con esso. Fare, sapere fare e saper essere. Armonia di pensiero, sentire ed azione. Quindi allo stesso modo in cui le “patate” cercano di portarsi a proprio concepimento e realizzazione, anche l’uomo che si trova in situazioni anguste reagisce e si realizza al meglio delle sue possibilità.
Sicuramente, l’attuale situazione che tutti stiamo vivendo di una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale legata al nuovo Coronavirus SARS-COV-2 che ci obbliga di risiedere nelle nostre abitazioni, in modo coercitivo, al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia, dichiarata da poche settimane pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, pone tutti in uno stato generale di allerta, disagio e paura, dove l’ambiente risulta essere percepito nelle sue polarità, sicuro e costrittivo nelle proprie abitazioni, insicuro, pericoloso seppur con un senso di libertà, fuori da queste ultime.
Così come ci insegna la metafora della “teoria della patata”, tutte le persone sono spinte a reagire in questa inclemente situazione per opera del cosiddetto “adattamento creativo”, il quale avviene grazie alla libera interazione delle facoltà, concentrata su qualche questione attuale, come in questo momento “l’emergenza coronavirus”, e dà luogo non già al caos o ad una pazza fantasia, ma a una gestalt che risolve un problema reale. Per entrare nel cuore dell’adattamento creativo in generale, così come affermano F. Pearls, R.F. Hefferline, P. Goodman, si pensi alla psicologia dell’arte, la parte rilevante si trova nella sensazione concentrata e nella manipolazione lucida del mezzo materiale. Con la chiarezza della sensazione e del gioco nei confronti del mezzo con atti essenziali, l’artista accetta il suo sogno e utilizza la sua intenzionalità critica: ed egli realizza spontaneamente una forma oggettiva. L’artista è ben consapevole di ciò che sta facendo; dopo aver terminato, egli vi può mostrare in dettaglio i passi compiuti; non è inconscio mentre lavora, ma non sta neppure attuando deliberatamente un calcolo deliberato. La sua consapevolezza costituisce una sorta di via di mezzo, né attiva né passiva, che accetta però le condizioni, si concentra sul lavoro, e matura verso la soluzione. Ed è la stessa cosa per quanto riguarda i bambini per esempio: è la chiarezza della sensazione del gioco, apparentemente privo di scopo, che permette all’energia di fluire spontaneamente e giungere a delle invenzioni così affascinanti. In entrambe l’integrazione sensoriale-motoria, l’accettazione dell’impulso, e il contatto assiduo con il nuovo materiale ambientale, sono gli elementi che producono un lavoro valido. Allo stesso modo dell’artista o del bambino che gioca, chiunque di noi in questo momento può attingere, nel modo più adeguato, al proprio adattamento creativo, anche in questa situazione di emergenza nella quale ci troviamo, pensiamo ad esempio a chi, nonostante la costrizione in casa, è riuscito a leggere finalmente quel libro che era sempre rimasto su quel comodino vicino a letto, un po’ impolverato, chi ha inventato nuove pietanze in cucina, chi ha scoperto di saper dipingere, chi si è messo a scrivere un romanzo o un articolo per un giornale, come me in questo momento, chi ha riscoperto i giochi da tavola, la complicità con la famiglia e chi finalmente ha fatto quella chiamata a quella persona cara che non aveva mai il tempo di fare, chi ha inventato nuovi progetti interamente on-line e potrei continuare all’infinito.
Ma l’adattamento creativo non è solo questo, si pensi a tutti gli operatori sul fronte, in questo momento, che hanno sperimentato nuovi modi per sentirsi meno stanchi, per affrontare l’emergenza, a chi fa mascherine fatte in casa perché non ce ne sono più in farmacia e agli scienziati che cercano di adattarsi a questo orripilante virus incentivando la ricerca per un nuovo antidoto.Quindi così come affermano i teorizzatori, nei casi in cui si è in contatto con i bisogni e le circostanze, è subito evidente che la realtà non è qualcosa di inflessibile e di immutabile ma invece pronta ad essere rifatta; e con quanta più spontaneità e senza trattenersi si esercita ogni potere di orientamento e manipolazione, tanto più vitale si dimostrerà tale rifacimento. “Che ciascuno pensi ai suoi colpi migliori, nel lavoro o nel gioco, nell’amore o nell’amicizia, e veda se ciò non è vero” (F.Pearls, R.F. Hefferline, P.Goodman).
Spesso, tuttavia accade che il prudente bisogno di agire in modo premeditato ci fa perdere sempre di più il contatto con le nostre condizioni presenti, ossia nella concentrazione di una questione attuale come suddetto, poiché il presente è sempre nuovo; e la timida ponderazione non è preparata alla novità, giacché ha sempre contatto su qualcos’altro, su qualcosa come il passato. Quindi in questa situazione accade che non si ha la piena percezione del “qui ed ora” che stiamo vivendo, così, se non siamo in contatto con la realtà presente, i nostri bisogni e le circostanze, perdiamo quella spontaneità che ci porta a fallire il bersaglio (anche se non necessariamente nel modo peggiore della nostra prudenza); e questo quindi diventa una confutazione delle possibilità della spontaneità creativa, poiché essa è non realistica.
Ciononostante, per quanto riguarda il funzionamento del corpo dal punto di vista organico è “l’autoregolazione organismica” che ci permette di contattare i bisogni e soddisfarli. Quindi non è necessario programmare deliberatamente, incoraggiare o inibire gli impulsi dell’appetito, della sessualità e così via, negli interessi della salute o della moralità. Se li si lascia stare, questi impulsi si regolano spontaneamente, e se vengono turbati tenderanno a recuperare tale equilibrio. Ma spesso ci si oppone alla proposta dell’autoregolazione più totale di tutte le funzioni dell’anima, comprese la cultura e l’apprendimento, l’aggressività e il compiere quel lavoro che l’attrae, assieme al libero gioco dell’allucinazione (proiezione). La possibilità che, se questi elementi vengono lasciati liberi nel loro contatto con la realtà, i loro squilibri abituali tendano a riequilibrarsi e a giungere a un valido sbocco viene considerata con angoscia e respinta con una sorta di nichilismo (come il vecchio consiglio di Tao: “lasciate la strada libera”). Le persone sono naturalmente capaci di autoregolazione, sensibili al contesto e guidate dalla motivazione a risolvere i problemi, è quindi la tendenza naturale o organismica della persona a regolare il sé.
Quindi, come viene sostenuto da J.M. Robine, quando le persone si trovano in una situazione di disequilibrio, pericolo, paura, di minaccia per la sopravvivenza, come il momento critico che stiamo vivendo tutti e quindi una situazione che l’approccio olistico definirebbe “di emergenza”, l’organismo crea una risposta adattiva globale: globale, perché mette in gioco percezioni, propriocezioni, rappresentazioni e pensieri, attività motoria e così via; adattiva, perché la possibilità al confine di contatto permette che gli eventi vengano gestiti in modo spontaneo e creativo. Tutte le capacità di orientamento e manipolazione nel campo possono dispiegarsi pienamente ed evitare che il campo diventi disorganizzato.
Quindi l’adattamento creativo è parte dell’autoregolazione organismica, che delinea quella capacità dell’organismo di far fronte ai cambiamenti dell’ambiente con risposte originali, caratterizzate dall’abilità a rispondere creando nuovi adattamenti personali alle richieste del mondo interno ed esterno. Un’adeguata autoregolazione ad una determinata situazione dipende da una buona consapevolezza che consente alla persona di valersi di ciò che per lei è “nutriente”, ed è rappresentativa, secondo la psicologia della Gestalt, dell’intero campo; corpo, psiche e ambiente. Pertanto, occorre sottolineare che, in questo caso, l’organismo si adatta all’ambiente in modo spontaneo e creativo, rendendo l’agire coerente con il sentire.