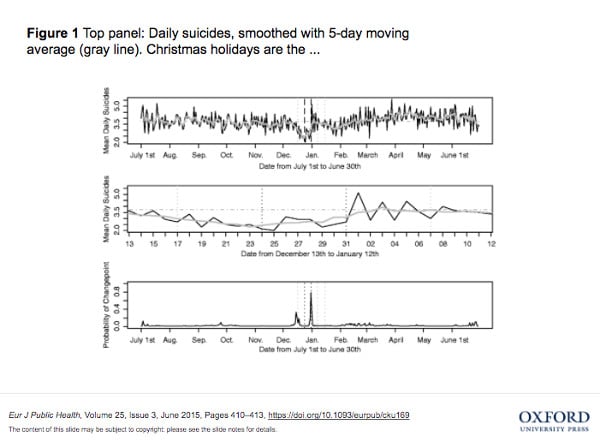L’alleanza terapeutica è il fattore aspecifico che renderebbe efficace qualunque psicoterapia? Non ci sono ragioni per supporlo
Il verdetto del Dodo, nonostante il suo fondamento dubbio, ha avuto il merito di stimolare un dibattito in letteratura che ha indotto lo spostamento dalla questione da se le psicoterapie sono efficaci al perché lo sono.
Nel nostro precedente post (Il verdetto del Dodo ha un adeguato fondamento empirico? Non sembra), abbiamo discusso della solidità delle evidenze che sottendono il verdetto del Dodo in psicoterapia secondo il quale tutte le terapie sarebbero ugualmente efficaci per tutti i disturbi. Abbiamo concluso che il ragionamento teorico e la qualità delle evidenze empiriche permettono di mettere fortemente in discussione questo verdetto, che spesso viene presentato come conclusione indiscutibile del filone di ricerca sull’efficacia della psicoterapia. Va notato che il verdetto del Dodo, nonostante il suo fondamento dubbio, ha avuto il merito di stimolare un dibattito in letteratura che ha indotto lo spostamento dalla questione da se le psicoterapie sono efficaci al perché lo sono, mettendo in luce l’importanza di identificare i fattori del cambiamento in psicoterapia.
In merito a questo argomento, appare fin da subito necessario differenziare i diversi elementi che sono stati oggetto di dibattito teorico e indagine empirica. In effetti, come ben sistematizzato da Kazdin (2007), la ricerca in psicoterapia dovrebbe avvalersi di una chiara distinzione tra le procedure terapeutiche che sono all’origine del cambiamento (per esempio sintomatologico del paziente) e i meccanismi di azione che spiegano perché un determinato intervento induce un cambiamento nell’outcome misurato. Oltre alla consapevolezza di questa distinzione, va segnalato che l’esito di una psicoterapia non è ragionevolmente da ascrivere soltanto all’attuazione di procedure psicoterapeutiche o a variabili che emergono dall’applicazione di tali procedure ma può anche essere in parte attribuibile a variabili che esulano dal contesto terapeutico come ad esempio il presentarsi di determinati eventi nella vita del paziente. Inoltre, precisa Kazdin (2007), va considerato il ruolo delle variabili moderatrici che possono potenziare, o al contrario ridurre, il nesso che intercorre tra procedura terapeutica e processo di cambiamento (come ad esempio le caratteristiche del paziente).
Forti di queste considerazioni, è possibile meglio comprendere l’impatto che il verdetto del Dodo ha avuto, e ha tutt’ora, sulla teoria della cura delle psicoterapie. In effetti, partendo dall’assunto (ripetiamo comunque discutibile) che il verdetto del Dodo sia vero, in altre parole che tutte le psicoterapie sono ugualmente efficaci per tutti i disturbi, sorge spontanea la domanda di quali siano i fattori responsabili di questa ipotetica efficacia indiscriminata. Ciò rappresenta una domanda fondamentale in quanto ciascuna delle psicoterapie bona fide asserisce il ruolo di fattori specifici che possono rendere conto del cambiamento del paziente. A titolo esemplificativo, la terapia cognitiva ipotizza che procedure come ad esempio il disputing inducono la modifica dei pensieri patogeni (meccanismo d’azione) che, a sua volta, è responsabile della riduzione dei sintomi del paziente. I partigiani del verdetto del Dodo hanno ben presto asserito che le evidenze scientifiche da loro promosse fossero un indizio circa la presenza di fattori di cambiamento comuni a tutte le psicoterapie. In altre parole, si è effettuato un salto logico dall’idea che le terapie fossero tutte efficaci all’idea che fossero tutte efficaci perché tutte fondate sullo stesso meccanismo di cambiamento. Il lettore può notare come questo salto logico sia in sua essenza discutibile. In effetti, è possibile pensare che diverse terapie provocano effetti simili ma percorrendo strade diverse. Il che, notiamo, è tra l’altro proprio quello che succede ai concorrenti protagonisti del libro di Lewis Carroll.
Ad ogni modo, volendo seguire il ragionamento di chi asserisce la veridicità del verdetto del Dodo e lo presenta come prova che le psicoterapie agiscano efficacemente in virtù di identici meccanismi di azione, diversi autori hanno sviluppato ipotesi circa la natura dei fattori comuni del cambiamento in psicoterapia (Frank, 1961; Wampold, 2015; per una panoramica vedere Lambert & Ogles, 2004). Tra essi, il modello di Wampold (2015) è probabilmente quello che ha riscosso maggiore successo e risulta tutt’ora quello maggiormente influente nella comunità clinica odierna. Per dettagli relativi al modello si rimanda al post pubblicato qui (Cambiamento in psicoterapia: il modello dei fattori aspecifici). Tra i diversi fattori individuati da Wampold, quello che ha avuto maggiore risonanza è quello dell’alleanza terapeutica. In effetti, ben presto, diversi gruppi di ricercatori hanno svolto studi e portato evidenze scientifiche a supporto dell’ipotesi che il fattore di cambiamento centrale comune a tutte le psicoterapie fosse riconducibile alla qualità dell’alleanza terapeutica (Zilcha-Mano, 2017). Tuttavia, è doveroso evidenziare la presenza di importanti limiti insiti nella tesi che l’alleanza terapeuta sia il fattore di cambiamento centrale e comune a tutte le psicoterapie.
Innanzitutto, possiamo interrogarci sullo status stesso attribuito al fattore “alleanza terapeutica” come meccanismo di cambiamento chiedendoci se non sarebbe piuttosto meglio concettualizzato come una condizione necessaria, ma non sufficiente, di alcuni fattori di cambiamento maggiormente specifici. In effetti, manchiamo di una teoria articolata e solida di perché avere una buona relazione terapeutica dovrebbe ridurre, ad esempio, la sintomatologia del paziente. In assenza di fondamenti teorici solidi, risulta arduo asserire il ruolo di una determinata variabile come motore di cambiamento (Kazdin, 2007). L’ipotesi forse che sembra meglio spiegare questo meccanismo è l’idea che una buona relazione terapeutica fornisca in qualche modo al paziente un’esperienza emozionale correttiva (Alexander, 1950). Tuttavia, tale ipotesi è stata fortemente ridimensionata e considerata una semplificazione ingenua delle complesse dinamiche che intercorrono tra paziente e terapeuta (Safran & Hunter, 2020). Piuttosto, sembra maggiormente ragionevole presuppore che la relazione terapeutica sia una condizione necessaria, e ciò in tutte le psicoterapie, all’esplicarsi di specifici fattori di cambiamento. In maniera simile, risulterebbe difficile asserire che sebbene aprire la bocca dal dentista sia una condizione necessaria alla cura, risulti anche essere il meccanismo di cambiamento fondamentale del trattamento (che ragionevolmente consiste piuttosto nella sanificazione operata dal dentista dopo il soddisfacimento di questa condizione). In questo senso, sottolineiamo che l’alleanza terapeutica è molto vicino a quello che è stato identificato come un fattore centrale di predizione del successo del trattamento, ovvero la compliance del paziente (e.g. Mausbach, Moore, Roesch, Cardenas, & Patterson, 2010). Questa concettualizzazione del ruolo svolto dall’alleanza terapeutica come condizione al cambiamento, piuttosto che come meccanismo di cambiamento, appare ulteriormente sollecitata dalla natura delle prove empiriche che spesso vengono citate a supporto dell’idea che l’alleanza terapeutica sia un meccanismo di cambiamento (Zilcha-Mano, 2017). Come notato in una rassegna recente e dettagliata di Cuijpers et al. (Cuijpers, Reijnders, & Marcus, 2019), la natura delle ricerche sul tema è essenzialmente di natura correlazionale. Ciò significa che abbiamo prove che la qualità dell’alleanza terapeutica predice il successo terapeutico (positivamente) ma ciò non costituisce una prova che sia un meccanismo di cambiamento. Per esempio, non verrebbe in mente a nessuno asserire, sulla base dell’osservazione di una correlazione tra il numero di sedute fatte e il successo del trattamento, che recarsi allo studio dello psicoterapeuta sia un meccanismo d’azione comune a tutte le psicoterapie e non una semplice pre-condizione. In effetti, come notato da Kazdin (2007), al fine di poter asserire che una determinata variabile sia motore del cambiamento, necessitiamo di ottenere evidenze longitudinali in cui osserviamo il nesso temporale tra un determinato intervento, il fattore di cambiamento e l’esito. Ciò rimane estremamente difficile da identificare nella ricerca in psicoterapia per via della complessità insita dei fattori coinvolti e dei loro probabili nessi retroattivi. Ad esempio, la qualità dell’alleanza terapeutica predice probabilmente un esito positivo della psicoterapia ma, a sua volta, la riduzione dei sintomi può probabilmente incrementare il senso di fiducia tra paziente e terapeuta.
In aggiunta, una limitazione concettuale relativa agli studi che hanno preso spunto dal Dodo e che hanno tentato di identificare – e teorizzare – la presenza dei fattori aspecifici protagonisti del cambiamento in psicoterapia consiste nell’affermazione che la dicotomia tra fattori specifici e fattori aspecifici sia poco congruente con la natura complessa dell’oggetto di studio della ricerca in psicoterapia (de Felice et al., 2019). In particolare, la maggioranza di questi studi utilizza tecniche di analisi dei dati che presuppongono l’ortogonalità, cioè l’indipendenza, tra fattori specifici e aspecifici. Questo presupposto non è realistico, infatti, i fattori aspecifici, ad esempio l’alleanza terapeutica, non sono per niente indipendenti da fattori specifici come ad esempio l’interpretazione nella psicoterapia psicoanalitica o l’esposizione e prevenzione della risposta in quella comportamentale. È evidente che uno psicoanalista pondera la proposta di una interpretazione al paziente in base a come valuta lo stato della relazione terapeutica. Similmente accade alla psicoterapeuta comportamentale che dosa gli esercizi di esposizione e prevenzione della risposta in conseguenza dello stato dell’alleanza terapeutica. L’utilizzo di analisi che danno per scontata l’assenza di associazione tra fattori specifici e aspecifici, pertanto, non risulta adeguato a come si svolge la psicoterapia. Alla luce di questa riflessione, appare poco sensato comprendere l’assenza di differenze in termini di efficacia tra diverse psicoterapie come un’assenza di ruolo svolto dai fattori specifici. Piuttosto, argomentano de Felice et al. (2019), dovremo porre attenzione ai trend di cambiamento delle relazioni tra fattori specifici (e.g. procedure terapeutiche) e fattori aspecifici (e.g. alleanza terapeutica) il cui intreccio è in grado di agire come motore di cambiamento terapeutico.
Accanto alla consapevolezza della natura debole delle prove empiriche e del ragionamento concettuale alla base dell’istituzione dell’alleanza terapeutica al rango di meccanismo di azione primario comune a tutte le psicoterapie, un ulteriore elemento di riflessione ci permette di mettere in prospettiva questa tesi. Ciò consiste nella costatazione dell’esistenza di valide spiegazioni alternative della natura dei meccanismi d’azione comuni in psicoterapia. In effetti, vi sono diverse proposte che hanno sviluppato teorie circa l’esistenza di fattori psicopatologici transdiagnostici ai diversi disturbi (rigidità cognitiva, disregolazione emotiva, mentalizzazione, carenza di flessibilità psicologica…) la cui modifica costituirebbe un meccanismo d’azione comune alle diverse psicoterapie. Va notato come, al contrario di quanto sottende la tesi della centralità dell’alleanza terapeutica, questi contributi hanno spesso messo a punto articolati modelli del funzionamento psicopatologico che serve da ancora allo sviluppo di una teoria della cura, presupposto epistemologico fondamentale all’identificazione di meccanismi di azione (Kazdin, 2007).
Per esempio, Peter Fonagy e i suoi collaboratori hanno sviluppato una teoria delle psicopatologie che mette al centro di esse un fondamentale deficit nella capacità di mentalizzazione. Tale capacità si svilupperebbe in età precoce nell’ambito delle relazioni di attaccamento insoddisfacenti (Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002). Secondo questa prospettiva, l’intervento di mentalizzazione reciproca tra terapeuta e paziente sarebbe all’origine di un accrescimento della “fiducia epistemica” del paziente che, a sua volta, sarebbe all’origine della riattivazione di meccanismi di apprendimento sociale, cambiamento centrale per l’apprendimento di nuove competenze, conoscenza sul sé e la ristrutturazione dei suoi modelli operativi interni (Luyten, Campbell, Allison, & Fonagy, 2020). Un altro esempio di contributo particolarmente articolato che asserisce la presenza di un fattore transteorico e transdiagnostico è stato fornito da Lane et al. (Lane, Ryan, Nadel, & Greenberg, 2015). Gli autori hanno sviluppato l’idea che un fattore comune di cambiamento sia costituito dalla rivisitazione di memorie emotive precoci attraverso un processo di riconsolidamento che incorpora nuove esperienze emotive. In particolare, il cambiamento terapeutico sarebbe il frutto di tre specifici ingredienti quali la riattivazione di vecchie memorie, il coinvolgimento in nuove esperienze emotive che sarebbero quindi incorporate alle vecchie memorie mediante un processo di riconsolidamento e infine il rinforzo di tale nuova struttura mnestica mediante l’esercizio di questa nuova esperienza soggettiva in un’ampia gamma di contesti. È degno di nota il fatto che entrambe queste proposte forniscono, mediante un’analisi accurata e dettagliata della letteratura, un modello transteorico forte che asserisce la presenza di elementi transdiagnostici e che quindi risultano valide alternative all’identificazione del primato dell’alleanza terapeutica come meccanismo di azione universale delle psicoterapie.
La breve presentazione di queste proposte mette quindi in luce che, ammesso che vi siano fattori comuni che sottostanno a tutte le procedure psicoterapeutiche, siamo ben lontani dall’aver raggiunto una certezza sul fatto che l’alleanza terapeutica possa essere considerata un fattore comune di cambiamento cardine delle psicoterapie. Piuttosto, sembra più ragionevole pensare che ne sia una precondizione e che altri elementi, che godono di solide concettualizzazioni teoriche, possano essere meglio considerati come fattori di cambiamento universali delle psicoterapie. In conclusione, sebbene il verdetto del Dodo e la sua derivazione nella teoria dei fattori comuni rimangono fondamentalmente discutibili dal punto di vista dei riscontri scientifici finora ottenuti, hanno senza dubbio aperto un interessante dibattito che tutt’ora stimola i tentativi dei teorici, clinici e ricercatori del mondo intero di identificare meccanismi di azione comuni e specifici delle singole psicoterapie permettendo, in ultima analisi, di accrescere le conoscenze utili allo sviluppo della psicoterapia.
Per saperne di più, leggi gli altri articoli pubblicati da State of Mind:
- Una psicoterapia vale l’altra? Non chiedetelo al dodo – Di Valentina Davi
- Una psicoterapia vale l’altra? Hanno ammazzato dodo, dodo è vivo! – Di Giuseppe Magistrale
- Dal verdetto del dodo alla strategia del cuculo: l’efficacia della terapia è dovuta a fattori specifici o alla relazione? – La risposta di Giovanni Maria Ruggiero
- Il verdetto del Dodo: perché il Dodo deve o non deve morire – Antefatto e Primo quadro – Di Angelo Maria Inverso
- Il verdetto del Dodo: perché il Dodo deve o non deve morire – Secondo quadro – Di Angelo Maria Inverso
- Il verdetto del Dodo: perché il Dodo deve o non deve morire – Terzo quadro, Epilogo e penultimo verdetto – Di Angelo Maria Inverso
- Il verdetto del Dodo ha un adeguato fondamento empirico? Non sembra – Di di Francesco Mancini e Guyonne Rogier
- L’alleanza terapeutica è il fattore aspecifico che renderebbe efficace qualunque psicoterapia? Non ci sono ragioni per supporlo – di Francesco Mancini e Guyonne Rogier