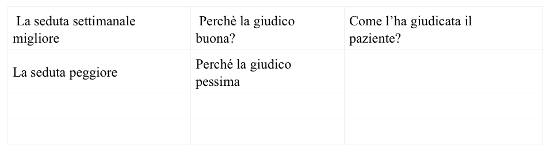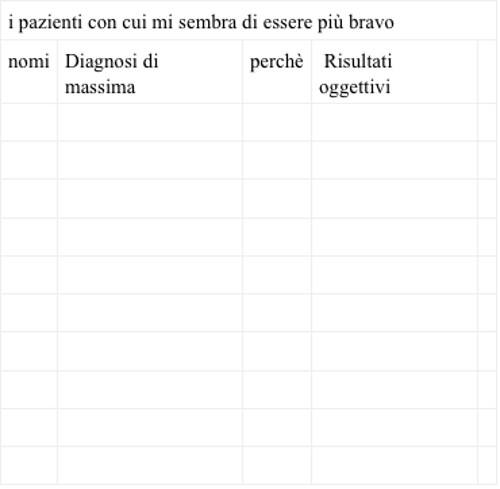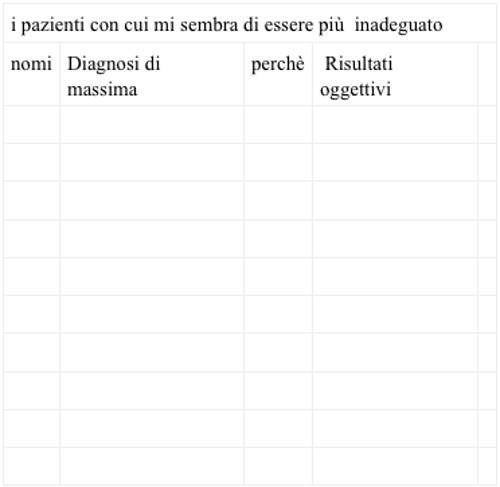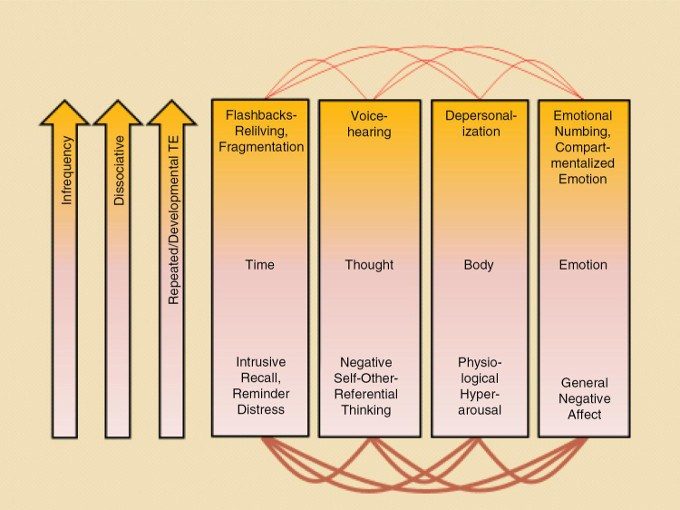Daniel Kahneman: come si prendono le decisioni – Introduzione alla Psicologia
Daniel Kahneman vinse il Nobel per i suoi studi sui processi decisionali, che sono diventati dei capisaldi anche in ambito economico.
Realizzato in collaborazione con la Sigmund Freud University, Università di Psicologia a Milano
Daniel Kahneman nasce il 5 marzo 1934 a Tel Aviv. Trascorre la sua infanzia a Parigi dove si era trasferito con la sua famiglia, di origine ebraica, dalla Lituania.
Daniel Kahneman: l’infanzia e gli studi che gli valsero il Nobel
Negli anni ’40, con l’avanzata nazista, il padre viene arrestato durante il primo rastrellamento degli ebrei francesi e rinchiuso nel campo di concentramento di Drancy. Successivamente viene rilasciato, per merito del suo datore di lavoro.
Durante gli anni della guerra Daniel Kahneman e la sua famiglia si spostano da un paese all’altro, riuscendo a sopravvivere e nel 1948 si trasferiscono in Palestina, prima della creazione dello Stato di Israele.
Nel 1954 Daniel Kahneman si laurea presso la Hebrew University di Gerusalemme in Psicologia. Nel 1958 si trasferisce negli Stati Uniti presso l’università della California a Berkeley per conseguire il dottorato di ricerca in psicologia (1961-70) e in seguito presso lo stesso ateneo fu nominato professore di psicologia.
Nel 1993 ricevette la nomina come professore alla Princeton University, dove ancor oggi insegna come Professore emerito di psicologia.
Kahneman è il secondo psicologo al mondo ad aver ottenuto il Premio Nobel, grazie alle ricerche svolte che aiutarono a comprendere e a individuare i processi decisionali in ambito economico.
Tramite la collaborazione con Tversky e alla formulazione di teorie microeconomiche, riuscì a spiegare come il comportamento decisionale non derivi da processi razionali finalizzati al raggiungimento di uno scopo utile per l’individuo.
Kahneman: le teorie su bias e euristiche
Daniel Kahneman iniziò a lavorare per le Forze Armate Israeliane, dove valutava l’idoneità dei candidati. In questi anni notò di aver commesso errori di giudizio nella selezione dei candidati. Per questo, si interessò ai meccanismi alla base dei processi che dal giudizio portano alla presa di decisione.
Nel 1968, cominciò a lavorare con Tversky sulle modalità decisionali in campo economico. Partendo dalla psicologia cognitiva e dai processi mentali, Daniel Kahneman intendeva comprendere come si sviluppino i giudizi e quali siano i processi che portino a prendere delle decisioni piuttosto che altre.
Kahneman e Tversky realizzarono una serie di esperimenti aventi lo scopo di comprendere cosa induce a una scelta in contesti dominati dall’incertezza e con limitate risorse individuali.
Secondo Daniel Kahneman la mente umana esegue due tipologie di pensiero: razionale e intuitivo. Il pensiero razionale funziona in maniera lenta, sequenziale, faticosa e controllata, mentre il pensiero intuitivo è veloce, automatico, senza sforzo, associativo e difficile da controllare (Kahneman & Egan, 2011).
I risultati delle loro ricerche in questo ambito hanno portato all’individuazione di percorsi mentali utili a giungere a delle conclusioni. Si tratta delle euristiche o scorciatoie mentali che suppliscono i processi di pensiero razionale.
Le euristiche consentono di creare una prima impressione, e di arrivare in maniera rapida, veloce e senza sforzo a delle conclusioni. Le euristiche sono processi mentali intuitivi, che consentono di giungere a un’idea in fretta e senza fatica. Sono, dunque, delle scorciatoie molto utili in determinati ambiti, ma pericolose in altri perché possono produrre errori di giudizio chiamati bias cognitivi.
I bias cognitivi interferiscono con il funzionamento del pensiero intuitivo, alterando la percezione di molti eventi. Questi errori di giudizio dipendono, sostanzialmente, da meccanismi universali che presiedono il recupero di conoscenze razionali, e agiscono secondo automatismi mentali che portano a prendere decisioni velocemente, ma il più delle volte sbagliate perché fondate su pregiudizi o percezioni errate o deformate. Insomma, sono decisioni prese a partire da un errore di giudizio.
Nel 2002 Kahneman e Shane sostennero che l’euristica cognitiva funzioni per mezzo di un sistema chiamato “sostituzione dell’attributo“, che si attiva senza essere consapevoli. In base a questa teoria, quando qualcuno esprime un giudizio complesso, lo si sostituisce con un attributo euristico calcolato più semplicemente e rapidamente accessibile, perché legato a ragioni cognitive o affettive.
L’eurisma, invece, è lo schema mentale, che impedisce il corretto svolgimento del procedimento euristico. Esso comporta, dunque, una sorta di ancoraggio a ciò che appare più visibile, impedendo di leggere più in profondità e di attivare la parte creativa e intuitiva della mente.
Daniel Kahneman: la teoria del prospetto
Successivamente, Kahneman e Tversky ampliarono i loro studi ed estesero le loro ricerche spostandosi all’ambito economico. Inizialmente, criticarono la teoria dell’utilità attesa (Von Neumann e Morgenstern, 1944; 2007), che stabilisce le condizioni secondo cui una decisione può essere definita razionale, e fornisce una descrizione di come effettivamente si comportano gli individui di fronte a una presa di decisione.
La teoria del prospetto, proposta dai due scienziati, differisce dalla teoria dell’utilità attesa, poiché nella formulazione della teoria il concetto di valore, sostituisce quello di utilità. Tutto questo porta a un vero e proprio cambiamento di prospettiva nella determinazione del processo volto a individuare la scelta da compiere.
Quindi, mentre l’utilità è considerata in termini di benessere raggiungibile, il valore è definito in termini di guadagni o di perdite non riferito alla posizione finale del soggetto, ma alle variazioni della ricchezza. Per questo, le persone tendono a valutare i due eventi separatamente, e a considerare più importante la perdita rispetto al guadagno.
La teoria del prospetto evidenzia come in una condizione di rischio, si possa giungere in maniera probabilistica a una data soluzione basandosi su evidenze empiriche. Attraverso numerosi esperimenti, Kahneman e Tversky dimostrarono come le scelte fatte violano sistematicamente i principi della razionalità economica.
In particolare si verificano i seguenti fenomeni psicologici:
- Effetto contesto: il contesto o frame in cui avviene la scelta, influenza la scelta stessa. Quindi, il modo in cui il problema è formulato influisce sul modo in cui l’individuo valuta le proprie azioni. Per cui formulazioni diverse di uno stesso problema portano a prendere decisioni differenti
- Effetto certezza: la volontà a evitare una perdita è superiore alla motivazione a realizzare un guadagno. Per questo, la stessa decisione può dare origine a scelte opposte se gli esiti sono rappresentati al soggetto in termini di perdite piuttosto che come mancati guadagni
- Effetto di isolamento: consiste nella tendenza a isolare probabilità consecutive, invece di trattarle insieme. Nella fase di valutazione, si tende a individuare un valore sulla base dei risultati potenziali e sulle probabilità di avere l’utilità maggiore. Quindi, spesso ci si focalizza sulle soluzioni non adeguate, che portano a scelte incoerenti o isolate, ma la probabilità di ricevere un lauto guadagno incrementa l’attrattiva di questa opzione.
Secondo Kahneman e Tversky la Teoria del Prospetto ha una duplice valenza:
- le persone ragionano in termini di guadagni e di perdite, piuttosto che guardare alla ricchezza
- le decisioni sono determinate dai risultati che derivano dalla verificabilità della scelta. In particolare, nel caso di scelte positive la persona dimostra un’avversione alle perdite, invece in presenza di premi negativi il soggetto tende ad effettuare un “Reflection Effect” cioè a invertire l’ordine delle preferenze individuando solo la soluzione finale senza considerare le perdite. Quindi, se la persona non ama rischiare in questo caso lo farà.
Kahneman e Tversky sostennero che le scelte soggettive derivino da operazioni di semplificazione, annullamento e considerazione dell’influenza del contesto. Quindi, la stessa persona può compiere scelte diverse di fronte allo stesso problema proprio a causa della presenza di un processo alla base poco scientifico e difficilmente ripetibile.
Per questo, il comportamento assunto dalle persone non corrisponde a ciò che tradizionalmente è descritto dai modelli economici, poiché si tende a non massimizzare l’utilità attesa seguendo regole razionali, ma il tutto è determinato da credenze soggettive cognitive.
Questa rivoluzionaria teoria fu pubblicata sulla rivista Econometrica nel 1979 nell’articolo “Prospect Theory: An Analysis of Decisions Under Risk”, e divenne il lavoro più importante, che portò a Daniel Kahneman il Premio Nobel per l’Economia nel 2002. Tversky, purtroppo, decedette nel 1996.
Negli anni ’90 Daniel Kahneman si è dedicato allo studio della psicologia edonica e nel 2011 ha pubblicato il suo best-seller “Thinking, Fast and Slow”. Inoltre, il giornale Foreign Policy lo ha inserito nella lista dei migliori studiosi al mondo.
Nel 2015 The Economist lo introduce al settimo posto nella classifica degli economisti più influenti al mondo.
Realizzato in collaborazione con la Sigmund Freud University, Università di Psicologia a Milano

RUBRICA: INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA