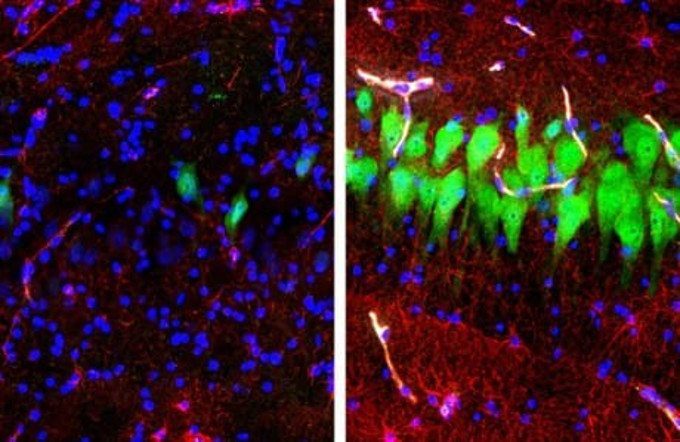Spiritual Bypassing: la scorciatoia della spiritualità per non andare dallo psicoterapeuta
Attraverso il Bypass Spirituale si sviluppa l’illusoria convinzione che svolgendo determinate pratiche oppure seguendo un guru o un maestro spirituale, sia possibile superare le proprie problematiche emotive senza doverle necessariamente affrontare in una psicoterapia.
Gli psicologi e gli psicoterapeuti italiani conoscono bene quali siano i meccanismi di difesa messi in atto dalle persone con un qualsivoglia disagio per non affrontarlo ed elaborarlo. Tra i molteplici meccanismi difensivi messi in atto da un soggetto si annovera il ricorso alla scorciatoia spirituale.
Questo atteggiamento probabilmente è sempre esistito, ma è aumentato a dismisura negli ultimi decenni grazie all’incontro che l’occidentale medio ha avuto con le dottrine spirituali d’Oriente e soprattutto con le tecniche ad esse connesse: yoga, meditazione, qi gong, taijiquan ed altre.
Questo non significa ovviamente che ogni persona che pratica queste discipline abbia necessariamente un disagio irrisolto, ma come ci spiega lo psicologo statunitense Robert Masters nel suo prezioso testo Spiritual Bypassing, molti occidentali rimangono illusi da questa scorciatoia invece che affrontare e risolvere con un terapeuta le proprie problematiche interiori e solo dopo intraprendere un reale percorso spirituale.
Cosa si intende per Bypass Spirituale
In realtà il concetto di Bypass Spirituale fu coniato nei primi anni ’80 da John Welwood, uno psicoterapeuta e insegnate buddhista. Welwood intendeva identificare la tendenza ad usare idee e pratiche spirituali per aggirare o evitare di affrontare problemi emotivi, ferite psicologiche irrisolte e compiti di sviluppo non completati. Questa trappola comporta attivamente la ricerca di sensazioni spirituali come mezzo per evitare di elaborare il sottostante dolore psicologico reale.
Quindi il testo di Masters espone chiaramente questa nuova “sindrome” oramai sempre più diffusa, di scavalcare i propri disagi o problemi di carattere psicologico e quindi relazionale/comportamentale, immergendosi senza riserve nella pratica spirituale e nelle tecniche che da essa derivano.
Un vero e proprio “bypass” che il soggetto costruisce con l’incontro spirituale, rilegando i suoi veri problemi di natura in un angolo, ma pronti a ripresentarsi una volta abbandonata la pratica.
Attraverso il Bypass Spirituale quindi si sviluppa l’illusoria convinzione che facendo certe pratiche o utilizzando determinate tecniche, oppure seguire un guru o un maestro spirituale, possa condurre ad uscire fuori dalle proprie problematiche emotive e non le si debba più affrontare con una terapia ordinaria e comprovata, come ad esempio la psicoterapia cognitivo-comportamentale. Possiamo dire che in definitiva il Bypass Spirituale avviene tutte le volte che: la pratica spirituale, invece di aiutare ad integrare le limitazioni umane, diventa un sostituto compulsivo per evitare di affrontare le questioni psicologiche, relazionali o emotive irrisolte.
Atteggiamenti comuni del Bypass Spirituale
In particolare possiamo rintracciare gli atteggiamenti comuni che si manifestano in un Bypass Spirituale:
- Il soggetto partecipa ad attività spirituali per sentirsi superiore agli altri che non vi partecipano: si tratta solo di una trappola per l’ego e dell’ego in quanto partecipare a queste attività non è garanzia di sviluppo, né è impossibile trovare una persona più avanzata di noi in campi del tutto differenti.
- Il soggetto utilizza la spiritualità come giustificazione per le proprie azioni socialmente inaccettabili: alcune frasi come “tutto è perfetto così com’è” o “la realtà è un’illusione” possono diventare una scusante per non mettere in discussione i propri comportamenti e non assumersi la responsabilità delle proprie azioni.
- Il soggetto ricerca la spiritualità perché “va di moda” o perché gli viene proposta da amici: l’esperienza spirituale autentica dovrebbe essere qualcosa di personale, che accade internamente al momento opportuno e non qualcosa che viene forzato dall’esterno frequentando raduni new age, lezioni di yoga o addirittura collezionando certificati e attestati di terapia alternative.
- Il soggetto tende a criticare sempre le reazioni emotive e la rabbia altrui: tutte le emozioni e quindi anche la rabbia sono sentimenti naturali e risposte perfettamente giustificabili a molte situazioni specie nella cultura Occidentale. Si dovrebbe imparare a gestirle e non certo a sopprimerle. Entrare nell’ottica di una finta e recitata condizione di mitezza e puntando il dito contro chi reagisce agli impulsi emotivi è un altro sintomo del soggetto con affetto da Bypass Spirituale. In definitiva attraverso il Bypass Spirituale il soggetto tende a reprimere le emozioni spiacevoli con varie metodologie, invece che accoglierle e cercare di trasformarle. La conseguenza di questo atteggiamento è quella di provare avversione verso se stessi appena viene fuori il proprio lato d’ombra precedentemente ignorato.
- Il soggetto è un fautore del pensiero positivo e tende a negare ogni possibile evento negativo reale. Ma gli aspetti negativi della vita non scompaiono solo perché vengono ignorati. Questo è un atteggiamento infantile. È necessario bilanciare l’ottimismo consapevole con la volontà di affrontare i problemi reali e non vivere in una condizione illusoria.
- Il soggetto tende sistematicamente ad ignorare la scienza ufficiale: crede che tutti i problemi, anche gravi, possano essere risolti dalle discipline del benessere, con il pensiero positivo o la meditazione ed ignora la scienza ufficiale.
- Il soggetto sviluppa una forte dipendenza da discipline come lo yoga, la meditazione e inizia a credere fortemente a riti effettuati in sistemi religiosi asiatici e ad idolatrare l’Oriente come unica via possibile di comprensione.
- Il soggetto associa la ricchezza materiale ad un’esperienza estremamente negativa: ha dunque la tendenza a considerare il modello Occidentale capitalistico e consumistico come un sistema completamente negativo e privo di spiritualità.
La messa a fuoco e intervista motivazionale sembrano essere le tecniche psicoterapiche più adatte nell’affrontare la sindrome da Bypass Spirituale.