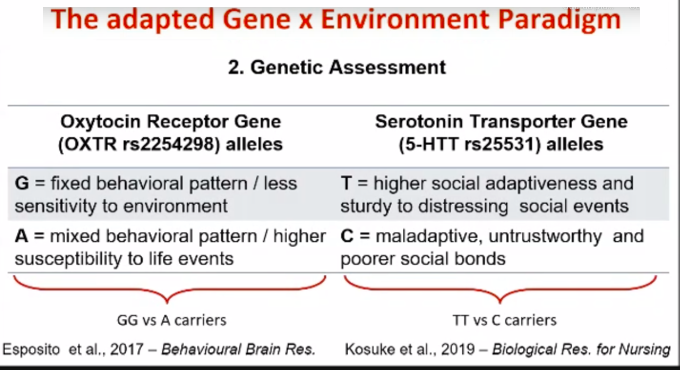Blended-care e demenza: supporto al caregiver nell’era digitale
La demenza è una malattia caratterizzata da una varietà di sintomi e un declino progressivo nelle funzioni cognitive. Per tale motivo, la costruzione di interventi integrati in modalità online e offline può aiutare il caregiver informale nella gestione delle diverse fasi di malattia della persona con demenza.
Noemi Boschetti – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi, Modena
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha descritto la demenza come una delle principali cause di disabilità e dipendenza tra le persone anziane (WHO, 2020).
Mentre si assiste ad un aumento delle patologie cronico-degenerative, si prefigura un incremento della domanda di figure assistenziali formali e informali nella cura della popolazione anziana. Tale condizione determina di fatto un incremento della richiesta di supporto nello svolgimento delle diverse attività quotidiane (Bressan, Visintini, & Palese, 2020).
In ragione delle limitazioni funzionali e della perdita di autonomia, emergono nuovi bisogni sanitari e assistenziali con un forte impatto sull’intero sistema familiare. L’aumento del carico assistenziale nella cura della persona con demenza può quindi avere significative ripercussioni sul benessere delle figure di supporto, in termini di aumento della percezione del burden, stress, disagio fisico e psicologico (Hopwood, Walker, McDonagh, Rait, Walters & Illiffe, 2018).
Il burdern del caregiver
Diverse ricerche finalizzate a studiare questo fenomeno hanno portato a una definizione muldimensionale del burden del caregiver, sottolinenando l’importanza della percezione di sé come figura di cura (Zarit,Todd, & Zarit, 1986). L’esperienza di caregiving può comprendere circostanze che causano un aumento dello stress e del carico assistenziale. D’altro canto, è noto che esistono differenti soglie di percezione del burden psicologico, fisico e socio-assistenziale. Il processo di cura presenta un carattere complesso ed è in grado di generare esperienze tra loro idiosincratiche.
Il careginving, pur presentando un rischio intrinseco di stress fisico e psicologico, può quindi suscitare una percezione di gratificazione nella costruzione di legami intrafamiliari (Tarlow, Wisniewski, Belle, Rubert, Ory, & Gallagher-Thompson, 2004).
Gli aspetti positivi del caregiving possono emergere in una condizione di equilibrio tra le richieste assistenziali e le capacità per farvi fronte. Tale equilibrio riduce il rischio di stress ed incrementa la percezione di un senso di auto-efficacia nel prendersi cura dei propri cari.
Per poter favorire la percezione di maggior gratificazione nel processo di cura e limitare l’insorgenza di difficoltà nella presa in carico, la proposta di interventi che facilitino la transizione al ruolo di cura rappresenta un elemento fondamentale. I familiari assistono infatti ad un cambiamento sostanziale del loro ruolo sociale in seguito alla diagnosi di demenza del paziente (Bruinsma, Peetooma, Bakker, Boots, Millenaar, Verhey, & Vugt,2021). Perciò, l’accesso a modalità di supporto personalizzate e adeguate alle coesistenti attività del caregiver può agevolare l’adattamento al ruolo.
L’avvento della e-Health nel supporto al caregiver
Nonostante sia stata dimostrata l’efficacia degli interventi di supporto “face-to-face”, il crescente gap tra i servizi di cura e la domanda fa emergere una richiesta di metodi alternativi per fornire un supporto e un’educazione ai caregivers informali (Boots, De Vugt, Withagen, Kempen, & Verhey, 2016). Questo divario può essere colmato attraverso l’implementazione di programmi di intervento integrati, che beneficiano dell’impiego di dispositivi internet e percorsi di supporto eHealth.
L’impiego della tecnologia nei percorsi di supporto al caregiver hanno mostrato risultati promettenti in termini di outcome. Interventi e-learning si sono rivelati utili strumenti per il caregiver informale, in quanto i destinatari del programma hanno apprezzato la veicolazione di contenuti multimediali, favorendo l’apprendimento e rendendo il materiale più interessante. In generale, emerge una significativa soddisfazione rispetto ad una comunicazione rapida ed efficace con gli operatori sanitari, o altri caregivers tramite l’impiego di piattaforme virtuali. Inoltre, l’opportunità di personalizzare l’utilizzo dei dispositivi elettronici favorisce il monitoraggio e la comunicazione in differenti setting che coinvolgono varie figure di cura (Nai-Ching,C. & Demiris, G., 2015).
Ad oggi, diverse ricerche hanno dimostrato l’efficacia di programmi eHealth personalizzati nell’incrementare il senso di auto-efficacia e ridurre la percezione di stress e depressione (Boots De Vugt, Smeets, Kempen, & Verhey, 2017). L’utilizzo della eHealth permette infatti di agevolare processi di decision making condivisi, facilitando l’assunzione di un ruolo attivo e partecipativo nel percorso assistenziale.
L’accesso a modalità di trattamento online può costituire un vantaggio per i caregivers che presentano difficoltà nell’accesso alla rete di servizi tradizionali. L’aderenza a programmi da remoto determina, inoltre, un significativo risparmio in termini economici e temporali. Gli interventi online presentano perciò una maggiore fruibilità, soprattutto per i caregiver che necessitano di maggiore flessibilità nell’espletare ai propri compiti di cura, portando direttamente l’intervento nelle loro case e riducendo la percezione di isolamento sociale (Hopwood et al., 2018).
La combinazione di trattamenti online e offline ha mostrato risultati positivi (Wentzel., J., Van der Vaart, R., Bohlmeijer, E.T. & Van Gemert-Pijnen, J.E.W.C., 2016). In particolare, caregivers di persone con demenza ad esordio precoce hanno mostrato maggiore partecipazione a interventi web-base, poiché le generazioni più giovani presentano una maggiore propensione per contenuti online (Boots et al., 2018). Tuttavia, gli studi sull’efficacia degli interventi erogati via web hanno permesso di inviare alcuni limiti nella loro applicazione. Uno degli aspetti più sensibili è relativo all’aderenza al trattamento e all’alto rischio di drop out dei caregiver che beneficiano soltanto del trattamento online (Cox, Schepers, Ketelaar,Van Heugten, & Visser-Meily, 2018).
Si può quindi dedurre che l’integrazione di programmi web-based debba svilupparsi sulla base di una personalizzazione dell’intervento rispetto alle caratteristiche dell’utenza e ai bisogni espressi.
Blended-care: i vantaggi del modello integrato online-offline
Nonostante tali programmi si muovano nella direzione di interventi auto-gestiti, dai risultati emerge l’importanza attribuita alla presenza di una figura di supporto, quali psicologi o altri operatori formati. Il contatto diretto con i professionisti della cura consente infatti la condivisione di dubbi o domande e la personalizzazione di suggerimenti pratici. Allo stesso modo, è possibile fornire un supporto psicologico, al fine di ridurre il senso di isolamento e favorire la comprensione dei vissuti individuali inerenti all’esperienza di caregiving.
In quest’ottica, fornire ai partecipanti un contatto con un terapeuta come supporto durante il periodo di trattamento consente di incrementare l’aderenza al trattamento stesso (Johansson, Michel, Andersson, & Paxling, 2015). Una comunicazione chiara ed adeguata alle capacità del partecipante è infatti essenziale per favorire la comprensione delle finalità e veicolare le istruzioni necessarie ad avviare il progetto.
Il programma d’intervento via web non si propone dunque come sostituzione di un percorso di supporto emotivo, pratico e psicoeducativo, ma come modalità integrata a fianco dell’intervento face-to-face. La componente online si configura come un aspetto flessibile, le cui proporzioni sono adeguate e adattate al trattamento, sulla base dei contenuti e della fase di malattia con cui deve confrontarsi il caregiver. L’aggettivo “blended” descrive infatti un modello interconnesso e non a sé stante rispetto all’intero processo di trattamento, contribuendo in modo equo all’intervento insieme agli incontri face-to-face.
Studi condotti su partners di pazienti con lesioni cerebrali acquisite (Cox et al., 2018) hanno rilevato l’importanza di costruire percorsi di trattamento personalizzati, sulla base delle specifiche problematiche riportare dai caregivers durante i colloqui con il professionista.
Un altro aspetto fondamentale riguarda la valutazione dell’adeguatezza stessa della proposta di un intervento blended. La proposta di inserire un percorso online non può infatti prescindere da una valutazione complessa del caso, analizzando i benefici potenziali ed eventuali limitazioni. Per tale motivo, occorre individuare possibili ostacoli, quali per esempio l’accesso a internet o a dispositivi elettronici, la familiarità con le modalità proposte e eventuali preferenze dell’assistito.
Studi recenti hanno sottoposto a valutazione di efficacia programmi di intervento con queste caratteristiche anche all’interno di percorsi dedicati ai caregivers di pazienti con demenza.
In particolare, il programma blended care “Partner in Balance” per i caregiver di pazienti in stadi precoci di demenza ha promosso un’attività di integrazione tra percorsi di apprendimento e supporto online e sessioni di valutazione in presenza con un professionista della salute (Boots et al., 2016; Boots et al. 2017). L’intervento si basa principalmente su principi di self-management per aiutare i caregivers a trovare un equilibrio tra l’attività di cura e la loro vita quotidiana. I partecipanti a questi interventi esprimono infatti una buona fruibilità dell’impostazione goal-setting, che consente loro di tradurre i contenuti del programma nella vita quotidiana. Tuttavia, emergono spesso difficoltà nella formulazione di obiettivi. L’aiuto di un professionista è dunque importante nella fase di individuazione di scopi specifici e misurabili. Il programma “Partner in Balance” prevede infatti un iniziale incontro con un coach personale allo scopo di far familiarizzare i partecipanti con il programma, stabilendo gli obiettivi e i moduli da condurre.
In questo modo si procede alla costruzione di moduli online tailored-made, che includono aspetti psicoeducativi, modeling comportamentale, piani di cambiamento, feedback via mail dal tutor in un periodo di 8 settimane. Inoltre, i partecipanti possono interagire tra di loro tramite un forum di discussione.
Partendo da questi modelli di intervento, è possibile creare contenuti nuovi, basandosi sull’emergenza di bisogni specifici di partner o altri familiari nel ruolo di caregiver (Bruinsma et al., 2021). Dalla valutazione di outcome emerge l’importanza attribuita alle sessioni face-to-face, come elemento fondamentale per la costruzione di una relazione con il singolo partecipante.
La presenza di coach familiare, con cui si è stabilito un contatto diretto, ha facilitato l’impegno nel completamento dei moduli e ha consentito una maggiore libertà di espressione e condivisione nei contesti online. Inoltre, questo elemento in presenza offre possibilità di riconoscimento per i partecipanti, incrementando la consapevolezza rispetto ai propri comportamenti ed emozioni.
L’analisi dei bisogni del caregiver: un modello personalizzato
La costruzione di un intervento personalizzato in base ai bisogni del caregiver promuove l’acquisizione di un maggior senso di competenza nella gestione della persona con demenza. Di conseguenza, è possibile favorire una percezione positiva del proprio ruolo di cura, focalizzandosi sull’apprendimento di competenze e l’esplorazione di risorse individuali e di comunità.
Alcuni studi si sono focalizzati sull’individuazione degli elementi maggiormente significativi per i caregivers di pazienti con demenza che hanno partecipato a programmi di supporto online (Hopwood et al., 2018). Dai risultati è emerso che il supporto dei pari fornito dai partecipanti online ha rappresentato uno dei temi maggiormente condivisi. Alcuni programmi, per esempio, offrono l’opportunità di sviluppare un network informale di supporto online, attraverso il quale condividere contatti e informazioni pratiche riguardo alla cura dell’individuo in uno contesto di mutuo-aiuto. Un approccio simile, impiegando modalità di videoconferenza, ha permesso di facilitare incontri di gruppo online una volta a settimana. I gruppi di incontro virtuale sono stati diretti da un professionista psicologo, consentendo lo scambio comunicativo tra i partecipanti e la veicolazione di informazioni sulla demenza.
Questi studi (ibidem) suggeriscono che programmi che comprendono l’interazione di gruppo e possibilità di contatto visivo tra i partecipanti hanno una maggiore efficacia rispetto all’impiego di chat, forum o semplice messaggistica nell’incrementare lo stato di benessere e percezione di efficacia dell’intervento. L’analisi qualitativa dei dati ha infatti messo in luce diversi benefici, tra cui un senso di comprensione attraverso l’esperienza condivisa, gratificazione nell’aiutare gli altri, riduzione dell’isolamento sociale.
Un altro aspetto significativo degli interventi online include la veicolazione di informazioni, che appare essere maggiormente efficace se calibrata sulla base dei bisogni informativi individuali.
All’interno dei programmi di supporto è importante includere moduli di sviluppo di abilità intrinseche al ruolo di cura. Tra queste le abilità di decision making sembrano avere una particolare importanza e spesso risultano carenti o non efficaci nella gestione complessa del paziente con demenza. Alcuni interventi hanno proposto strumenti a supporto di questa funzione, favorendo modalità di identificazione delle priorità nel processo decisionale (Hopwood et al., 2018).
Il carattere cronico e progressivo della demenza determina tuttavia l’emergere di bisogni e competenze differenti in base ai vari stadi della malattia. Per tale ragione, programmi d’intervento integrati efficaci devono essere individualizzati e coerenti con le problematiche relative a una determinata fase del processo di cura.
Gli interventi negli stadi precoci di malattia possono preparare i caregivers ai loro compiti futuri, in una fase in cui lo stress e il carico assistenziale sono relativamente bassi (Boots et al., 2017). Questi programmi si sono dimostrati efficaci nel ridurre lo stress, incrementare il senso di auto-efficacia e ritardare l’istituzionalizzazione del paziente. L’individuazione dei bisogni del caregiver basati sulle situazioni individuali e la facilitazione nel processo di adattamento favoriscono dunque una gestione positiva del processo di cura (Boots et al, 2016; Boots et al., 2017; Cox et al, 2017).
La rivoluzione digitale consente di promuovere un’azione proattiva da parte dei familiari, facilitando la condivisione dei processi decisionali e l’accesso a fonti di informazione personalizzate (Nai-Ching & Demiris, 2015). Pertanto, si può concludere che l’uso integrato della eHealth si prefigura come un’opportunità di offrire continuità nelle cure e di sviluppo di una rete di intervento interconnessa a supporto del ruolo del caregiver.