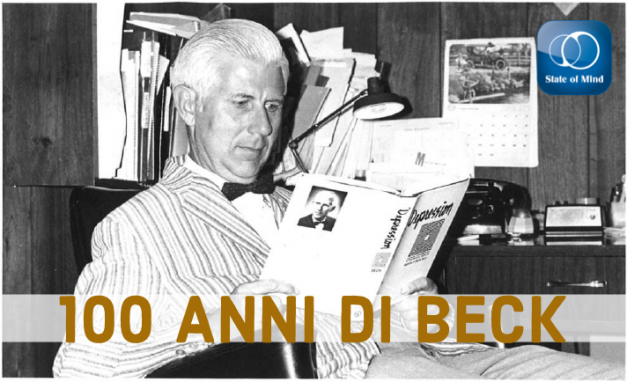Disturbi parafilici a causa iatrogena in pazienti con malattia di Parkinson: difficoltà, sofferenze e ripercussioni sul paziente, sui familiari e sull’ambiente – FluIDsex
Sebbene la terapia dopaminergica abbia migliorato notevolmente la qualità della vita dei pazienti con Parkinson, non sono rari gli effetti collaterali correlati, tra i quali l’insorgenza di disturbi parafilici. La presenza di pensieri e disturbi parafilici viene spesso sottovalutata o considerata solo come un’osservazione aneddotica.
La malattia di Parkinson è un disturbo neurodegenerativo che generalmente si presenta con sintomi correlati a bradicinesia asimmetrica, tremore, rigidità e instabilità posturale (Ali & Morris, 2014; Postuma et al., 2015), ma anche con altri sintomi non motori come disturbi reumatologici, neurologici, del sonno, dell’umore e disturbi relativi al comportamento sessuale (Campo Arias et al., 2018), che possono complicare la prognosi e impattare in modo significativo sulla qualità della vita della persona che ne soffre.
Sebbene sia un fatto innegabile che la terapia dopaminergica abbia migliorato notevolmente la qualità della vita dei pazienti affetti da malattia di Parkinson, non sono rari gli eventi avversi correlati ai farmaci dopaminergici (Cannas et al., 2006), tra le quali una serie di manifestazioni sessuali anormali come l’ipersessualità (Codling et al., 2015) e i disturbi parafilici (Riley, 2002; Campo Arias et al., 2018). Negli ultimi anni si è osservato che la terapia sostitutiva della dopamina è in grado di comportare lo sviluppo o il peggioramento di disturbi specifici del controllo degli impulsi che vanno dal gioco d’azzardo patologico o dallo shopping compulsivo (Nakum & Cavanna, 2016). Nonostante queste siano problematiche che si possono manifestare comunemente nei pazienti parkinsoniani sottoposti a trattamento dopaminergico, la presenza di pensieri e disturbi parafilici viene spesso sottovalutata o considerata solo come un’osservazione aneddotica (Cannas et al., 2006; Solla et al., 2012). Il più delle volte la mancata individuazione di questi disturbi è dovuta anche al fatto che spesso questi comportamenti sessuali non convenzionali si verificano principalmente in ambito familiare, dove sia il paziente sia le persone ad esso vicine non informano adeguatamente il personale medico per il forte senso di vergogna provato, per la natura stigmatizzante di questi disturbi (Cannas et al., 2006), ma anche per l’incapacità di riconoscere le caratteristiche tipiche di disturbi parafilici.
Ad oggi, le parafilie vengono descritte dall’American Psychiatric Association come qualsiasi interesse sessuale, intenso e persistente, diverso dall’interesse sessuale per la stimolazione genitale o i preliminari sessuali con partner umani fenotipicamente normali, fisicamente maturi e consenzienti (American Psychiatric Association, 2013). Questo prevede la classificazione delle parafilie come comportamenti atipici, ma non intrinsecamente patologici, differenziandole dai disturbi parafilici, in cui la presenza di pensieri parafilici e interessi sessuali non convenzionali comportano disagio, menomazione o danno psicologico e fisico, sia al paziente sia alle persone vicino ad esso (American Psychiatric Association, 2013; Solla et al., 2015). Diversi studi documentano come disturbi parafilici e comportamenti sessuali devianti possono emergere come conseguenze iatrogene rare nei pazienti con malattia di Parkinson (Solla et al., 2015). Questi comportamenti possono includere comportamenti o disturbi parafilici come esibizionismo, frotteurismo, pedofilia, masochismo sessuale, travestitismo e voyeurismo, che possono comportare ripercussioni sociali, legali, disagio e vergogna per il paziente e la sua famiglia, già colpiti da una malattia molto debilitante come il Parkinson (Solla et al., 2015; Nakum & Cavanna, 2016). In genere questi disturbi si sviluppano in giovani pazienti di sesso maschile, con esordio precoce della malattia di Parkinson e precedente storia di problemi comportamentali, dopo circa 10 anni dall’esordio della malattia, in uno stadio in cui le complicanze motorie e di deambulazione si fanno più marcate e, quindi, possono richiedere dosi più elevate di farmaci dopaminergici (Cannas et al., 2006; Solla et al., 2015). L’effetto stimolante della terapia dopaminergica sul comportamento sessuale è stato descritto in diversi studi, che suggeriscono che i comportamenti parafilici possano essere innescati da stati di eccessiva attivazione dei recettori dopaminergici, conseguenti a dosi molto elevate di farmaci dopaminergici (Kafka, 2003; Cannas et al., 2006; Cannas et al., 2007). In questi casi, la gravità e la pervasività dei sintomi e dei comportamenti parafilici, associati ai farmaci dopaminergici, è stata attenuata riducendo gradualmente il dosaggio dei farmaci o utilizzando antagonisti dopaminergici (Riley, 2002; Solla et al., 2015), oppure, in caso di non successo, riducendo sia il dosaggio sia aggiungendo un farmaco antipsicotico, come la Clozipina (Cannes, 2007; Basile Fasolo et al., 2008). Tuttavia, l’effetto collaterale di questo intervento comporta l’aggravamento delle manifestazioni legate alla malattia di Parkinson, soprattutto quelle motorie e di deambulazione (Solla et al., 2015).
Sebbene la relazione tra la stimolazione dopaminergica anomala e la regolazione del comportamento e degli impulsi sia piuttosto complessa, l’ipersessualità e le parafilie sembrano essere delle espressioni fenotipiche che si rifanno ad un unico processo fisiopatologico comune; ad oggi, alcuni autori, tra cui Voon e collaboratori (2006), hanno incluso comportamenti parafilici nello spettro dell’ipersessualità patologica associata al trattamento della malattia di Parkinson, poiché sia l’ipersessualità sia le parafilie sembrano essere manifestazioni associate ai farmaci agonisti della dopamina, suggerendo che, in alcuni individui, le parafilie possono insorgere come fenomeni di un disturbo di impulsività sottostante caratterizzato da compulsività sessuale e ipersessualità (Voon et al., 2006; Solla et al., 2015).
I disturbi parafilici che si potrebbero sviluppare a seguito di una terapia dopaminergica possono portare a mettere in atto comportamenti dannosi contro sé stessi, il proprio partner o altri, sfociando talvolta in comportamenti perseguibili penalmente (Solla et al., 2015); infatti, una vasta gamma di rapporti evidenzia le conseguenze psicologiche, sociali, ma anche legali potenzialmente devastanti di questi disturbi, che possono includere comportamenti pedofili, frotteuristici ed esibizionistici (Mendez & Shapira, 2011). Quindi, in questi casi sarebbe opportuno capire se questi individui affetti da malattia di Parkinson che mettono in atto comportamenti criminali, debbano essere considerati responsabili o meno di questi (Berger et. al, 2003; Solla et al., 2015); in particolare, soprattutto per i pazienti che sperimentano questo comportamento come un’esperienza spiacevole e come un incidente iatrogeno non intenzionale, diventa molto importante documentare in modo dettagliato e approfondito tutte le manifestazioni e sintomi dei disturbi parafilici che la persona sviluppa, così da poter fornire un adeguata correlazione tra i comportamenti manifestati, i farmaci antiparkinsoniani assunti, lo stato cognitivo e le facoltà mentali della persona, qualora essa, anche non volontariamente, avesse compiuto un comportamento punibile penalmente (Houeto et al., 2002; Berger et. al, 2003; Cannas et al., 2006).
La presenza di qualsiasi segnale premorboso che possa identificare o permettere una corretta diagnosi di questi disturbi parafilici legati alla malattia di Parkinson, dovrebbe essere adeguatamente studiata e monitorata sin dalle prime fasi della malattia. Una volta che vengono individuati pensieri o caratteristiche tipiche di un disturbo parafilico in pazienti parkinsoniani soggetti a terapia dopaminergica, è opportuno prendere in considerazione aggiustamenti del dosaggio dei farmaci (Cannas et al., 2007; Solla et al., 2015; Nakum & Cavanna, 2016). Inoltre, sin dalla pressa in carico del paziente, è importante che sia la persona che i famigliari siano accuratamente informati in merito alla possibilità di eventi avversi dovuti alla terapia dopaminergica (Evans et al., 2005), così da poter anch’essi riconoscere e segnalare eventuali manifestazioni disfunzionali.
La frequente osservazione di questi disturbi in pazienti parkinsoniani suggerisce la necessità di ulteriori studi per approfondire le conoscenze su questo fenomeno e individuare strumenti diagnostici più adeguati per effettuare una corretta diagnosi precoce dei comportamenti parafilici in pazienti con malattia di Parkinson, che permettano di identificare possibili fattori di suscettibilità e di quantificare l’incidenza e la prevalenza di queste problematiche in tutte le popolazioni cliniche trattate con agenti dopaminergici (Solla et al., 2015; Nakum & Cavanna, 2016).
HAI UNA DOMANDA? 9998 Clicca sul pulsante per scrivere al team di psicologi fluIDsex. Le domande saranno anonime, le risposte pubblicate sulle pagine di State of Mind.
La rubrica fluIDsex è un progetto della Sigmund Freud University Milano.