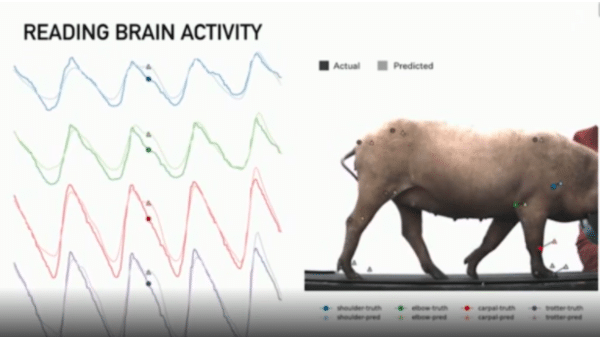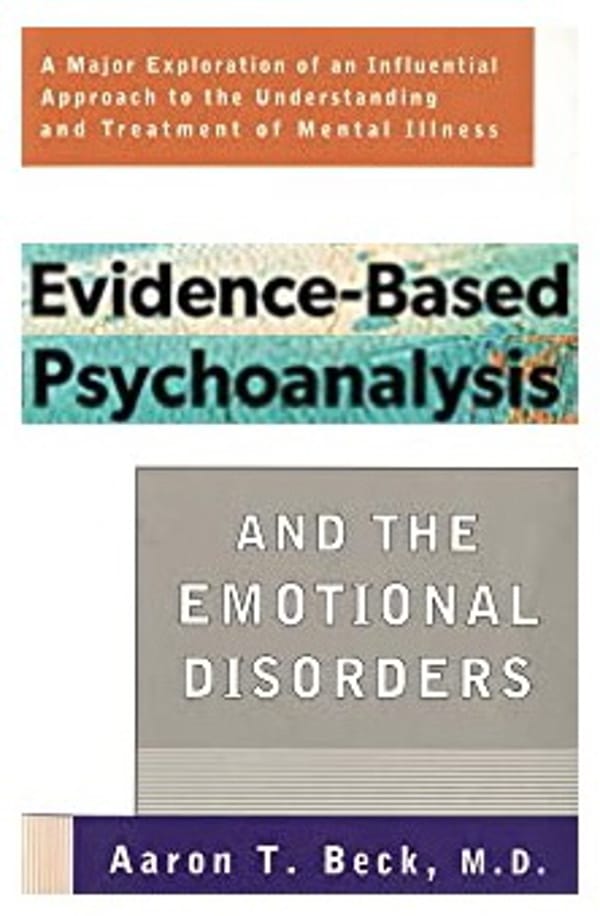Psicoeducazione di gruppo per il paziente grave. Manuale di intervento sul funzionamento sociale di Popolo e Poliseno – Recensione del libro
Gli autori di Psicoeducazione di gruppo per il paziente grave presentano in questo volume un intervento che prevede 24 sessioni di un’ora e mezzo a cadenza settimanale, per una durata complessiva di 6 mesi, in cui vengono affrontati ed approfonditi 4 moduli.
Psicoeducazione di gruppo per il paziente grave. Manuale di intervento sul funzionamento sociale di Popolo e Poliseno è una proposta di terapia gruppale per una popolazione di pazienti molto complessa e allo stesso tempo molto numerosa, di conseguenza difficile da gestire sia da un punto di vista clinico che organizzativo/progettuale, con particolare riferimento al servizio pubblico che, nelle sue diverse sfaccettature, si occupa di salute mentale.
Il volume si apre con la definizione dell’OMS di “salute mentale”, che sottolinea quanto questa sia connotata non solo dall’assenza di malattia, ma dalla presenza di “uno stato di benessere emotivo e psicologico”. La sensazione, leggendo il manuale, è che Popolo e Poliseno abbiano cercato di riempire di contenuti questa distinzione che troppe volte viene percepita come formale e al limite un po’ ipocrita, tra “togliere” qualcosa che non va (la malattia) e “aggiungere” e “ottimizzare” competenze che possono modificare la qualità della vita delle persone. Sia perché a volte non si può ipotizzare in modo idilliaco una guarigione, sia, soprattutto, perché la “guarigione” o il miglioramento sintomatologico sono strettamente legati ad altre componenti della cura che hanno a che fare proprio con le capacità relazionali e di mastery.
Per “pazienti gravi” gli autori guardano a quei pazienti che “pongono difficoltà nella relazione e nell’adesione al trattamento”. Al di là della diagnosi, la gravità viene considerata come “grado di funzionamento interpersonale mostrato dal paziente stesso” e valutata sulla base di diversi assi: quanto e come riesce ad accedere al proprio mondo interno e a quello altrui, a costruire rappresentazioni e ragionarci, a stabilire relazioni costruttive con gli altri tenendosi fuori da cicli interpersonali disfunzionali. I criteri di esclusione dal protocollo di gruppo comprendono il ritardo mentale medio-grave e la dipendenza attiva da sostanze o alcool.
Sembra allora che stiamo parlando di quei pazienti che da una parte faticano ad uscire definitivamente dai percorsi di cura convenzionali, arrivando ad essere considerati in qualche misura cronici, dall’altro, spesso anche alla luce delle proprie difficoltà relazionali, rischiano di “bruciare” gli operatori più in fretta di altri pazienti, arrivando così ad essere contemporaneamente tra i pazienti più bisognosi di aiuto e tra quelli più difficili da aiutare. Ma veniamo al protocollo.
Gli autori hanno previsto 24 sessioni di un’ora e mezzo a cadenza settimanale, per una durata complessiva di 6 mesi, in cui vengono affrontati ed approfonditi 4 moduli. Gli obiettivi della psicoeducazione sono 3: affrontare e discutere il significato personale che il paziente attribuisce alle proprie difficoltà (le credenze soggettive che per lui sono alla base del disturbo); sviluppare un maggior senso di padronanza che consenta, a partire dalle informazioni acquisite, di ottenere un maggiore controllo del proprio disturbo e del proprio funzionamento; proteggere l’autostima del paziente, spesso minacciata dal suo funzionamento e da quello che questo comporta da un punto di vista relazionale e sociale.
Il contesto di gruppo è un setting privilegiato perché consente da una parte il confronto con persone che manifestano difficoltà almeno in parte simili alle proprie, dall’altra una palestra in cui mettere alla prova sia le proprie credenze sia le nuove abilità che si vanno man mano costruendo in un clima di condivisone non giudicante. L’elemento centrale dell’attività sarà infatti non tanto l’informazione appresa, ma il lavoro che questa informazione attiverà all’interno del gruppo.
La conduzione è pensata per due figure: il conduttore e il supervisore. Mentre il primo ha il ruolo più attivo di proporre contenuti, riformularli al termine della sessione e stimolare la partecipazione dei pazienti, il secondo vigila sul funzionamento e sul clima del gruppo, pronto a cogliere e modulare aspetti relazionali che il conduttore potrebbe non cogliere, proprio in quanto parte attiva del contesto di lavoro.
Per quanto riguarda l’organizzazione di ogni seduta, questa è composta da diverse fasi: dopo un primo momento di saluto e di condivisione, il conduttore presenta i contenuti teorici del giorno; questa parte più “pedagogica” viene poi seguita da una discussione libera, in cui viene stimolato il coinvolgimento attivo dei partecipanti chiedendo loro di riportare la propria esperienza personale o riflessioni proprie sul tema proposto. Infine, al termine dell’incontro il conduttore riassume l’argomento trattato rivedendolo alla luce di quanto emerso, integrando alla parte pedagogica i contenuti condivisi dai partecipanti.
I contenuti che gli autori del manuale hanno pensato si possono riassumere in quattro aree tematiche di intervento.
La prima area rappresenta un’introduzione al disagio mentale ed al trattamento e interessa gli aspetti psicopatologici e clinici che influenzano la qualità della vita dei pazienti, con particolare focus sulla sintomatologia depressiva e sui sintomi negativi. Approfondisce aspetti del trattamento farmacologico ed analizza le diverse categorie di farmaci utilizzando un linguaggio non tecnico ma comprensibile e assimilabile dal paziente. Per ciascuna tipologia di farmaco viene descritta la sua natura, le indicazioni, il funzionamento, le avvertenze di uso, gli effetti collaterali e le controindicazioni. All’interno del manuale sono stati inseriti specifici box con proposte di attività di gruppo, utili per una modalità di discussione del tema interattiva e soprattutto calata nel contesto e nella vita dei singoli pazienti.
La seconda area rappresenta un’introduzione al funzionamento mentale e riguarda le funzioni cognitive e metacognitive e il loro ruolo nella quotidianità. È a sua volta composta da cinque sezioni: due per le funzioni cognitive (attenzione e memoria) e tre per le funzioni metacognitive (cognizione sociale, autoriflessività e decentramento). Anche in questo caso, il manuale riporta le sottocategorie specifiche per ogni sezione ed esempi di stralci di sedute che permettono di comprendere in modo concreto come condurre la discussione intorno a questi temi così fondamentali e cruciali per i pazienti con compromissione sintomatologica grave.
La terza area interessa la gestione delle situazioni problematiche. Importante in questo caso sottolineare come le difficoltà non vengano inquadrate in relazione ai disturbi o alle etichette diagnostiche, ma alla luce del paradigma stress-vulnerabilità coping. A sua volta, l’area comprende quattro sezioni: nella prima viene illustrato il concetto di stress, nella seconda il coping, nella terza il problem solving e nella quarta il ciclo interpersonale.
Infine, la quarta ed ultima area riguarda l’elaborazione delle emozioni ed è costituita da quattro sezioni che approfondiscono, rispettivamente, il ruolo svolto dall’emotività, le singole emozioni semplici e complesse, le relazioni che le emozioni hanno con pensieri, immagini mentali e sensazioni e le strategie più funzionali per regolarle. Soprattutto per quanto riguarda questa ultima e importante sezione, il manuale propone diversi box con possibili attività di gruppo mirate ad approfondire la regolazione emotiva e la psicoeducazione in merito.
Infine, il volume si chiude con un’Appendice con materiale psicoeducativo che è possibile utilizzare anche con i pazienti e che introduce in termini molto semplici e comprensibili gli argomenti previsti dal protocollo (funzioni cognitive, metacognitive, il coping, il problem solving, etc.).
A latere, gli autori sottolineano come la presentazione dei diversi argomenti non debba per forza seguire rigidamente l’ordine proposto, ma adattarsi al clima del gruppo ed alle singole situazioni che interessano i partecipanti.
Concludendo, la proposta di Popolo e Poliseno rappresenta una bella sfida, che si propone di utilizzare il setting di gruppo per lavorare con i pazienti proprio sul funzionamento sociale e sulle dimensioni ad esso propedeutiche, come la metacognizione e la regolazione delle emozioni. Un bel presupposto e un bel messaggio per una popolazione di pazienti spesso lasciata indietro dai progetti di cura e dai protocolli sperimentali, che fa venire voglia di dire, come nell’omonimo film, “si può fare”.