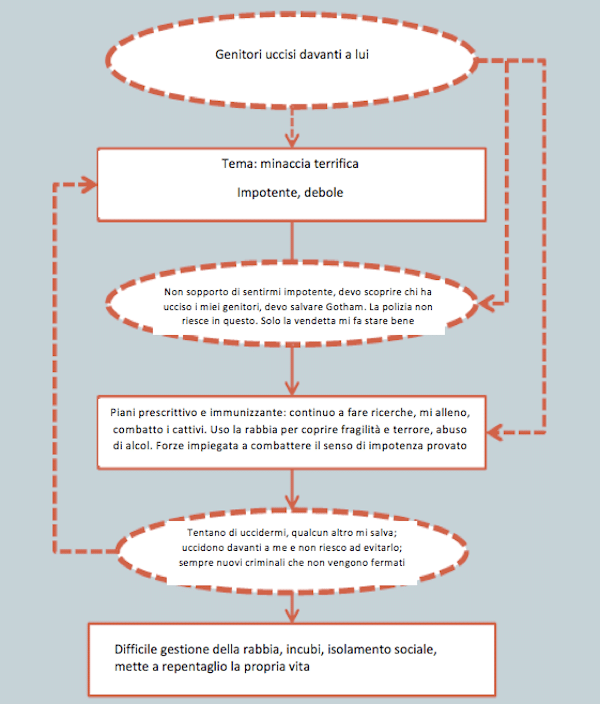Ricerca preliminare quantitativa sulla relazione tra videogame, violenza ed aggressività
Al di là dei diversi studi, rimangono ancora sconosciuti i fattori per possono influenzare o sopprimere la relazione tra l’uso di videogiochi violenti e l’aggressività; le variabili interagiscono fra loro in modi che ancora non comprendiamo, rendendo difficile generalizzare molti dei risultati ottenuti.
La preoccupazione per le potenziali conseguenze negative date dall’interazione con i media non è un fenomeno nuovo: è prassi che lo sviluppo tecnologico arrivi accompagnato da
ansia e allarmismo verso le potenziali conseguenze negative sugli utenti. I
videogiochi, proprio per la loro natura interattiva, sono stati particolarmente al centro di questo tipo di controversie, anche per via dei contenuti di natura violenta presenti in moltissimi titoli. Per esempio, giochi estremamente popolari come Call of Duty o Grand Theft Auto (GTA), che sono riusciti a conquistare il grande pubblico raggiungendo vendite da record (Macy, 2017), sono distinti dalla presenza di scene violente (Saar, 2014). Proprio la presenza di tali contenuti ha suscitato i dubbi della comunità scientifica, la quale ha voluto indagarne la potenziale influenza sui giocatori, in particolare su quelli più giovani. Per poter meglio comprendere gli effetti dell’esposizione ad un medium violento, sia esso un videogioco o un film, la ricerca scientifica ha posto l’attenzione sulla distinzione fra il termine aggressione e il termine
violenza, concetti erroneamente considerati sinonimi. L’aggressività viene definita come un’ampia varietà di comportamenti ostili (Allen & Anderson, 2017), innescati da stimoli ambientali o sociali particolari che si rifanno a comportamenti territoriali di avvicinamento ed esplorazione. Essa può esprimersi, dunque, con azioni benigne od ostili, in modo diretto o indiretto (Kirsh, 2012). La violenza (da Vis, che significa forza nelle lingue indoeuropee) rappresenta, invece, una delle dimensioni possibili che può assumere l’aggressività (Baron & Richardson, 1994), con forme maggiori di intensità e distruttività, svolta con l’intento di causare danni (Anderson & Bushman, 2001). La violenza è ascrivibile a un atteggiamento antisociale, intenzionale, organizzato e finalizzato al raggiungimento di uno scopo preciso (Ferguson, 2018). La violenza può, dunque, essere aggressiva, ma l’aggressività non è violenza (Ferguson, 2018). Questa distinzione risulta necessaria per comprendere gli effetti di un videogioco violento (VVG- Violent VideoGames), poiché anche in letteratura vi è confusione circa le conseguenze rilevabili post-gioco (Anderson & Bushman, 2002).
Ci sono ragioni teoriche plausibili per aspettarsi che giocare a VVG possa aumentare l’aggressività, ma ci sono altrettante motivazioni per credere che la relazione sia probabilmente più complessa. Bandura (2001) suggerisce che l’apprendimento per osservazione, concetto spesso utilizzato per confermare la relazione positiva fra contenuti violenti e comportamenti violenti, non è sinonimo di mimetismo, ma include anche l’apprendimento di regole sull’adeguatezza di particolari comportamenti in date circostanze. Allo stesso tempo, i VVG possono essere usati per indurre senso di rilassamento o per aiutare la gestione dell’umore, suggerendo, così, che il gioco possa essere associato a una ridotta ostilità e ad un aumento dell’umore positivo (Ferguson & Olson, 2013; Ferguson & Rueda, 2010).
Ancora, alcuni livelli maggiori di aggressività sono stati rilevati solo dopo l’esposizione al medium in questione, ma in modo limitato e circoscritto nel tempo. Tuttavia, è bene precisare che tale fenomeno viene definito pseudo-aggressività, o aggressività apparente, la quale viene manifestata per l’affermazione e la tutela della propria identità (Ferguson, 2018), con valore funzionale alla vittoria dell’attività ludica. Inoltre, è bene non dimenticare la componente competitiva che può accompagnare il giocatore. Un fenomeno analogo si potrebbe osservare, ad esempio, in un giocatore di calcio con livelli di aggressività più alti subito dopo aver sbagliato un goal importante, ma non per questo sarebbe capace di compiere azioni violenti nel lungo periodo.
Al di là dei diversi studi, rimangono ancora sconosciuti i fattori per possono influenzare o sopprimere la relazione tra l’uso del gioco violento e l’aggressività; le variabili interagiscono fra loro in modi che ancora non comprendiamo, rendendo difficile generalizzare molti dei risultati ottenuti.
Più recentemente, la ricerca si è concentrata sui videogiochi come potenziale fonte di dipendenza patologica e sulla possibilità di considerare tale dipendenza come un vero e proprio disturbo mentale (Griffiths et al., 2016). I ricercatori, a tal proposito, hanno sistematicamente sostenuto che tutte le dipendenze condividono caratteristiche e aspetti comuni simili. In questo contesto, è stato osservato come la dipendenza possa verificarsi indipendentemente dai mezzi (ad es. assunzione di sostanze o comportamento eccessivo) ogniqualvolta un individuo provi i sei componenti fondamentali della dipendenza (ad es. salienza, tolleranza, sintomi di astinenza, modificazione dell’umore, conflitto, e recidiva) (Griffiths, 2005). Diversi studi empirici sembrano supportare questa nozione, poiché i componenti principali delle dipendenze sono stati empiricamente testati e hanno dimostrato di applicarsi a una vasta gamma di comportamenti di dipendenza, come la dipendenza da gioco online (Pontes, Király, Demetrovics e Griffiths, 2014), dipendenza da Internet generalizzata (Kuss, Shorter, Van Rooij, Van de Mheen, & Griffiths, 2014), dipendenza da lavoro (Andreassen, Griffiths, Hetland e Pallesen, 2012), dipendenza da shopping (Andreassen et al., 2015) e persino dipendenza da studio (ad es. precursore della dipendenza da lavoro) (Atroszko, Andreassen, Griffiths e Pallesen, 2015). Alcune di queste forme specifiche di dipendenze (comportamentali) sono state definite “dipendenze tecnologiche” (Griffiths, 1995) da oltre due decenni. Le dipendenze tecnologiche sono state definite operativamente come dipendenze comportamentali non chimiche che implicano un’eccessiva interazione uomo-macchina (Griffiths, 1995). Inoltre, le dipendenze tecnologiche possono essere passive (ad esempio, guardare la televisione) o attive (ad esempio, giocare ai videogiochi) e di solito contengono elementi che inducono o possono contribuire alla promozione di tendenze che creano dipendenza (Griffiths, 1995). Sulla base di ciò, le dipendenze tecnologiche possono essere viste come un sottoinsieme di dipendenze comportamentali (Marks, 1990), con tutte e sei le componenti principali della dipendenza (cioè salienza, tolleranza, sintomi di astinenza, modificazione dell’umore, conflitto e ricaduta) per la prima volta descritto da Brown (1993) e successivamente modificato da Griffiths (1996, 2005)”.
Dal 1 gennaio 2022 il Gaming Disorder sarà riconosciuto come una patologia a tutti gli effetti da parte dell’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, avendo deciso di inserire la dipendenza da videogiochi nella prossima edizione dell’ICD-11 (International Classification of Desease). La stessa OMS definisce tale disturbo come caratterizzato da controllo alterato/indebolito sull’attività di gioco, che diventa la principale occupazione della propria vita a discapito delle altre, con una durata di minimo 12 mesi.
L’etichetta patologica del Gaming Disorder non vede in accordo tutta la comunità scientifica, infatti l’American Psychiatric Association ha ritenuto opportuno l’inserimento dell’internet gaming disorder (o dipendenza da videogiochi online) nella Sezione III del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, come condizione che necessita ulteriori ricerche cliniche prima di essere considerata formalmente un disturbo (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013).
In tale sede, l’internet gaming disorder viene definito come un disturbo da dipendenza che riflette un impegno persistente e ricorrente con i videogiochi, spesso con altri giocatori, con conseguente disagio clinicamente significativo come indicato da cinque (o più) dei seguenti nove criteri fondamentali su un periodo 12 mesi:
- consapevolezza che tali comportamenti stiano causando problematiche psicosociali;
- mentire in merito alla quantità di tempo passato a giocare o nascondere l’uso dei videogiochi;
- uso di videogiochi per sfuggire o alleviare gli stati di eccessiva preoccupazione per il gioco;
- sintomi di astinenza quando non si gioca o il gioco viene impedito;
- tolleranza, risultante nella necessità di dedicare quantità crescenti di tempo ai videogiochi;
- tentativi infruttuosi di controllare l’attività ludica;
- abbandono delle altre attività per dedicarsi esclusivamente al gioco;
- uso continuativo dei videogiochi nonostante stati d’animo negativi;
- mettere a repentaglio o perdere una relazione significativa, lavoro o istruzione o opportunità di carriera a causa dell’eccessivo uso dei videogiochi.
Tuttavia, la proposta dell’Internet Gaming Disorder ha portato con sé dubbi riguardo alla sua entità diagnostica. Più precisamente, l’inclusione del termine “Internet” è stata contestata in favore dell’uso del termine “Video Gaming Disorder” (o più semplicemente Gaming Disorder), suggerendo che l’eccessivo uso di Videogiochi possa non essere confinato esclusivamente a un contesto online (Griffiths & Pontes, 2014). Il termine internet addiction, è stato inoltre criticato dalla comunità scientifica per la sua mancanza di specificità, data l’eterogeneità di comportamenti potenzialmente problematici che possono avvenire in rete e dei diversi meccanismi eziologici sottostanti (Starcevic e Aboujaoude, 2016).
I videogiochi sono stati considerati dalla comunità scientifica non solo per gli eventuali effetti negativi associati, ma anche per le loro potenzialità nel migliorare le funzioni cognitive, percettive e motorie (vedi Granic, Lobel, & Engels, 2013). Infatti, giocare ai videogiochi è associato ad una maggior coordinazione oculo motoria (Griffith, Voloschin, Gibb e Bailey, 1983), ad un incremento dell’
attenzione (Howard, Wilding e Guest, 2016), a maggior capacità di rotazione mentale (Spence & Feng, 2010), e ad un miglioramento della
working memory (Colzato, van den Wildenberg, Zmigrod, & Hommel, 2010). Per questo, i videogiochi possono rallentare il declino cognitivo associato con l’età, di deficit mnestici ed essere usati come strumenti riabilitativi nel post stroke o per una malattia neurodegenerativa, come il
morbo di Alzheimer (Ballesteros & Reales, 2004).
L’obiettivo del presente studio sarà quello di analizzare la prima tra le diatribe scientifiche riguardanti l’uso dei videogiochi che abbiamo qui brevemente introdotto: la relazione che esiste tra videogiochi violenti e aggressività. Nello specifico, verrà analizzata e rilevata una statistica descrittiva del campione al fine di contribuire alla comprensione della relazione esistente fra videogiochi violenti ed eventuali comportamenti di aggressività e di rabbia. L’ipotesi di partenza del presente studio è che esista una relazione significativamente elevata preesistente fra l’utilizzo di videogames e condotte devianti a livello socio-emotivo (quali, ad esempio, la violenza o la mancanza di controllo degli impulsi).
Per visionare la ricerca completa clicca qui
Discussioni
L’ipotesi di partenza del presente studio presupponeva l’esistenza di una relazione (significativamente elevata) preesistente fra l’utilizzo di videogames e condotte devianti a livello socio-emotivo (quali, ad esempio, la violenza o la mancanza di controllo degli impulsi). In relazione ai risultati emersi dalla nostra domanda di ricerca introduttiva, i test inseriti nell’indagine propongono delle evidenze che dovranno essere ulteriormente avallate da future indagini.
Come si denota dai risultati, il primo dato che emerge è un’assenza di significatività statistica elevata tra le ore di attività ludica dei videogiochi e la percezione di stati di tensione legati al controllo della rabbia o aggressività, come evidenziato in alcuni degli item inseriti ad hoc per la strutturazione delle relazioni emotive (quali il QAG e il IGDT9SF). Ulteriormente, non vi è una nessuna correlazione (significativamente elevata) tra l’utilizzo di videogiochi negli ultimi dodici mesi dal contenuto violento PEGI 18+ e le dinamiche di condotta violente o aggressive. Risulta interessante come l’insoddisfazione legata all’insuccesso di una missione o un obiettivo virtuale non sollevi alcuna conseguenza evidenziabile nella condotta quotidiana “offline” (così come si evince dalla tabella 4 e 5), nonostante il diverso tempo impiegato con dispositivi ludici, sia online che non. Da questi dati è possibile affermare che i VVG non sembrano esercitare alcuna influenza negativa significativamente elevata (ad esempio Ferguson, 2015). Infatti, come afferma Bandura (2001), l’apprendimento per osservazione non è sinonimo di mimetismo ma include l’apprendimento di regole sull’adeguatezza di comportamenti particolari per circostanze particolari.
Inoltre, non emerge significatività statistica elevata tra l’alterazione del tono dell’umore e la ricerca regolare di nuove skills e/o accessori di potenziamento e/o estetica utili per la costruzione del proprio avatar. Per cui si può ipotizzare che l’acquisto dei pacchetti di potenziamenti non vengano percepiti come fondamentali o uniche alternative per la buona esecuzione dell’esperienza ludica. Infatti, recenti ricerche (Rieger et al., 2015) hanno suggerito come l’utilizzo di un VVG possa essere associato non solo ad una ridotta ostilità ma a un aumento dell’umore positivo.
Un altro elemento di interesse che potrebbe essere ulteriormente esplorato è l’importanza delle relazioni instaurate online, tra videogiocatori e/o utenti delle piattaforme digitali. Come si riporta anche nei risultati, non vi è una rilevanza sulla totalità della dominanza di relazioni virtuali rispetto a quelle instaurate nella quotidianità. Infatti, il legame instaurato online è finalizzato ad un obiettivo comune o per instaurare un’alleanza a breve o lungo termine, che non influenza le relazioni strette sul piano reale. All’interno dell’indagine non si sono presentate correlazioni con l’uso di videogiochi e condotte perseguibili dal punto di vista giuridico (unica nota di rilevanza la detenzione di Hashish, che potrebbe essere associate a dinamiche non statisticamente significative alla nostra indagine sullo stato emotivo e uso di videogiochi).
Il campione è consapevole delle discrepanze tra il piano virtuale e reale, associato anche ad un range di livello culturale e sociale medio; si potrebbero produrre evidenze su una possibile differenza tra le componenti culturali e sociali e l’uso di videogames, tendenzialmente legate alle dinamiche socio-educative di provenienza.
Scopo di questa indagine è scomporre e ricomporre le illazioni e i luoghi comuni sulla condotta ludica, lo stato emotivo e la condotta della popolazione di utenti, al fine di approfondire evidenze e nuovi quesiti.
Il tempo e la tipologia di genere video-ludico non risultano quindi correlati a condotte devianti a livello emotivo e sociale né alla dipendenza da gioco da internet. Futuri studi dovranno approfondire le variabili individuali che possono innescare i comportamenti qui esaminati. Inoltre, anche il livello di istruzione e i comportamenti violenti sembrano essere non correlati tra di loro in modo significativo. Anche se questa ricerca pilota ha ottenuto dei risultati interessanti, non è priva di limiti. Infatti, il campione reclutato è di tipo non probabilistico e non è quindi necessariamente rappresentativo della popolazione generale di videogiocatori Italiani. Inoltre, non è stato possibile controllare la veridicità dei dati, in quanto, trattandosi di un questionario sottoposto online in forma anonima, gli autori dello studio non possono sapere se un soggetto ha risposto in modo sincero alle domande sottoposte. Inoltre, questa è una indagine quantitativa a scopo divulgativo e non scientifico e non può in nessun modo essere vista come tale. I partecipanti hanno prestato il loro consenso volontario alla partecipazione della ricerca stessa e dovevano essere maggiorenni per potervi partecipare. Inoltre, non è stato fornito nessun riscontro alla fine del questionario ed i dati sono stati conservati in forma anonima.
Questa ricerca non fa riferimento a nessuna Università né ad altre Istituzioni. Il suo scopo rimane di carattere divulgativo ed informativo. L’approvazione etica per la raccolta dati è stata data dall’AIPCCG.