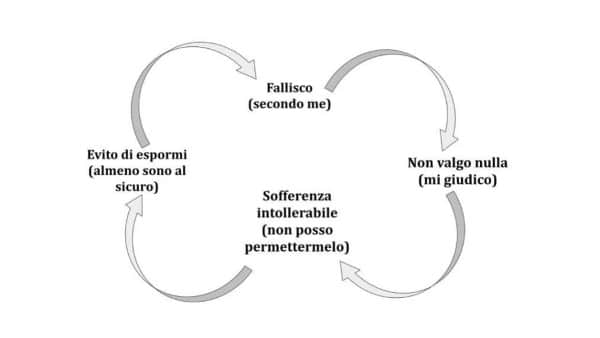L’infosfera: come internet ci rende più ignoranti
Internet ci apre a sterminate praterie di informazioni, ma ci mette anche davanti alla nostra limitata capacità computazionale, che ci indurrà ad abbandonare sempre più l’uso del pensiero critico.
Una delle cose più dolorose del nostro tempo è che coloro che hanno certezze sono stupidi, mentre quelli con immaginazione e comprensione sono pieni di dubbi e indecisione (Bertrand Russel).
Ogni qualvolta apriamo il computer o il telefonino ci appaiono informazioni o riferimenti riguardanti le nostre recenti ricerche effettuate su
internet; che si tratti di ricette gastronomiche, dati economici o di indirizzo sociale o politico, non fa alcuna differenza.
Ci sembra normale, quasi ovvio, e lo riteniamo molto utile perché ci fornisce velocemente indicazioni e riferimenti su quanto consideriamo interessante; inoltre quando constatiamo che altre persone la pensano come noi, hanno i nostri stessi interessi o convinzioni, ne traiamo un piacevole senso di conforto, un solido senso di appartenenza; le nostre idee ci appaiono confermate e sostenute nella loro esattezza dalle ampie condivisioni.
Non ci soffermiamo mai a considerare che tale risultato è falsato dalle modalità utilizzate dai motori di ricerca, che non si limitano a fornire informazioni, ma le vagliano per noi, selezionando quelle che appaiono coerenti con il nostro profilo e definendo un nostro personale universo di immagini e notizie.
Internet e la selezione di informazioni
I sofisticati algoritmi che operano sui motori di ricerca dei social si sostituiscono al funzionamento dell’attenzione selettiva, che naturalmente opera in ogni individuo, creando un meccanismo retroattivo molto pericoloso.
Le persone normalmente sono portate ad operare una selezione sui dati sensoriali provenienti dall’ambiente in modo da dedicare la computazione solo a quelli che sembrano rivestire una certa importanza per il soggetto. Scegliamo cioè, quasi sempre inconsapevolmente, di elaborare solo i dati che riteniamo utili alle nostre necessità. In sintesi le nostre ipotesi, le nostre aspettative su come debba essere la realtà, condizionano la ‘scelta’ delle informazioni che ricercheremo e che assumeremo come valide.
Lasciare quindi che qualcun altro analizzi e scelga per noi le informazioni di cui abbiamo bisogno, selezionando intenzionalmente quelle coerenti con le nostre previsioni, ci porta inevitabilmente ad un restringimento dei nostri interessi che si incanaleranno su argomenti predefiniti, sempre più coerenti ed integrati, che si vedranno così sistematicamente rinforzati evitando l’esperienza formativa del confronto con opinioni ed interessi diversi dai nostri, portandoci ad assumere una visione rigida ed univoca della ‘verità’.
La realtà che costruiamo diventa allora ipersoggettiva, in quanto continuamente rafforzata dalle opinioni di persone che la pensano come noi, dominata dal bias di conferma, la distorsione cognitiva che ci porta inconsciamente a dare più rilevanza alle opinioni che rispecchiano le nostre, risultando nella sua visione complessiva deprivata delle alternative o delle molteplici variabili, consegnandoci una visione del mondo più limitata ed impoverita.
Inoltre a causa dell’effetto del bias dell’ancoraggio, che rende difficilissima la revisione di un giudizio intuitivo, resteremo condizionati dalla valutazione iniziale anche nel caso in cui le informazioni raccolte o disponibili non siano congruenti con le idee di partenza; esse saranno allora scartate oppure interpretate in modo da sostenere o rafforzare i nostri preconcetti, coinvolgendo in questo complesso meccanismo auto confermativo anche la memoria, che tenderà a recuperare in modo selettivo solo i dati e le esperienze fra loro congruenti.
Il risultato finale sarà il sistematico abbandono dello schema ipotetico, con il quale sviluppiamo modelli interpretativi della realtà a favore del modello della certezza, che esclude per definizione l’esistenza di alternative; ritenendo di aver raggiunto la sicura conoscenza di un fatto oggettivo, non avremmo più ragione di dubitarne.
L’orientamento di varie ricerche nell’ambito della psicologia sociale sembra infatti suggerire che la radicalizzazione su alcuni temi centrali nell’opinione pubblica si basi prevalentemente su meccanismi centrati sul riconoscimento identitario piuttosto che sull’analisi e la sistematizzazione coerente delle informazioni disponibili. Assistiamo di fatto all’abbandono dello scetticismo metodologico, cardine del pensiero scientifico, per una deriva ideologica alla cui base il ‘so’ viene sostituito dal ‘voglio’, dove l’esigenza pratica giustifica la sua supposizione non semplicemente come ipotesi lecita ma come postulato che determina inevitabilmente l’esito del giudizio finale.
Questo induce la nefasta tendenza a confondere i fatti con le opinioni, portandoci ad abbandonare la capacità di analisi critica su quanto ci viene proposto e sulle alternative possibili, appellandoci ad un realismo ingenuo che, nel ritenere i nostri sensi in grado di percepire gli oggetti e gli eventi direttamente come sono senza alcun processo interpretativo e valutativo interposto, fornisce una solida base per molti dei nostri bias cognitivi.
I problemi legati ad internet e alla disponibilità di informazioni
Ma allora perché l’accesso a una gran mole di informazioni determinerebbe un problema?
Per comprendere appieno il senso di questa premessa dobbiamo conoscere, almeno genericamente, il funzionamento della nostra mente.
La psicologia sperimentale ha oramai da molto tempo suggerito l’esistenza di due diversi livelli di conoscenza, sviluppatisi gradualmente nel lungo percorso dell’evoluzione umana; il primo livello è quello tacito, formatosi quando l’individuo era sprovvisto della capacità verbale del linguaggio e del pensiero complesso, dotato solo delle prime strutture di consapevolezza si è strutturato per rispondere velocemente ai problemi di adattamento con l’ambiente, utilizzando schemi prevalentemente visivi o iconici, abituandosi a confrontare il flusso dei dati in entrata con i modelli rappresentativi interni basati sulle pregresse esperienze. I suoi processamenti sono condizionati dalle necessità imposte dai suoi limiti iniziali, la scarsa capacità computazionale ha indotto il sistema ad utilizzare delle comparazioni visive, molto più rapide delle successive descrizioni verbali, che hanno anche il vantaggio di poter essere utilizzate con il minimo sforzo psichico, ed in modo automatico, senza dover utilizzare cioè la coscienza, che nella forma attuale ancora non si era sviluppata o era presente in modo embrionale.
Ecco quindi che questa struttura piuttosto rozza si è trovata a ricercare la soluzione di problemi complessi e fondamentali per la sopravvivenza e ha quindi sviluppato una serie di euristiche, regole generali predefinite, veloci ed automatiche, che potessero fornire costantemente degli schemi di adattamento comportamentale; quelli che oggi nel loro significato disfunzionale definiamo bias mentali.
Il secondo livello di conoscenza, quello cosiddetto analitico, rappresenta al contrario il livello più sofisticato dell’evoluzione; esso dispone della coscienza secondaria, quella che ci caratterizza, del pensiero astratto e fondamentalmente del linguaggio.
Ecco quindi che le informazioni che ci giungono dall’ambiente sono processabili in modo diverso mediante il linguaggio che consente l’esecuzione consapevole di ragionamenti sequenziali, finalizzati, permettendoci una enorme complessità computazionale rispetto a quella espressa inizialmente e consentendo un’elaborazione della realtà sganciata dalla sua immediatezza con l’esperienza.
Sebbene i due sistemi operino sostanzialmente in modo differente, mantenendo la loro specificità, essi risultano funzionalmente interconnessi, consentendo in linea generale una integrazione tra i diversi modelli rappresentativi; i processamenti taciti, essendosi formati per primi, costituiscono il livello gerarchicamente superiore di elaborazione delle informazioni, essi rappresentano e definiscono gli elementi prototipici delle strutture cognitive, fornendo con le loro regole la base dell’impianto concettuale che orienta e condiziona il sistema analitico.
Ecco quindi che il cervello analogico continua ad operare, determinando i nostri comportamenti o le nostre decisioni, spesso in modo molto utile ed efficace, utilizzando regole veloci sebbene, proprio per questa caratteristica, grossolane ed imprecise, che richiedono pochissimo dispendio psichico e prevalentemente in modo tacito, senza cioè che essi siano percepiti dalla coscienza.
Avendo assunto il compito di controllare costantemente se le situazioni che viviamo debbano essere considerate positive o pericolose, il suo obiettivo primario è quello di fornirci nel più breve tempo possibile una risposta comportamentale.
Per rendere più efficace il suo operato tende ad evitare ogni sorta di dubbi o di incertezza, che impedirebbero o ritarderebbero l’emissione del comportamento agito: per ognuno di noi nelle situazioni di emergenza è più utile reagire prontamente, senza esitazioni o tentennamenti piuttosto che dedicarci ad una attenta analisi situazionale.
È quindi con questo armamentario piuttosto abborracciato di euristiche automatiche ed imprecise, poco inclini all’uso di procedure analitiche, che siamo chiamati ad affrontare e gestire la smisurata massa di informazioni oggi disponibili, scontrandoci inevitabilmente con l’incapacità di processarle ed integrarle per ricavare una migliore comprensione dei fenomeni valutati.
Dopo millenni di lenta accumulazione infatti, la conoscenza umana è entrata in una epoca di crescita esponenziale e rapidissima.
Oggi viviamo in un mondo dove la maggior parte delle informazioni risale a meno di 15 anni fa. Nell’ambito scientifico le conoscenze tendono a raddoppiare nel giro di soli otto anni, uguale accelerazione ha subito la nostra vita quotidiana, viaggiamo sempre di più, cambiamo casa e città, veniamo a contatto con molte più persone, al supermercato ci troviamo davanti ad un gamma di scelte che erano impensabili pochi anni fa.
I dati sono sconcertanti, nel 2014 l’umanità ha generato ogni due giorni una quantità di dati superiore a quella complessivamente prodotta dal genere umano dalla sua comparsa sulla terra fino al 2003.
Si stima che nel 2011 un americano medio fosse esposto quotidianamente ad una quantità di informazioni cinque volte superiore a quella a cui era esposto nel 1986.
Ogni giorno processiamo 34 gigabyte equivalenti a 100.000 parole, per fare un esempio è come leggere Guerra e pace di Tolstoy in 4 giorni; e tutto ciò a fronte di una capacità della mente cosciente di processare informazioni che è stata stimata dal neuroscienziato Daniel Levitin in circa 120 bit al secondo.
Considerando che quando una persona ci parla abbiamo bisogno di elaborare 60 bit al secondo appare evidente che al massimo siamo in grado di comprendere soltanto due persone che ci parlano contemporaneamente e poi ci troveremmo costretti ad escludere qualunque altra fonte di informazione.
Risulta evidente che la nostra capacità di elaborare l’informazione rischia probabilmente di diventare sempre più insufficiente e inadeguata a gestire il sovraccarico di cambiamenti, scelte, novità della vita moderna. Sempre più spesso ci troveremo nella condizione di non essere in grado di fronteggiare un ambiente così articolato e complesso; quando i dati che il nostro cervello deve processare simultaneamente diventano troppi, l’unico modo per uscirne è quello di prendere delle scorciatoie, specialmente se il nostro cervello tacito è già predisposto a farlo.
Internet e la nostra capacità di elaborare le informazioni
Quindi se da una parte il complesso mondo della rete e dei social ci apre sterminate praterie di informazioni, ci mette anche davanti alla nostra limitata capacità computazionale che ci indurrà ad abbandonare sempre più l’uso del pensiero critico, rinunciando alla possibilità di raggiungere un giudizio attraverso i processi mentali di discernimento, analisi, valutazione delle fonti e della loro attendibilità, confondendo i nostri interessi e desideri con la realtà oggettivabile.
Non possiamo arrenderci a questa tendenza, la posta in gioco è molto alta e non riguarda soltanto la nostra personale capacità di elaborare le informazioni per costruire un migliore adattamento alla realtà, essa riguarda la società nel suo complesso, determinando gli orientamenti che saranno assunti rispetto a temi di grande rilevanza.
Non stiamo parlando di eventi futuribili, quanto temuto sta già accadendo: nel 2004 alcune ricerche empiriche dell’università di Oslo rilevarono che tra il 1970 e il 1993 l’effetto Flynn era diminuito (lo studio di James Flynn del 1987 ha dimostrato che il quoziente intellettivo nelle nazioni sviluppate era costantemente aumentato nei precedenti 25 anni da una generazione all’altra in modo significativo).
Ma il dato più preoccupante è che a partire dagli anni 2000 è stata registrata una inversione di tendenza chiamata Effetto Flynn capovolto: dal 2004 il rallentamento si è trasformato in una costante diminuzione. Insomma pare che stiamo diventando sempre più stupidi.
Una delle cause accertate dell’abbassamento del QI è l’impoverimento del linguaggio, l’incapacità di elaborare e formulare pensieri complessi, l’aumento dell’analfabetismo funzionale, la degradazione delle facoltà emotive e relazionali.
Sebbene le cause di questo depauperamento non siano ancora tutte individuate, appare evidente la tendenza in atto: oggi ad occuparsi del processo di immagazzinamento, memoria ed elaborazione dei dati è prevalentemente la tecnologia, che sta riducendo l’intelligenza umana a svolgere un ruolo ausiliario sempre più ininfluente.
Ecco cosa scrive il neurobiologo Laurent Alexandre: ‘laddove il libro favoriva una concentrazione duratura e creativa, internet incoraggia la rapidità, il campionamento distratto di piccoli frammenti di informazioni provenienti da fonti diverse. Un’evoluzione che ci rende più che mai dipendenti dalle macchine, assuefatti alla connessione, incapaci di procurarci un’informazione senza l’aiuto di un motore di ricerca, dotati di una memoria difettosa e alla fine più vulnerabili a manipolazioni di ogni sorta’.
L’unico modo per opporci a questa deriva che mette in pericolo i principi stressi della democrazia e della condivisione sociale è quella di ribaltare la tendenza facendo leva sulla nostra parte più funzionale, investendo la maggior parte delle nostre risorse sulla formazione cognitiva delle persone.
Nel 1999 gli esperimenti di Dunning – Kruger sulla distorsione cognitiva, a causa della quale individui poco esperti e competenti tendevano a sopravvalutare le proprie abilità considerandosi a torto esperti in materia, (questo perché se non si hanno un minimo di competenze in un certo ambito non si riesce a fare una stima realistica delle proprie prestazioni e dei propri limiti) hanno avuto come corollario che i risultati potevano cambiare modificando un fattore. Gli studenti più incompetenti si attribuivano una valutazione più veritiera a seguito di una seppur minima introduzione alla materia o alla competenza analizzata, questo restituiva loro la capacità di poter valutare le proprie conoscenze e di sviluppare conseguentemente una valutazione più oggettiva.
Dobbiamo quindi invertire la tendenza scegliendo la complessità e praticandola in tutte le sue forme anche se sembra complicata, soprattutto se è complicata, non dobbiamo accettare di divenire troppo stupidi per vivere liberi.
Parafrasando Christophe Clavè: Non c’è libertà senza il pensiero della libertà e non c’è democrazia senza il pensiero della democrazia.