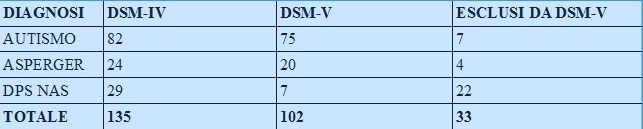Curare la bulimia nervosa: l’importanza di un trattamento tempestivo
La bulimia nervosa è caratterizzata da preoccupazioni per la magrezza e dalla presenza di abbuffate seguite da condotte compensatorie per prevenire l’aumento di peso. Se la diagnosi è precoce e il trattamento intensivo e completo sotto il profilo medico e psichiatrico, i bulimici hanno buone probabilità di recupero.
La bulimia: cos’è e come si manifesta
La bulimia nervosa è caratterizzata da preoccupazioni per la magrezza e dalla presenza di abbuffate seguite da condotte compensatorie per prevenire l’aumento di peso come vomito autoindotto, rigida restrizione alimentare, abuso di lassativi e diuretici, eccessiva attività fisica (DSMV, 2014).
L’abbuffata è l’ingestione di un quantitativo di cibo significativamente maggiore di quello che la maggior parte delle persone assumerebbe nello stesso lasso di tempo, avendo la sensazione di perdere il controllo mentre lo si fa. Inoltre nella persona che soffre di bulimia nervosa l’autostima è influenzata in misura eccessiva dalla forma e dal peso corporei. Le persone con bulimia nervosa tipicamente sono nei limiti di peso normale o di sovrappeso (indice di massa corporea IMC>18.5 e <30) e possono manifestare serie complicanze mediche come ad esempio gravi alterazioni elettrolitiche, complicanze renali e aritmie, fino a lacerazioni esofagee, rottura gastrica, e sintomi gastrointestinali importanti. Nelle donne sono spesso presenti irregolarità nel ciclo mestruale o talvolta amenorrea.
Nell’esperienza clinica si osserva come da un punto di vista psicologico la presenza di bulimia nervosa ha spesso effetti negativi sull’umore (sintomatologia depressiva e disturbi bipolari) e sulla propria autostima. Può esserci inoltre un’elevata frequenza di disturbi d’ansia che vanno spesso incontro ad una remissione totale in seguito ad un trattamento efficace della bulimia nervosa.
Spesso le persone con bulimia nervosa fanno uso di sostanze e alcol nel tentativo di controllare l’appetito e il peso. Esistono, inoltre, delle caratteristiche specifiche di personalità che si riscontrano nei pazienti affetti da tale disturbo dell’alimentazione: coloro che ne sono portatori sono più esposti di altri a sviluppare bulimia nervosa. Infatti la bassa autostima, la scarsa consapevolezza delle proprie emozioni, l’eccessivo perfezionismo, l’oscillazione tra comportamenti impulsivi e comportamenti ossessivi e l’eccessiva importanza attribuita al peso ed alla forma corporei paiono essere elementi comuni alle persone che soffrono di bulimia nervosa.
Cause della bulimia nervosa
I fattori di rischio (DSM V, 2014) per lo sviluppo della bulimia nervosa possono essere: temperamentali (preoccupazioni relative al peso, bassa autostima, sintomi depressivi, disturbo d’ansia sociale, disturbo iperansioso dell’infanzia), ambientali ovvero l’avere un ideale di corpo magro ma anche l’aver subito in infanzia abusi fisici e/o sessuali e fattori genetici e fisiologici come la trasmissione familiare e la vulnerabilità genetica ma anche l’obesità infantile e la precoce maturazione puberale.
Prevalenza e esito del disturbo
La prevalenza della Bulimia Nervosa nella popolazione femminile giovane ha un tasso dell’1% mentre l’incidenza sarebbe pari a 12 per 100.000 persone per anno. I tassi epidemiologici forniti da Hoek e Van Hoeken (ibidem, 2006) concordano abbastanza con quelli forniti dall’ APA in merito alla situazione negli Stati Uniti con una prevalenza tra l’1,1 e il 4,2 per cento per la bulimia Nervosa. Tipicamente riscontrati e diagnosticati soprattutto nei paesi occidentali, i disordini alimentari sono negli Stati Uniti la prima causa di morte per malattia mentale.
Per quanto riguarda il decorso della bulimia nervosa, la gravità dei disturbi copresenti predirrebbe un esito peggiore e a lungo termine del disturbo. Tuttavia, se la diagnosi è precoce e il trattamento intensivo e completo sotto il profilo medico e psichiatrico, i bulimici hanno buone probabilità di recupero. Per quanto riguarda la bulimia nervosa, la APA indica un tasso di successo dei pazienti trattati del 50–70 per cento nel breve periodo, e del 30-50 per cento nel lungo. Solitamente, i pazienti la cui condizione all’inizio del trattamento non è tale da richiedere ospedalizzazione, raggiungono risultati migliori.
Il rapporto tra prevalenza nelle donne e negli uomini si attesta tra 1 a 10. La bulimia colpisce tutte le classi sociali statunitensi e tutte le componenti etniche.
Secondo dati aggiornati a maggio 2015, forniti dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, la prevalenza della Bulimia Nervosa in Italia sarebbe dell’1%-5%, in linea con i dati forniti dagli altri paesi.
La Liguria parrebbe essere una delle regioni del nord-ovest in cui si ci ammala di più di disturbi dell’alimentazione. I dati rilevano una prevalenza di disturbi, come bulimia e anoressia, tra i 14 e i 24 anni, che arriva all’8 per cento, un punto in più rispetto alla media nazionale. Ma il picco arriva a quindici anni, la percentuale sale al 24%, si ammala quasi un ragazzo su quattro.
La fascia adolescenziale, tra i 14 e i 24 anni, resta la più colpita, ma bulimia nervosa e anoressia nervosa iniziano a diffondersi anche prima: ci si ammala già a nove anni, dalle Elementari si comincia a sviluppare un rapporto morboso con il cibo e anche i maschi cadono, sempre più spesso, nell’ossessione di un corpo perfetto.
Il centro Psicoterapia e Scienza Cognitiva di Genova
All’interno del centro Psicoterapia e Scienza Cognitiva di Genova i terapeuti di comprovata esperienza utilizzano la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) per il trattamento della bulimia la cui elevata efficacia è ampiamente documentata in letteratura (Anderson CB et al, 2012, Agras WS et al. 2000, Fairburn CG et al 1993) tanto da risultare la tecnica di elezione per il trattamento di tale patologia alimentare (NICE, 2004, Shapiro et al., 2007, Hay et al., 2009, Murphy et al., 2010) soprattutto nella versione ampliata (CBT-E) (Fairburn et al., 2009). In particolare, studi di efficacia riportano che il trattamento cognitivo-comportamentale determinerebbe un decremento nei comportamenti di abbuffata, vomito e abuso di lassativi (Mitchell JE et al, 1993, Bulik CM et al., 1998, Agras WS et al., 1989).
All’interno del Centro Psicoterapia e Scienza Cognitiva di Genova la terapia cognitivo-comportamentale ha lo scopo di aiutare chi soffre di bulimia nervosa a identificare e modificare alcune modalità di pensiero problematiche che favoriscono la comparsa e il mantenimento della patologia alimentare, a imparare a gestire il sintomo e a sostituirlo con pensieri e comportamenti più adeguati e funzionali.
In particolare attraverso lo strumento del colloquio psicoterapeutico cognitivo (Ruggiero, Sassaroli 2013), la persona è incoraggiata a riconoscere il legame tra sofferenza emotiva ed elaborazione cognitiva consapevole, mettere in discussione la validità di questi pensieri, il loro valore di verità e di utilità e costruire nuovi pensieri più utili, che andranno a sostituire quelli vecchi, nelle situazioni quotidiane e quindi genereranno emozioni e comportamenti differenti e più funzionali. Ha inoltre il compito di aiutare la persona che soffre di bulimia nervosa a conoscere le proprie emozioni negative e a gestirle non solo attraverso il cibo ma con attività differenti.
Il percorso di psicoterapia individuale del centro Psicoterapia e scienza Cognitiva di Genova prevede il raggiungimento di diversi obiettivi: nelle fasi iniziali il trattamento si focalizza sulla normalizzazione del peso e sull’abbandono dei comportamenti di controllo dello stesso; successivamente tende ad aiutare la persona a migliorare l’immagine corporea, la valutazione di sé e i rapporti interpersonali, modificando l’idea che il peso e le forme corporee costituiscano il principale fattore in base al quale stimare il proprio valore personale.
La strutturazione del percorso di terapia all’interno del centro Psicoterapia e Scienza Cognitiva di Genova prevede un primo colloquio di conoscenza del paziente e della sua problematica con l’obiettivo di definizione del problema, una valutazione diagnostica e colloqui di psicoterapia individuale e colloqui di supporto ai familiari; spesso si affianca alla psicoterapia la terapia farmacologica per gestire gli aspetti legati all’umore e il controllo delle abbuffate.
Il centro Psicoterapia e Scienza Cognitiva di Genova lavora in un’ottica multidisciplinare, avvalendosi di medici internisti, psichiatri abilitati alla terapia psichiatrico-farmacologica, nutrizionisti per una alla valutazione internistica e nutrizionale allo scopo di valutare le condizioni fisiche e modificare le abitudini nutrizionali scorrette attraverso il monitoraggio quotidiano dell’alimentazione. In alcuni casi si rende necessario un eventuale invio presso strutture di ricovero pubbliche o private.
Scopri il centro di psicoterapia di Genova