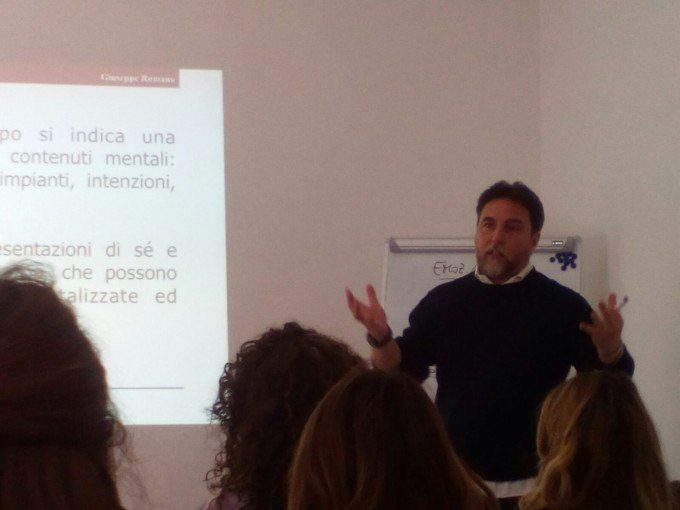Gianni Liotti – Introduzione alla Psicologia
Lo studio dei Sistemi Motivazionali Interpersonali (SMI) permise a Gianni Liotti di proporre una nuova spiegazione della genesi e del mantenimento dei disturbi psicopatologici.
Realizzato in collaborazione con la Sigmund Freud University, Università di Psicologia a Milano
Giovanni Antonio Liotti è nato a Tripoli, in Libia, il 27 marzo 1945. Si è laureato in Medicina a Roma e poi si è specializzato in Psichiatria (1962-1973). Subito dopo la laurea continuò a frequentare l’università in qualità di borsista e poi di ricercatore. I principali interessi di
Liotti erano centrati sull’applicazione e integrazione della
teoria dell’attaccamento di
John Bowlby alla psicoterapia e alla psicopatologia.
Liotti nel 1978 è stato socio fondatore della Società italiana di terapia comportamentale e cognitiva (SITCC), di cui è stato presidente dal 2000 al 2006.
Nel 1983 scrisse insieme a Vittorio Filippo Guidano il libro “Cognitive processes and emotional desorders“, che fu premiato come il miglior libro dell’anno sulla psicoterapia. Da allora il suo interesse si è focalizzato sullo studio della connessione tra dissociazione psicopatologica e attaccamento disorganizzato e nel 2005 Liotti ha ricevuto il premio Pierre Janet’s Writing Award.
Liotti e i sistemi motivazionali
Liotti fin da subito cercò di unire la ricerca svolta in ambito evolutivo, le neuroscienze, il funzionamento dell’affettività, al mestiere di psicoterapeuta, in un periodo in cui l’unico paradigma psicoterapeutico accettato era quello psicoanalitico. Questo tentativo d’integrazione è stata la sua grande innovazione ed evoluzione, in cui metteva insieme il nuovo, risultati della ricerca, alla clinica per costruire un progetto psicoterapeutico rivoluzionario e innovativo.
Liotti, studiò le emozioni, partendo dalla teoria di autori come Darwin, Ekman, Bowlby, Panksepp e Gilbert. Bowlby e Panksepp, condividono essenzialmente la tesi centrale dell’esistenza di sistemi psicobiologici frutto dell’evoluzione, omologhi negli animali e nell’uomo, che regolano sequenze caratteristiche sia di comportamenti sia di emozioni, in vista del perseguimento di specifici obiettivi adattativi.
La teoria evoluzionistica della motivazione di Liotti tiene in considerazione sia i processi alti sia i processi bassi in un’organizzazione gerarchica tripartita in cui i vari sistemi motivazionali si collocano al livello inferiore, intermedio o superiore in accordo con la loro successiva comparsa nel corso dell’evoluzione. Si delinea, perciò, una ricorsività dell’informazione fra sistemi motivazionali che unisce in maniera bidirezionale il livello arcaico, intermedio e il livello superiore evoluzionisticamente più recente.
La gerarchia dei sistemi motivazionali
Il cervello umano ha una struttura evolutiva gerarchica organizzata su tre livelli: rettiliano, limbico e neo-corticale. L’architettura dei sistemi motivazionali segue questa tripartizione, aumentando la propria influenzabilità ambientale col salire di livello gerarchico.
Il livello evolutivamente più arcaico dell’organizzazione motivazionale è connesso all’attività neurale localizzata nel cervello rettiliano, tronco encefalico, nuclei della base. Esso è costituito da sistemi che regolano condotte non-sociali rivolte alla regolazione delle funzioni fisiologiche, alla difesa dai pericoli, all’esplorazione dell’ambiente, a definire e controllare un proprio spazio fisico vitale, al procacciamento di cibo, e alla riproduzione sessuale.
Su queste sistemi non-sociali poggiano quelli appartenenti alla storia evolutiva più recente che controllano l’interazione sociale caratteristica dei mammiferi. Questo secondo livello corrisponde all’attività delle reti neurali localizzate nell’area limbica del cervello che comprende l’amigdala e il giro del cingolo. Le condotte sociali messe in atto dai mammiferi rivelano alcune omologie universali: la separazione identifica il sistema motivazionale dell’attaccamento, o richiesta di cura; il contatto corporeo morbido e ripetuto quello dell’accudimento o offerta di cura; i rituali di corteggiamento quello della sessualità; posture e mimiche di sfida e di resa identificano il sistema competitivo di rango o agonistico e, infine, nei mammiferi più evoluti, come i primati, il gioco sociale e l’attenzione congiunta riportano al sistema cooperativo paritetico.
Il terzo livello, prerogativa della specie umana, è localizzato nella neo-corteccia, riguarda la dimensione cognitiva dell’intersoggettività e della costruzione di significati. Esso è responsabile di combinazioni e variazioni individuali della loro espressione, in funzione della cultura di appartenenza.
Il sistema dell’intersoggettività, in quanto evoluzionisticamente più recente, esercita una funzione regolatrice sui sistemi sottostanti da cui emerge, mentre un’abnorme attivazione di questi ultimi può condurre a una più o meno protratta dissoluzione della motivazione intersoggettiva.
Ne consegue che nessuna influenza culturale sui contenuti della coscienza può annullare il fondamento evoluzionistico e dunque universale sul quale la coscienza di ordine superiore poggia.
Ne discende che ogni emozione umana presuppone l’intervento dei processi cognitivi superiori dell’uomo: le componenti fisiologiche delle emozioni sono trasformate in emozioni propriamente dette soltanto grazie all’intervento delle regioni neocorticali e “cognitive” del cervello umano.
I sistemi motivazionali interpersonali
I sistemi appartenenti al secondo livello gerarchico sono nell’uomo denominati sistemi motivazionali interpersonali (SMI). I sistemi motivazionali interpersonali sono quindi tendenze universali, biologicamente determinate e selezionate su base evolutiva, la cui espressione nel comportamento presenta variabilità individuali. Essi regolano la condotta in funzione di particolari mete e sono in stretta relazione con l’esperienza emotiva. Le emozioni accompagnano infatti l’azione dei sistemi motivazionali interpersonali e possono esserne considerate indicatori di attività. Quindi, secondo Liotti, ogni specifica esperienza emotiva può essere meglio compresa se rapportata al sistema motivazionale interpersonale entro cui si colloca. Le emozioni sono modalità di funzionamento dei sistemi motivazionali interpersonali e possono essere avvertite dalla coscienza. Quando due persone si incontrano, dunque, il loro scambio intersoggettivo è sempre regolato e motivato dagli SMI che, di conseguenza, si attivano.
Gli SMI sono sistemi di regolazione fisiologici che, una volta attivati, organizzano il comportamento sociale, interpersonale, oltre che l’esperienza emozionale e la rappresentazione di “sé-con-l’altro”.
Gli SMI di base sono cinque e da ognuno di essi si generano emozioni diverse.
Il sistema dell’attaccamento
Il sistema motivazionale dell’attaccamento è finalizzato all’ottenimento di aiuto e vicinanza protettiva da parte di un’altra persona individuata come idonea. Il sistema si attiva e assume il controllo di emozioni e comportamenti nelle situazioni di dolore, pericolo, percezione di vulnerabilità e solitudine. Quando è attivo regola una serie di emozioni tipicamente percepibili in sequenza: paura da separazione, collera da protesta, tristezza da perdita e, infine, il distacco emozionale. La disattivazione del sistema permette l’attivazione di altri registri motivazionali come quello dell’esplorazione, del gioco cooperativo, della sessualità di coppia.
Il sistema di accudimento
Il sistema è reciproco a quello dell’attaccamento. Esso porta all’offerta di cura verso un conspecifico, agevolando le possibilità di sostentamento di altri individui all’interno del proprio gruppo. Il sistema è attivato dai segnali di richiesta di conforto e protezione emessi da un altro individuo, a sua volta motivato dal sistema di attaccamento, o da percezione della sua fragilità/condizione di difficoltà. Le emozioni derivanti dall’attivazione di questo sistema sono ansia, compassione, tenerezza protettiva o colpa per il mancato accudimento. Il sistema si disattiva alla cessazione delle condizioni attivanti, quindi alla percezione di segnali di sollievo e sicurezza da parte dell’altro.
Il sistema sessuale di coppia
Il sistema della sessualità è finalizzato alla formazione e al mantenimento della coppia sessuale. Il sistema è attivato da segnali fisiologici interni all’organismo, come variazioni ormonali, più importanti negli animali che nell’uomo, e da segnali comportamentali di corteggiamento emessi da un altro individuo. Emozioni collegate all’attivazione del sistema sono il pudore, la paura del rifiuto e la gelosia; la percezione dell’avvicinarsi della meta invece è collegata all’esperienza emotiva del desiderio e piacere erotico. L’orgasmo pone termine all’attivazione del sistema, che può essere disattivato anche dall’attivazione di altri SMI. All’interno della coppia sessuale può naturalmente verificarsi l’attivazione di altri SMI (attaccamento-accudimento, agonistico, cooperativo) con il conseguente arricchimento di forma e qualità della relazione.
Il sistema agonistico o di Rango
Il sistema agonistico di competizione per il rango è finalizzato alla definizione dei ranghi di potere e di dominanza/sottomissione per regolare all’interno di un gruppo il diritto prioritario di accesso alle risorse. Una volta stabilita la gerarchia all’interno del gruppo, questa rimane presente ed attiva nel tempo, con il vantaggio biologico di eliminare la necessità di continue lotte che potrebbero sfiancare gli individui. La definizione dei ranghi avviene attraverso forme ritualizzate in cui l’aggressività non è primariamente finalizzata a ledere l’antagonista ma ad ottenere da quest’ultimo un segnale di resa. Il sistema agonistico è attivato (a) dalla percezione che una risorsa è limitata e appetibile da più di un membro del gruppo sociale, (b) da segnali di sfida provenienti da un conspecifico, (c) nell’uomo da giudizio, ridicolizzazione, colpevolizzazione e altri segnali di rango. La disattivazione del sistema è determinata dal segnale di resa che comporta il riconoscimento della propria subordinazione al vincitore. Questo sistema può essere disattivato da un altro sistema motivazionale che subentra.
Il sistema cooperativo paritetico
Il sistema cooperativo ha come meta il conseguimento di un obiettivo comune, più facile da raggiungere attraverso un’azione congiunta. Il sistema è attivato appunto dalla percezione che risorse non limitate risultano più accessibili attraverso uno sforzo congiunto di più individui.
Il sistema è attivato dalla percezione degli altri individui interagenti, in funzione dei fini prefissati e la percezione da parte dei “pari” di segnali di non-minaccia agonistica, come il sorriso. Il sistema può essere disattivato dal raggiungimento dell’obiettivo, dal tradimento della lealtà cooperativa da parte di uno o più interagenti o anche dall’attivazione di altri sistemi motivazionali in forme incompatibili. Quando la meta è vista avvicinata o raggiunta le emozioni collegate all’attivazione del sistema riguardano la gioia da condivisione, la fiducia e l’amore amicale; senso di colpa, sfiducia e risentimento segnalano invece la trasgressione dalle mete proprie del sistema.
Emozioni
Le emozioni giocano un ruolo intermedio fra la percezione della situazione, che attiva un dato sistema motivazionale, e la condotta che mira alla meta del sistema. Le operazioni di regolazione della condotta di ogni SMI sono radicalmente inconsce e le emozioni, dunque, sono le prime fasi nell’attività del sistema che possono essere esperite dalla coscienza. Le emozioni sono parte delle operazioni di un sistema motivazionale, e non hanno di per sé proprietà motivanti se non a livello di causalità prossimale.
Alcune emozioni sembrano attivarsi solo in concomitanza di uno specifico sistema motivazionale e non si manifestano mai durante l’attivazione di altri sistemi interpersonali. Altre emozioni, invece, si possono attivare nell’ambito di più di un sistema motivazionale, all’interno di sequenze emozionali molto diverse tra loro.
L’Analisi degli Indicatore delle Motivazioni Interpersonali nei Trascritti
L’Analisi degli Indicatore delle Motivazioni Interpersonali nei Trascritti (AIMIT) ha lo scopo di valutare le dinamiche motivazionali complesse, che potrebbero avere un ruolo importante nella genesi e nel mantenimento dei disturbi psicopatologici.
In particolare, consente di individuare gli indicatori che segnalano l’attivazione di un singolo sistema motivazionale o di identificare segnali di transizione da un sistema motivazionale all’altro.
Ad ogni sistema motivazionale è associato un codice: At (Attaccamento), Ac (Accudimento), Sex (Sessuale), Ra (Rango), Pa (Cooperazione Paritetica); se il sistema è attivo nella relazione terapeutica del momento si usa Rel (Relazione), se invece il sistema è attivo nella narrazione che però non coinvolge l’interlocutore si usa Nar (Narrazione)
Attaccamento e trauma
Liotti evidenzia come l’attaccamento disorganizzato nel primo anno di vita sia un potente predittore della dissociazione, più di quanto lo siano
traumi successivi, avanzando l’ipotesi che l’interazione fra ricordi traumatici e attaccamento disorganizzato possa essere il necessario antecedente della dissociazione patologica.
Secondo Liotti, il possibile meccanismo alla base di ciò sembrerebbe risiedere nella particolare interazione tra due sistemi motivazionali innati frutto dell’evoluzione: il sistema di difesa e il sistema di attaccamento. Mentre in condizioni ottimali questi due sistemi funzionano in perfetta armonia (il bambino scappa dal pericolo rifugiandosi dalla mamma, ed essendone confortato disinnesca il sistema di difesa), nell’attaccamento disorganizzato la figura di attaccamento è nello stesso tempo fonte di pericolo e di conforto, generando nel bambino un terrore senza sbocco.
La teoria polivagale di Porges aiuta a spiegare come la mancata inibizione del sistema di difesa da parte del sistema di attaccamento una volta che l’evento traumatico sia terminato favorisca la dissociazione: dato che attacco/fuga sono impossibili è probabile che l’unica difesa possibile sia la finta morte, con l’attivazione del nucleo dorsale del vago che ostacola le funzioni integrative superiori della coscienza.
Ma come mai non sono così evidenti e frequenti i sintomi dissociativi in bambini con attaccamento disorganizzato? L’ipotesi è che la maggior parte di loro sviluppi delle strategie per controllare i genitori senza attivare l’attaccamento, utilizzando altri sistemi motivazionali, come per esempio il sistema di rango o quello di accudimento. Queste strategie controllanti funzionano bene finché una sollecitazione troppo intensa del sistema di attaccamento non le faccia collassare, facendo emergere il MOI disorganizzato.
Il sistema di difesa merita particolare attenzione perché è coinvolto in tutte le esperienze traumatiche. Il trauma per definizione comporta sempre una minaccia alla vita o all’incolumità. Una volta attivato dalla percezione di una tale minaccia, il sistema di difesa si manifesta con una sequenza comportamentale descritta con le quattro “F”: Freezing, Flight, Fight, Feigned death. L’attivazione del sistema di difesa inizia con un’immediata e automatica immobilità (freezing, congelamento) comandata dal sistema ortosimpatico e accompagnata da tachicardia e iperpnea oltre che da un incremento del tono muscolare che ha il fine di preparare alla fuga (flight) o alla lotta (fight). La scelta fra la fuga e la lotta avviene durante la fase di congelamento, ed è legata a operazioni cerebrali che si svolgono a livello del tronco encefalico, essa non richiede dunque l’intervento della coscienza di ordine superiore. Si attua una valutazione puramente percettiva, non concettuale, dei rapporti di forza con l’aggressore o predatore. Se tale valutazione è favorevole all’aggredito, al freezing segue l’attacco al predatore, altrimenti la scelta è per la fuga. Se poi la fuga si rivela impossibile, può subentrare una manifestazione estrema, anch’essa automatica, ovvero una variante della sincope vagale nota come finta morte.
Mentre le prime tre fasi dell’attivazione del sistema di difesa sono regolate dal sistema ortosimpatico, la finta morte è regolata da una sezione del nucleo del vago, il nucleo vagale dorsale. L’espressione facciale riflette in modo diretto lo stato polivagale della persona; attraverso un processo di “neurocezione” (si tratta di un processo neurofisiologico) il sistema nervoso valuta il rischio presente nell’ambiente circostante senza consapevolezza e, spesso, indipendentemente da una narrazione cognitiva. In questo quadro, è possibile che la neurocezione del pericolo, in persone che hanno vissuto esperienze traumatiche, si attivi in modo automatico anche quando non esiste un pericolo “reale”. L’attivazione del nucleo dorsale del vago ostacola le funzioni integrative superiori della coscienza.
L’importanza per i clinici di conoscere le implicazioni dell’attivazione del nucleo dorsale del vago nelle esperienze traumatiche consiste nel fatto che tale attivazione può spiegare molti sintomi osservabili nei pazienti che soffrono degli esiti di traumi psicologici: i sintomi somatoformi di accasciamento e incertezza motoria, l’ottundimento e il tipico sentimento pervasivo di impotenza personale.
La centralità della relazione terapeutica e del sistema paritetico collaborativo
Questa teorizzazione ha una ricaduta di primaria importanza nella relazione terapeutica con pazienti traumatizzati: un terapeuta troppo accudente potrebbe far emergere i modelli operativi interni disorganizzati, con la fobia dell’attaccamento e la fobia della perdita di attaccamento, favorendo processi dissociativi. Un migliore assetto relazionale è invece garantito, secondo la teoria di Liotti, da una posizione collaborativa, paritetica, fra terapeuta e paziente. La costruzione e la riparazione dell’alleanza terapeutica ancora una volta, sembra essere uno dei principali strumenti del trattamento, soprattutto per pazienti pesantemente traumatizzati.
Realizzato in collaborazione con la Sigmund Freud University, Università di Psicologia a Milano
 RUBRICA: INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA
RUBRICA: INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA