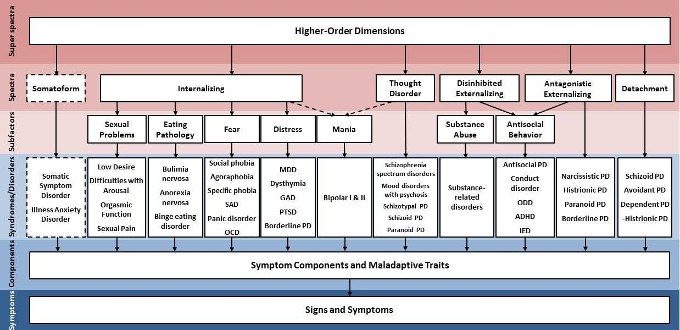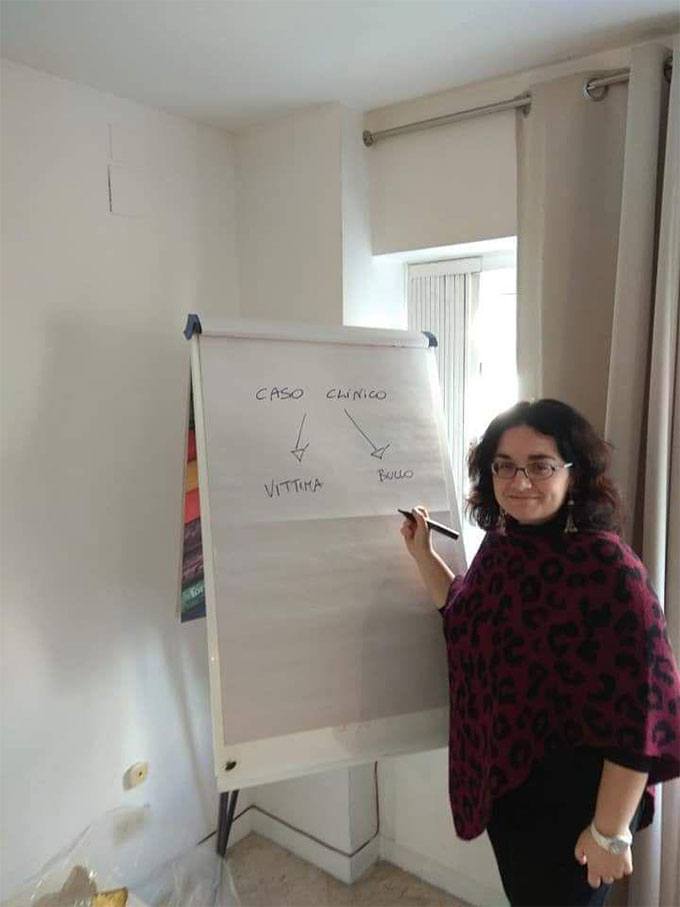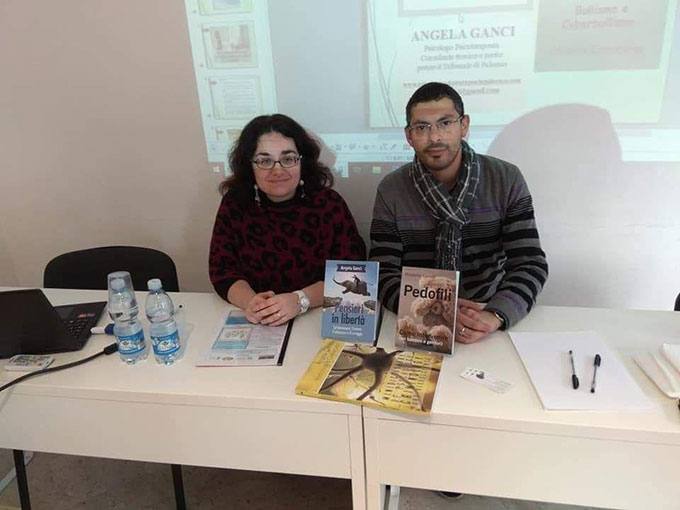Nuovi equilibri familiari: quando arriva un figlio con disabilità
La nascita di un figlio disabile pone la famiglia di fronte alla necessità di riorganizzarsi. Si tratta di un processo non sempre facile, nel quale il supporto psicologico può essere di grande aiuto nell’accompagnare ciascun membro della famiglia nell’elaborazione dei propri vissuti e delle proprie credenze verso un nuovo equilibrio individuale e familiare.
Malizia Genoveffa e Pignarolo Monica – OPEN SCHOOL Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Milano
La
famiglia è un sistema emozionale plurigenerazionale che racchiude al suo interno le esperienze di almeno tre generazioni, legate da vincoli di parentela, di sangue o legali e risulta quindi influenzato dalle relazioni passate, presenti e future (McGoldrick, Heiman e Carter, 1993).
Due esigenze della famiglia sono:
- trasformarsi in relazione ai bisogni evolutivi dei singoli componenti;
- conservare il senso della propria identità, stabilità e continuità nel tempo nonostante le trasformazioni (McGoldrick et al, 1993).
La famiglia è un sistema in evoluzione: affronta perciò compiti evolutivi che richiedono un più o meno vasto processo di riorganizzazione. Si parla infatti di ciclo di vita o fasi di transizione (McGoldrick e Carter, 1982). Le famiglie differiscono fra loro per le modalità con cui affrontano tali compiti evolutivi; anche il singolo nucleo familiare in tale percorso non rimane uguale a se stesso.
Il ciclo di vita della famiglia è caratterizzato da una serie di eventi più o meno critici che possono essere causati da diversi fattori, come l’ingresso o l’uscita di alcuni componenti della famiglia, problemi psicosociali legati allo sviluppo dei bambini o semplicemente eventi particolari legati alla vita della coppia (Gambini, 2007). Nessun evento in sé, tuttavia, è “critico” per lo sviluppo della famiglia, ma diventa rilevante sulla base di come viene percepito e dal significato ad esso attribuito, che è in gran parte correlato alle esperienze personali di tutti e alle credenze e ai valori sociali che sono trasmessi di generazione in generazione nella storia di ogni famiglia (Barnes, 2009).
Il modo in cui una famiglia reagisce a circostanze difficili risulta dall’interazione tra diversi fattori: le dinamiche familiari, la capacità di effettuare una valutazione corretta del problema, le strategie disponibili per affrontarlo, le risorse materiali e i supporti sociali forniti dall’esterno.
La nascita di un bambino, dunque, anche se notoriamente considerato un “evento felice”, porta la coppia ad affrontare un certo grado di confusione e una serie di problemi, alcuni dei quali richiedono una ristrutturazione della relazione, delle solite routine familiari, in modo da far fronte alle molteplici esigenze del nuovo nato. Tipicamente, dopo una fase iniziale di disorganizzazione, la coppia trova un equilibrio ed è in grado di integrare il nuovo bambino nel sistema, che diventa da diadico a triadico. Ma quando aggiungi elementi più critici, il processo di riabilitazione e riequilibrio potrebbe essere più lungo e più difficile e richiede più risorse, sia fisicamente che psicologicamente (Hedvat, Hauser‐Cram e Warfield, 2006). Le risorse necessarie riguardano: risorse emozionali (capacità di gestire frustrazione, ansia, paura, impotenza, che, soprattutto all’inizio, sembrano sopraffare i genitori), risorse cognitive (la necessità di elaborare l’evento e cercare di razionalizzarlo), risorse sociali (la necessità di attivare tutte le risorse in ambito sociale e familiare che potrebbero essere necessarie per gestire meglio la situazione) e risorse economiche (necessarie per fornire al bambino tutto ciò di cui ha bisogno, per garantirgli le migliori condizioni possibili per lo sviluppo) (Janoff‐Bulman e Frantz, 1997).
La famiglia di fronte alla disabilità
La nascita di un figlio con disabilità pone la famiglia di fronte alla necessità di riorganizzarsi, e lo può fare assumendo quattro diverse modalità (Faber, 1959):
- Child-oriented ovvero centrata sui bisogni del figlio
- Home oriented ovvero centrata sulla creazione di un ambiente domestico consono alle nuove esigenze
- Parent-oriented ovvero centrata sul nucleo familiare
- Orientamento incerto
Spesso, ad esempio, la natura della disabilità viene resa “invisibile” (Fisman, 2000), il che riduce la possibilità per la famiglia di essere immediatamente compresa e supportata dall’ambiente sociale in cui vive: per questo motivo, il rischio per i familiari, è quello di provare vergogna per la sua disabilità e di ridurre progressivamente gli scambi sociali, fino a giungere in alcuni casi ad un vero e proprio isolamento. Tale situazione è estremamente pericolosa, in quanto il sostegno sociale rappresenta una delle principali risorse per fronteggiare adeguatamente lo stress cronico, e in sua assenza la coppia genitoriale rischia di ritrovarsi sovraccaricata da aspettative e richieste spesso ambivalenti che entrambi i componenti rivolgono l’un l’altro, con il rischio di esacerbare il livello di conflittualità coniugale. Rischio ulteriore è inoltre rappresentato dal fatto che la sofferenza dei genitori, il loro senso di colpa e gli intensi sentimenti di vergogna da loro spesso provati possano compromettere il loro rapporto con il figlio e con chi si occupa di lui (Ramaglia e Pezzana, 2004).
Benché negli ultimi anni si sia assistito ad una maggiore responsabilizzazione di entrambi i membri genitoriali, è inevitabile che le madri continuino ad essere il cardine della presa in carico dei bambini disabili, essendo per questo sottoposte generalmente ad un maggiore stress rispetto al resto della famiglia. Harris et al. (1987) e Sorrentino (1987) evidenziano come spesso, per far fronte alle maggiori responsabilità quotidiane legate all’accudimento del figlio disabile, le madri rinuncino a diverse opportunità di sviluppo personale, per esempio in ambito lavorativo. Tale situazione porterebbe in alcuni casi al manifestarsi di sentimenti di depressione e rabbia, legati anche alla fatica e alle tensioni quotidiane; inoltre sembra frequente una caduta del livello di autostima, soprattutto nei casi in cui la maternità costituisce per la donna la fonte principale di autorealizzazione. Studi cross-culturali (McConkey et al. 2008, Keiko et al. 2001) hanno evidenziato come le madri di bambini con disabilità mentale fossero soggette ad un incremento nel rischio di stress mentale, non alleviato peraltro dall’accesso ai servizi sociali e dalle strategie di coping messe in atto; Azar e Badr (2006) evidenziano un’alta incidenza di sintomi depressivi nelle madri di bambini con disabilità intellettiva, come anche confermato dagli studi circa il sentimento di tristezza cronica (chronic sorrow) di Scornajenchi (2003).
I cambiamenti socio-culturali ai quali è stata esposta la famiglia, hanno portato alcuni autori (Powell et al. 1992; Zanobini e Freggiaro 2002) a prestare un maggiore interesse per la figura paterna (Keller e Honig 2004), evidenziando nel complesso come i padri siano più a rischio delle madri nello sviluppo di solidi legami affettivi con il figlio disabile, in quanto il loro ruolo è più marginale e più orientato a fronteggiare l’aspetto economico. I padri sembrano manifestare minori livelli di disponibilità e questo fenomeno è tanto più consistente quanto più gravi sono le difficoltà presentate dal figlio disabile; ciò è collegato anche ad una loro maggior difficoltà nel decifrare i segnali del bambino e alla loro minor disponibilità di tempo, rispetto alla madre, da dedicare all’interazione con il figlio (Pelchat e colleghi, 2003). Krauss (1993) ha evidenziato nelle madri maggiori problemi legati al ruolo genitoriale, mentre i padri riportavano un maggior livello di stress in relazione al temperamento del figlio ed erano più sensibili agli effetti dell’ambiente familiare, a differenza delle mogli le quali risultavano essere maggiormente influenzate dalle reti di supporto personale e sociale.
Quindi, considerare la famiglia come un sistema in evoluzione, è importante per non correre il rischio di giudicare come permanente una reazione poco adattiva al momento della diagnosi o viceversa di considerare il superamento di tale impatto come unico ostacolo a cui la famiglia di un bambino con disabilità deve far fronte nel tempo. Sicuramente la nascita di un figlio disabile, o comunque, il momento della scoperta del disturbo, è un fenomeno dirompente all’interno del ciclo vitale di una famiglia, tale da produrre una crisi di ampia portata, anche perchè non sempre i professionisti che informano le famiglie sono anche preparati ad aiutarle nel reggere l’impatto di una simile notizia e delle conseguenze che essa comporta.
La scoperta del disturbo, tuttavia, è solo il primo grande ostacolo davanti al quale si trovano le famiglie di un bambino disabile, il primo in scala ontogenetica. Esistono infatti altri momenti cruciali, che spesso coincidono con le tappe importanti della crescita del figlio, che pongono i familiari innanzi a nuovi problemi di adattamento (Myers, 1991). Nei primi mesi di vita si ha la necessità di rivedere i ruoli all’interno della famiglia, di riformulare i compiti, le responsabilità e le funzioni fra i coniugi, di ridistribuire le risorse economiche e di dover far fronte a tutta una serie di nuove routine per soddisfare le esigenze del nuovo venuto. Finchè il bimbo è piccolo l’esperienza del genitore di un figlio disabile non risulta molto dissimile da quello di uno senza disabilità; la discrepanza con i coetanei sia in termini di livello evolutivo che in termini di bisogni e interessi, aumenta ovviamente con la crescita anche se in modo diversificato per diversi tipi di disabilità. Con il passare del tempo, l’apprendimento di abilità funzionali alla vita quotidiana (come vestirsi, lavarsi o nutrirsi) non avviene automaticamente, ma sono necessari specifici interventi genitoriali ripetuti nel tempo e attenzioni particolari al fine di garantire il mantenimento e la generalizzazione dei risultati.
Il momento dell’ingresso a scuola è un altro passaggio molto delicato, soprattutto quando l’alunno con disabilità non è in grado di condividere le linee essenziali dei programmi svolti in classe, neanche con l’ausilio di personale specializzato o con l’ausilio di materiali appropriati.
L’eta adulta pone, infine, tutta una serie di problemi evolutivi cruciali, poichè esiste una difficoltà culturalmente determinata a pensare il disabile come individuo adulto. Emerge nei genitori il desiderio di maggiore autonomia dei propri figli, di maggiori amicizie con i pari e l’ingresso nel mondo del lavoro. Questi desideri non vengono quasi mai soddisfatti, in quanto la maggior parte di loro trascorre il proprio tempo a casa o in servizi diurni, a contatto esclusivamente con altre persone disabili, portando come conseguenza ad una restrizione della rete sociale. Talvolta la gravità del problema costituisce una difficoltà oggettiva all’emancipazione del soggetto dalle figure familiari; talvolta tale emancipazione è ostacolata soprattutto dalle barriere psicologiche che relegano la persona disabile al ruolo di eterno bambino, negando per esempio i bisogni e le possibilità legati alla sfera sessuale (Govigli, 1987).
In più, i genitori si trovano a dover fare i conti con il proprio invecchiamento, la riduzione delle capacità fisiche e una maggior frequenza di malattie, rendendo più difficoltoso il compito di cura del figlio disabile.
Anche le credenze culturali sulla disabilità svolgono un ruolo importante nel determinare il modo in cui la famiglia percepisce la disabilità e il tipo di misure necessarie per la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione (Sen, 1988). Gli studi riportano che le aspettative dei genitori sul loro figlio disabile sono per lo più negative e irrealistiche. Dalal e Pandey (1999) hanno studiato le credenze culturali e gli atteggiamenti messi in atto verso la disabilità fisica in una comunità rurale indiana: la disabilità è vista in termini di “tragedia”, “meglio essere morto che disabile”, in quanto c’è l’idea che non è possibile per le persone disabili essere felici o godere di una buona qualità della vita. In questa cultura, la convinzione che prevale molto fortemente è la percezione della disabilità come punizione per la vita passata, tutto legato al karma.
Il momento della comunicazione della diagnosi
Un punto cardinale riguarda le modalità con cui la diagnosi viene comunicata. La chiarezza e la gradualità delle informazioni (Harris et al., 1987; Pain, 1999), sia nel contenuto che nella modalità di presentazione, sembrano essere elementi importanti che non possono naturalmente impedire la sofferenza, ma possono accompagnare la famiglia verso un cammino fatto di speranza e un naturale processo di adattamento (Gabovitch e Curtin,2009), stimolando reazioni di tipo costruttivo, attivo, anziché di rassegnazione (Zanobini, Manetti, Usai, 2002).
La diagnosi può provocare nei genitori un forte trauma, legato alla discrepanza tra il bambino “ideale” che hanno costruito come oggetto d’amore durante l’attesa e il bambino “imperfetto” che la realtà presenta loro. I genitori si trovano quindi a dover elaborare un lutto, la perdita del bambino atteso che avevano già fortemente desiderato e ad investire le cariche affettive sul figlio reale (Monti Civelli, 1983; Dell’Aglio, 1994). La perdita del loro figlio ideale e sognato durante il periodo di gestazione può rappresentare oltre che una sconfitta personale, anche una sconfitta sociale che riaffiora ogni volta che il divario tra lo sviluppo del figlio disabile e gli altri bambini diventa più evidente (Winnubst, Buunk e Marcelissen, 1998).
Tale impatto, naturalmente, varia a seconda della gravità e della tipologia della menomazione (Myers, 1990), oltre che in relazione alla situazione personale, familiare e sociale dei genitori (cooperazione dei genitori, suddivisione dei compiti, qualità del rapporto coniugale, partecipazione dei componenti della famiglia allargata, supporto sociale e risorse che la comunità riesce ad attivare di fronte alla disabilità, creando nei genitori la percezione di non essere isolati).
Il momento in cui viene data la diagnosi ed il successivo periodo di adattamento della famiglia restano determinanti per avviare una relazione tra il bambino, la famiglia e gli operatori che forniranno un sostegno terapeutico. È necessario che i genitori abbiano gli elementi che permettano loro di capire il bambino, di rendersi conto dei suoi bisogni e di immaginarsi il futuro senza troppe ansie e incertezze. Hasnat e Graves (2000), hanno riscontrato in un loro studio, che i genitori che ritenevano di aver ricevuto, al momento della diagnosi, una grande quantità di informazioni, erano più soddisfatti di coloro che trovavano le informazione fornite semplicemente sufficienti.
Ciò che i genitori lamentano più volte è di essere stati lasciati soli di fronte alla diagnosi, denunciando la mancanza di un adeguato sostegno affettivo da parte degli operatori (Zanobini et al. 1998; 2002) e percependo la presenza di un atteggiamento di eccessiva rigidità e di un tono negativo e schietto all’atto della comunicazione iniziale e nelle fasi immediatamente successive, come se il proprio figlio fosse visto solo nel contesto della disabilità, più come oggetto che come soggetto avente dei diritti.
Non sempre i professionisti che informano le famiglie sono preparati ad aiutarle nel reggere l’impatto di una simile notizia, sia per via di una formazione non adeguata sia per il timore di fornire delle false speranze in un momento di estrema vulnerabilità della famiglia (Harnett, Tierney, Guerin, 2009; Mulligan, Steel, Macculloch, Nicholas, 2010). Perciò, diversi colloqui sono importanti per cercare di capire i bisogni specifici di ciascuna famiglia e per tarare su questa base l’eventuale offerta di supporti e servizi.
Una volta raggiunta la consapevolezza sulla disabilità del bambino e aver risposto alla domanda “perché e come è accaduto questo?”, la famiglia prende in rassegna le idee e le attese rispetto al modo in cui dovranno gestire la malattia (Patterson, 1989).
Le fasi di elaborazione e accettazione della disabilità
Il momento della comunicazione della diagnosi è ovviamente il più critico, con un effetto dirompente sugli equilibri personali e familiari; un momento molto difficile nella vita delle persone perché rende difficoltoso per i genitori immaginarsi un futuro e anticipare ciò che potrà accadere, soprattutto quando si tratta del primogenito (Farber, 1986). La notizia della disabilità è il tempo da cui prende vita una nuova realtà familiare; molte domande affollano la mente dei genitori, specialmente riguardo al loro futuro e al futuro del loro bambino, con la sensazione che nulla possa essere più simile a prima.
Bicknell (1983) ha tentato di delineare le fasi attraverso le quali si arriva all’elaborazione di tale lutto: dallo shock al dolore iniziali si genererebbero sensi di colpa e rabbia, fino ad arrivare a una fase di trattativa, la quale sfocerebbe in un’accettazione del problema e nell’elaborazione di un progetto. Nei genitori, in modo più o meno cosciente, potrebbero insorgere in questa prima fase atteggiamenti contrastanti (Cigoli, 1993; Dawin et al., 1991):
- un attaccamento eccessivo e di iperprotezione al figlio disabile, che li conduce ad una dedizione assoluta e indiscriminata, anche a spese del benessere di se stessi e degli altri membri della famiglia, portando spesso ad un esito decisamente negativo per lo sviluppo del bambino (Crnic, Friedrich e Greenberg, 1983; Landman, 1979).
- il rifiuto più completo, il desiderio che il proprio figlio non sia mai nato, che li porta a proiettare il problema verso l’esterno e a correre da uno specialista all’altro nel tentativo disperato di risolvere definitivamente il problema, cercando diagnosi nuove e diverse o interventi miracolosi. I passi successivi sono caratterizzati da meccanismi di difesa più o meno consapevoli, che si alternano a periodi di esplosioni emotive ingestibili legate al rifiuto delle prove e alla necessità di sfuggire alla sofferenza. Questo processo di “autoinganno” ha spesso la funzione di creare una pausa, necessaria per ricostruire il loro equilibrio interiore, messo a dura prova;
- la negazione della disabilità, associata a una caduta di autostima, un totale diniego della realtà che porta a misconoscere e non accettare la diagnosi (Schonell e Watts, 1957) e un diniego della necessità di cure, precludendosi qualunque tipo di trattamento (Worchel e Worchel, 1961).
Quindi l’idea di un impatto negativo della disabilità sulle famiglie ha finito per dominare la letteratura e guidare la ricerca sull’argomento per decadi, dando centralità a concetti quali dolore, lutto, tristezza cronica, stress, frustrazione, imbarazzo e senso di colpa (Kearney e Griffin,2001), che inevitabilmente seguono l’evento critico e che a volte causano nei genitori forme di isolamento dalla realtà esterna, una forma di “chiusura”: gradualmente interrompono i rapporti sociali e, in alcuni casi, cadono nella depressione.
Solo lentamente si supera la prima fase di shock e incredulità. Si sviluppa poi una certa razionalità e consapevolezza del problema e dei bisogni del figlio disabile e subentra il graduale adattamento alla nuova realtà, la costruzione di un rapporto reale con il proprio figlio (Di Cagno, Gandione, Massaglia, 1992).
Fattori stressanti e protettivi
Qualsiasi evento che rompa gli equilibri esistenti e richieda l’adattamento è potenzialmente una fonte di stress. Tutta la nostra esistenza è scandita da eventi stressanti, che ci costringono a trasformare le nostre risorse per affrontarli e superarli; il modo in cui li affrontiamo e le risorse che siamo in grado di attivare hanno una forte influenza sulla traiettoria del nostro sviluppo.
La vulnerabilità allo stress psicologico è influenzata da una serie di fattori, che riguardano il temperamento, il livello di coinvolgimento emotivo, le capacità di coping, il background socio-culturale, la disponibilità di risorse personali e sociali (Caldin e Serra, 2011).
Un evento è considerato una fonte di disagio nella misura in cui è percepito dalla persona come eccessivo o intollerabile o in qualche modo al di sopra della sua capacità di affrontarlo e superarlo (Zimbardo,1988). Più un evento è improvviso, imprevedibile, con effetti persistenti e con scarse risorse per affrontarlo, maggiore sarà la percezione di scarsa autoefficacia dei soggetti e maggiori saranno i rischi per la loro salute e per il loro benessere fisico e psicologico. Situazioni stressanti per la famiglia possono condurre i genitori a sperimentare distress circa il loro ruolo genitoriale, con conseguenze a medio e lungo termine sulla relazione genitore-bambino e sulla capacità di risposta costruttiva ai bisogni del minore (Kirby, 2005).
Il trauma emotivo provocato dalla nascita di un figlio disabile provoca ansie, preoccupazioni, stress e sensi di colpa che normalmente non si riscontrano quando il figlio è normodotato. I genitori devono adeguarsi a nuovi ruoli, riorganizzare la loro vita e far fronte alle cure e alle maggiori esigenze.
Per McCubbin e Patterson (1982), la capacità del genitore di far fronte ad una situazione stressante è determinata dall’interazione tra l’evento stressante e i successivi eventi sfavorevoli della vita, le risorse familiari, le percezioni dei genitori e le strategie di coping utilizzate. Il risultato di questa interazione è il livello di
adattamento familiare che va dallo stress grave/crisi ad un buon adattamento.
Diversi studi hanno dimostrato come la natura e la gravità della disabilità di un bambino possa essere significativamente correlata allo stress genitoriale, così come il temperamento di un bambino, i problemi comportamentali e le richieste poste al genitore (Cunningham, Bremner e Secord-Gilbert, 1992; Kazak e Marvin, 1984; Minnes, 1988). L’incapacità di affrontare e correggere correttamente alcuni eccessi comportamentali, spesso presenti nei bambini con disabilità, aumenta significativamente i livelli di stress dei genitori e riduce il senso di genitorialità e di autoefficacia. Se si aggiunge questo elemento alla loro già fragile condizione psicologica, non è difficile capire perché i livelli di stress dei genitori di bambini con disabilità siano di solito molto alti, specialmente se paragonati a quelli dei genitori di bambini con sviluppo tipico (Dabrowska e Pisula, 2010; Gupta e Kaur, 2010).
Tra i fattori protettivi possiamo trovare:
Un rapporto positivo tra genitori e figli e una elevata intimità coniugale può aiutare il bambino a sviluppare una miglior capacità di comunicazione, migliori abilità cognitive e rapporti sociali con i coetanei, ma questo non può proteggere i genitori dalla sfida posta dalla disabilità del figlio e dal conseguente stress (Gerstein, Crnic, Blacher, Backer, 2009). Le famiglie coese e armoniose presentano un miglior funzionamento socioemotivo, con ripercussioni positive anche sull’adattamento psicologico e sulla capacità di riorganizzazione di ogni membro familiare di fronte alla situazione di disabilità.
Al contrario, il conflitto coniugale è associato a molti più disturbi del comportamento, ansia e aggressività del bambino. In riferimento al rapporto di coppia, le madri di bambini disabili riportano meno soddisfazione per il rapporto matrimoniale e più sintomi depressivi rispetto alle madri dei normodotati (Kersh, Hedvat, Hauser‐ Cram, Warfield, 2006), il tutto correlato alle risorse economiche della famiglia e ai problemi di coppia e di comportamento del figlio (Hastings e Back, 2004; Kersh, 2006), a differenza dei padri, la cui soddisfazione per il matrimonio non è correlata a ciò. I conflitti coniugali possono essere a loro volta esacerbati dalla condivisione di emozioni negative intense e dalla richiesta di riorganizzazione che un figlio disabile comporta.
Altrettanto importanti sono certamente le reazioni cognitive, emotive, sociali, relazionali ed esperienziali dei genitori, considerate sia individualmente che in coppia. Le loro risorse fisiche, le caratteristiche della personalità, il modo di affrontare i problemi e lo stress in generale possono certamente fare la differenza (Venkatesh, 2008; Houser, Rick, Seligman, Milton, 1991).
Un altro elemento importante e cruciale della variabilità è dato dal livello di soddisfazione della coppia e dal funzionamento della famiglia. È stato spesso osservato che il sistema familiare, non solo in termini di rapporto coniugale (Cuzzocrea, Larcan, Baiocco, Costa, 2011), ma anche di famiglia allargata, può rappresentare, una fonte importante di vulnerabilità o una risorsa straordinaria.
Ci sono considerevoli ricerche che hanno evidenziato come i genitori di un figlio disabile abbiano un livello di stress molto più alto rispetto ai genitori di bambini senza disabilità (Hastings, 2002; Konstantareas, 1991; Scorgie, Wilgosh e McDonald, 1998).
Tuttavia, altre ricerche hanno dimostrato che, sebbene alcune famiglie siano a rischio di avere numerose difficoltà, queste riescano poi ad affrontare e ad adattarsi positivamente a questo stress (Konstantareas, 1991; Scorgie et al., 1998). Le modalità di coping familiari possono variare dall’adattamento sano al disadattamento in seguito al cambiamento delle risposte familiari nel tempo (Donovan, 1988).
I genitori e le famiglie che presentano, tutto sommato, un buon funzionamento sembrano possedere e ricorrere ad efficaci strategie di fronteggiamento delle difficoltà che inevitabilmente si trovano a dover affrontare. Alcune di queste strategie sono essenzialmente cognitive e si riferiscono alla “riformulazione” di quanto si e verificato, all’individuazione, nonostante tutto, di alcuni aspetti positivi, alla rilettura della propria esperienza alla luce di più dettagliate informazioni e conoscenze scientifiche; altre sono prevalentemente “emozionali” e consistono nell’esprimere apertamente i propri sentimenti e le proprie emozioni, nel “bloccare” la tendenza a stimolare in se stessi e negli altri sentimenti negativi, nel ricorrere, in presenza di situazioni conflittuali, alla contrattazione e nel dare spazio e tenere in considerazione anche i bisogni degli altri membri della famiglia, del partner e dei figli non disabili. Accanto a queste, alcuni genitori fanno ricorso anche a strategie relazionali, come il porre accentuate attenzioni alla coesione familiare, allo sviluppo delle capacità adattive dei diversi membri della famiglia, alla cooperazione e alla tolleranza, ma anche e di contro a strategie finalizzate a potenziare il proprio sviluppo personale, a mantenere soddisfacenti livelli di autonomia e indipendenza, a ricavare del tempo per i propri hobby e per la propria vita comunitaria e spirituale (Burr e Klein, 1994).
Le famiglie che ricorrono con elevata frequenza a queste strategie (high coping family) si differenziano da quelle che vi ricorrono solo sporadicamente (low coping family) per come affrontano le difficoltà sin dall’inizio, per gli atteggiamenti che tendono ad assumere nel corso del tempo, per i valori ai quali sembrano aderire, per le attività che svolgono, per la partecipazione alla cura del figlio disabile e per come vivono il supporto sociale che ricevono (Taanila et al., 2002).
Le strategie di coping svolgono diverse funzioni fondamentali in base alle quali possono essere suddivise in diverse tipologie (Lazarus, 1991):
• Emotion-focused coping, che consiste nella regolazione delle reazioni emotive negative conseguenti alla situazione stressante
• Problem-focused coping, che consiste nel tentativo di modificare o risolvere la situazione che sta minacciando o danneggiando l’individuo e la famiglia (Lazarus, 1991; Lazarus e Folkman, 1984).
Werner e collaboratori (2009) hanno rilevato che le strategie di coping collegate al mantenimento dell’integrazione familiare, della cooperazione e dell’ottimismo sono fortemente associate ad una riduzione dello stress, ad una maggiore coesione della famiglia, a percezioni positive dei genitori sulla gratificazione o soddisfazione nel prendersi cura del figlio disabile e a minor preoccupazioni per la futura assistenza del loro bambino e alla possibilità di istituzionalizzazione.
Il locus of control interno è la modalità con cui un individuo ritiene che gli eventi della sua vita siano prodotti dai suoi comportamenti o azioni piuttosto che da cause esterne indipendenti dalla propria volontà (Rotter, 1966). Diversi studi hanno riscontrato che anche il locus of control sia altamente correlato allo stress genitoriale (Friedrich, Wilturner e Cohen, 1985; Demaso, Campis e Wypij, 1991; Hastings e Brown, 2002): genitori che si sentono competenti nel loro ruolo genitoriale e nel gestire la disabilità del figlio tendono ad avere livelli di stress più bassi.
Indicatori di locus of control interno sono (Rotter, 1966):
• ricerca attiva di strumenti, conoscenze e skills per affrontare situazioni e problemi;
• ritenere che ciascun problema possa essere risolto o analizzato, che ciascun obiettivo sia raggiungibile (con le risorse adeguate);
• credere nei propri potenziali, attivarsi per svilupparli;
• “visione” delle possibili alternative di un azione finalizzata al raggiungimento di un obiettivo e tentativo di determinare le probabilità di successo di ciascuna azione.
A migliori livelli di qualità della vita si associano le credenze di efficacia, importanti nello svolgimento del “mestiere di genitore”; esse influenzano i livelli di stress e di depressione e l’utilizzo di strategie di coping centrate sul compito. Sono le informazioni che un genitore possiede a proposito delle proprie capacità genitoriali a regolare il comportamento e a intervenire attivamente nei confronti della scelta dei suoi obiettivi e delle azioni che possono essere realizzate per il suo raggiungimento. La fiducia che il genitore nutre a proposito della propria capacità di riuscire in compiti e attività con il figlio disabile influenza l’impegno e gli sforzi che vengono investiti, il perseguimento degli obiettivi, la perseveranza e la costanza nell’applicazione (Coleman, 1997; Karraker, 2003).
Le persone che nutrono scarse credenze di autoefficacia nei confronti delle loro capacità di affrontare con successo un determinato compito e di superare gli ostacoli che potrebbero incontrare possono evitarne lo svolgimento, delegarne ad altri la responsabilità o sperimentare un disagio consistente nel momento in cui si trovano ad affrontare situazioni difficili (Nota e Soresi, 2000).
L’orientamento della famiglia può variare da un controllo interno a uno esterno. I nuclei che hanno un senso di controllo interno si sentono in grado di individuare change o opportunità per il loro bambino e avvertono meno stress (Hassal, Rose e McDonald, 2005) e maggior solidità (personal hardiness)( Kobasa, Maddi e Kahn, 1982), mentre quelli che si orientano verso un senso di controllo esterno hanno una percezione maggiore del potere degli altri, siano essi educatori o operatori sociali, verso i quali avranno una relazione di fiducia/sfiducia. Da ciò risulta che una percezione eccessiva del proprio senso di competenza può dar luogo a rapporti marginali con il sistema di salute territoriale, al contrario la percezione di un forte senso del potere dei tecnici può danneggiare il percorso di ricerca della salute o produrre passività nel gestire i processi di malattia.
- Supporto sociale ricevuto
Un ruolo importante sul benessere della famiglia e del bambino è giocato dalla possibilità di godere di un adeguato sostegno sociale, psicologico e sanitario. Occorre però valutare non solo l’ampiezza delle relazioni, ma anche la loro qualità. La mancanza di tali relazioni intime si associa ad un alto rischio di effetti negativi a lungo termine sulla salute e sulla capacità genitoriale.
Il supporto sociale ha il suo effetto maggiore sullo stile di attribuzione, ovvero sul modo in cui i genitori giudicano e valutano l’evento disabilità e le situazioni ad esse connesse (Jennings et al., 1995). Infatti, il supporto sociale intra ed extrafamiliare può, date certe condizioni, migliorare efficacemente la qualità della vita laddove sia presente un bambino con una disabilità cronica. (Altiere, Kluge, 2008; Mancil, Boyd, Bedesem, 2009). È il percepire l’evento come stressante che lo rende tale (Boyce e Barnett, 1991; Innocenti, Huh e Boyce, 1992); se un individuo considera le proprie risorse come adeguate a far fronte alle richieste che gli arrivano dall’esterno, può adattarsi con successo anche se le domande ambientali sono considerevoli (Frey, Greenberg e Fewell, 1989).
Diverse ricerche hanno confermato che la presenza di reti di supporto oltre la famiglia immediata sono importanti mediatori nello stress genitoriale (Barakat e Linney, 1992; Henggeler, Watson e Whelan, 1990; Park, Turnbull e Rutherford, 2002; Rimmerman, 1991; Bristol, 1987; Trivette e Dunst, 1992; Park e Turnbull, 2002).
Sia nel caso in cui il figlio disabile sia il primo figlio, sia quando ci sono altri bambini, l’organizzazione e la gestione del ménage famigliare e il ruolo genitoriale possono essere particolarmente difficili (Larcan e Oliva, 2008; Cannao, 2006). I genitori, se non adeguatamente supportati, specialmente nella fase critica del processo di adattamento, sono suscettibili di commettere errori educativi che possono avere un impatto significativo sullo sviluppo emotivo e cognitivo del bambino con disabilità e, quando presente, anche su altri bambini. Il coinvolgimento di altri bambini nella famiglia è inevitabile. Nella maggior parte dei casi, per loro, soprattutto se lui/lei è più vecchio di suo fratello disabile, vengono assegnati ruoli e responsabilità sproporzionati alla loro età. L’attenzione, incentrata principalmente sul fratello con disabilità, li pone in una posizione di marginalità emotiva, evoca spesso sentimenti ambivalenti nei confronti del fratello, con ripercussioni sulla relazione e sullo sviluppo in generale. In alcuni casi sono stati segnalati episodi depressivi, ritardi dello sviluppo psicosociale e scarso rendimento accademico (Larcan, Cuzzocrea, 2011).
- La valutazione positiva della situazione
Per fronteggiare lo stress, di fondamentale importanza è la valutazione, ovvero il processo mentale durante il quale un individuo dà a un evento un significato soggettivo e personale. Gli individui che hanno un buon senso di coerenza sono portati a vedere gli avvenimenti esterni e interni come predicibili in buona misura e a pensare che ci sia un’alta probabilità che le cose si evolvano come è ragionevole che ci si possa attendere. Questo genera un senso di fiducia cha aiuta ad affrontare gli eventi che accadono nel corso della vita (Antonovsky, 1987).
Una buona capacità di mentalizzazione permette di regolare il comportamento emotivo del soggetto e implica la competenza di identificare e interpretare i propri e gli altrui stati interiori (Söderström e Skårderud, 2009). Essa è inoltre intimamente correlata alla funzione riflessiva e alla possibilità di rielaborazione emotiva e riorganizzazione cognitiva a fronte di eventi critici, così come la nascita di un figlio disabile.
Un altro dei fattori protettivi è la resilienza, ovvero la capacità di superare le avversità, sopravvivere allo stress e di contrapporsi alla pressione esercitata dall’ambiente, adattandosi in modo positivo (Valentine e Feinauer, 1992). Secondo il parere di Malaguti e Cyrulnik (2005), la resilienza familiare emerge dal combinarsi di tre fattori protettivi:
• la capacità di far fronte alle avversità, interpretando la sofferenza come occasione di crescita;
• l’atteggiamento positivo, ovvero la capacità di veder oltre le difficoltà, ipotizzando comunque un futuro migliore;
• la trascendenza e la spiritualità che aiutano a dare un signifcato alle sofferenze che si stanno affrontando inserendole in un più complessivo percorso di crescita spirituale.
Interventi terapeutici: come procedere e cosa fare
Sulla base di queste considerazioni, quando si progetta un intervento sulla famiglia con un figlio disabile, ci sono diversi fattori che devono essere presi in considerazione. È necessario fare una valutazione preliminare accurata non solo dei probabili elementi di vulnerabilità, ma anche delle risorse del bambino e della famiglia. In particolare, gli aspetti principali che dovrebbero essere considerati includono: il comportamento del bambino, il suo stato cognitivo, il comportamento dei genitori, gli aspetti emotivi e relazionali, e più specificamente le capacità genitoriali, gli aspetti rappresentativi, sia in relazione ai modelli di lavoro interni, sia in relazione ai significati attribuiti dai genitori alla disabilità e al comportamento del bambino, aspetti dell’organizzazione e del funzionamento familiare (struttura della famiglia, soddisfazione delle coppie, rapporti con le loro famiglie di origine), aspetti del più ampio contesto sociale (sostegno sociale, esperienza lavorativa, ecc.) e dinamiche relazionali (intra-ed extra-familiare).
Un intervento può essere considerato valido, se agisce a tutti i livelli sui membri della famiglia coinvolti. Deve essere in grado di cambiare credenze, emozioni e comportamenti disfunzionali, deve promuovere l’autoefficacia personale e parentale e deve stimolare la sinergia all’interno del sistema familiare e con i sistemi esterni.
L’accesso al sistema familiare può essere realizzato attraverso diverse modalità, in relazione a quanto emerge dalla valutazione iniziale, anche se, come suggerito da Sameroff (2006), in qualsiasi modo si scelga di entrare nel sistema, gli effetti del cambiamento dovrebbero comunque verificarsi a tutti i livelli del sistema. In alcuni casi potrebbe essere sufficiente intervenire direttamente sul figlio disabile (riparazione) per avere effetti significativi sul funzionamento dell’intero sistema. Altre volte può essere più utile cambiare la percezione che i genitori hanno della disabilità e il comportamento del bambino (azioni ridefinite). In altri casi, tuttavia, può rivelarsi utile un intervento di parent training sulle abilità genitoriali, che indirettamente porterà alla modifica delle loro credenze cognitive e del comportamento del bambino.
Dato l’impatto delle capacità e delle caratteristiche comportamentali dei genitori sulla loro reazione alla disabilità, Elliot et al. (1999) considerano la possibilità di un intervento psicologico sui caregiver durante il processo di riabilitazione, diversamente dai programmi psicosociali tradizionali, i quali considerano unicamente la prospettiva del bambino disabile senza tenere in gran conto la famiglia. Gli autori evidenziano come il coinvolgimento e il supporto della famiglia, sono importanti moderatori del processo di riabilitazione del paziente. Gli ultmi studi effettuati sulle famiglie nelle quali è presente un membro affetto da disabilità (Zanobini, 2002; Soresi, 2010) hanno evidenziato chiaramente che, la presa in carico di un bambino disabile pone il terapeuta di fronte alla necessità di prendere in carico l’intero nucleo familiare. Non è possibile avviare un processo terapeutico e/o riabilitativo considerando il soggetto indipendete dal contesto familiare e sociale in cui vive. È fondamentale riuscire a stringere con la coppia genitoriale, un patto terapeutico per mezzo del quale rafforzare ed amplificare l’efficacia degli interventi terapeutici e riabilitativi. I genitori, se sostenuti, possono attivare risorse utili allo sviluppo educativo, emotivo e cognitivo del figlio disabile. Per ottenere questo risultato è necessario favorire nei genitori lo sviluppo di sentimenti di fiducia, autoefficacia, speranza di poter incidere positivamente sul futuro del proprio fglio.
Nella pratica clinica cognitiva, si ritiene che il trattamento debba essere generalmente orientato nella direzione dell’accettazione; esso, infatti, si configura come tanto più efficace nel produrre e stabilizzare il cambiamento se visto non come mezzo per dimostrare l’infondatezza e l’irrazionalità delle convinzioni e dei timori del paziente né come un modo per modificare una realtà immodificabile, ma piuttosto come occasione di far sperimentare al paziente che il problema sta nell’iper-focalizzazione su di essi. Le credenze e le ipotesi del paziente sono sempre rappresentazioni legittime della realtà (frutto di esperienze di vita altrettanto legittime), ma l’eccessiva focalizzazione su alcune di esse, produce un iper-investimento sugli scopi connessi e la persistenza di condotte orientate a questi scopi, anche quando infruttuose o paradossali (Perdighe e Mancini, 2008). È comprensibile come, infatti, nel caso di un genitore alle prese con la disabilità del figlio, tanto più tempo egli si concentrerà negli anni a tentare di falsificare la diagnosi, tanto meno tempo potrà dedicarsi a fronteggiarla con strumenti terapeutici adeguati che possano mettere il figlio disabile, in condizioni di crescere al meglio possibile. Esistono pochi studi sulle rappresentazioni e sulle credenze proprie di genitori di bambini con disabilità. Si evidenzia una tendenza generale a sviluppare una rappresentazione disfunzionale circa se stessi e il bambino, ed un’immagine distorta della relazione. Il grave deficit del sistema di credenze del bambino (particolarmente visibile nei disturbi pervasivi dello sviluppo), si accompagna ad una difficoltà del genitore di accedere ai propri stati mentali (riflessività) e di riconoscere i bisogni e le intenzioni proprie del bambino (decentramento) (Giamundo et al., 2000).
Credenze di inadeguatezza e non amabilità possono condizionare fortemente la relazione col bambino e funzionare, in ottica cognitiva, come elementi di mantenimento di una relazione disfunzionale. Nel tentativo di testare le proprie credenze o schemi irrazionali, le madri mettono in atto comportamenti spesso intrusivi per il bambino o scarsamente sensibili ai suoi bisogni, di fronte ai quali il bambino attiva pattern più netti di rifiuto o di evitamento che finiscono per confermare le credenze irrazionali delle mamme e perpetuare a loro volta i cicli interattivi disfunzionali tra genitori e bambino.
Riprendendo gli obiettivi tratti dalle applicazioni della teoria dell’adattamento cognitivo di Taylor, osserviamo come l’adattamento ad una malattia grave e cronica, o nel nostro caso specifico alla disabilità di un figlio, dovrebbe avere due outcome principali: la ricerca di un significato, tramite lo sviluppo di un nuovo e più positivo atteggiamento alla vita, e l’incremento di un senso di mastery, il quale darebbe ragione di una maggiore percezione di controllo sugli esiti della patologia. Al fine di favorire tali risultati comportamentali, risulta utile un intervento per fasi il quale prende le mosse da alcune domande fondamentali come: “che problemi porta la famiglia?”, “in quale fase del processo di accettazione si trova, o in quale fase il processo si è bloccato?”, “quali sono le emozioni coinvolte e quali scopi la patologia del figlio compromette?”. Tale procedimento è fondamentale al fine di non colludere con la necessità di cambiare a tutti i costi uno stato della realtà di fatto immodificabile, bensì trovare una modalità che aiuti ad aumentare le capacità adattive e migliorare la qualità della vita della famiglia, in relazione alla gestione quotidiana della disabilità, nella prevenzione dei disturbi emotivi associati e nella gestione del dolore e dell’elaborazione del lutto conseguente (Taylor S.E.; 1983)
Un input importante in tal senso è dato dall’Acceptance and Commitment Therapy (ACT), basato sulla Relational Frame Theory (RFT) di Hayes, Barnes-Holmes e Roche (2001). Concezione centrale dell’ACT, una delle terapie del comportamento di terza generazione più legate alla ricerca di base sul comportamento verbale, è che la sofferenza psicologica sia solitamente e prevalentemente causata dal modo in cui il linguaggio, la cognizione e il controllo dell’esperienza diretta sul comportamento, interagiscono. Secondo tale approccio, il tentativo di modificare direttamente pensieri e sentimenti che producono e mantengono la difficoltà rappresenterebbe una modalità di intervento inefficace e controproducente. Nel caso specifico qui esaminato, si evince ad esempio come tale modalità di comportamento potrebbe colludere col tentativo del genitore, intrappolato in una fase di rabbia/colpa, di negare/cambiare lo stato di disabilità del figlio. L’ACT insegna come modificare il modo in cui difficili esperienze private agiscono sulle persone, piuttosto che tentare di eliminare la loro comparsa, avvalendosi di alternative terapeutiche efficaci come l’accettazione, la mindfulness, la defusione cognitiva, i valori e l’impegno nell’azione (Hayes, Strosahl, Wilson 1999). Essa prende in considerazione alcuni concetti non convenzionali (Hayes, 2004):
- la sofferenza psicologica è normale, è importante ed accompagna ogni persona;
- non è possibile sbarazzarsi volontariamente della propria sofferenza psicologica, anche se è possibile prendere provvedimenti per evitare di incrementarla artificilamente;
- il dolore e la sofferenza sono due differenti stati dell’essere;
- non bisogna identificarsi della propria sofferenza;
- si può vivere un’esistenza dettata dai propri valori, imparando ad uscire dalla propria mente ed entrare nella propria vita;
L’ACT si basa quindi su tre punti fondamentali:
- Mindfulness: un modo di osservare la propria esperienza, praticato per secoli in oriente attraverso la meditazione (Hayes, Follette e Linehan, 2004); attraverso tali tecniche si impara a guardare al proprio dolore, piuttosto che vedere il mondo attraverso esso, comprendendo come ci siano molte cose da fare nel momento presente, oltre che tentare di regolare i propri contenuti psicologici o la propria sofferenza.
- Accettazione: basato sulla nozione che, normalmente, tentando di liberarsi del proprio dolore si arriva solitamente ad amplificarlo, intrappolandosi in esso ancora di più e trasformando l’esperienza in qualcosa di traumatico. Non si intende il favorire un atteggiamento auto-distruttivo o nichilistico che tollera e/o sopporta il proprio dolore, ma un atteggiamento in grado di favorire un vitale e consapevole contatto con la propria esperienza, al fine di fronteggiare i problemi psicologici, più che eliminarli come si farebbe con un fattore esterno disturbante.
- Impegno e vita basata sui valori: volto al non mettere la propria vita in attesa, mentre si affrontano i propri problemi psicologici, ed attendendo passivamente la diminuzione del proprio dolore, ma uscendo dalla propria mente ed entrando nella propria vita, tramite azioni impegnate nella direzione di quelli che sono i propri valori.
In seguito è necessario valutare la dinamica del processo di accettazione, con le relative fasi, al fine di capire dove il processo si sia eventualmente bloccato, per ristabilire il normale processo di accettazione. A tal fine è necessario entrare nei dettagli, ad esempio tramite l’uso del laddering (Wells, 1999), facendo specificare alla persona cosa significhi, ad esempio “è una tragedia” (è su questi specifici contenuti che poi sarà possibile intervenire, come ad esempio “sono preoccupato per mio figlio: chi si occuperà di lui quando non ci sarò più?”, “è tutta colpa mia, avrei dovuto stare più attenta, merito di soffrire”, “mio figlio non avrà mai una vita serena”).
Conclusioni
Nonostante la visione dominante della famiglia sia apparsa catastrofica, il disadattamento e lo stress non sono affatto conseguenze inevitabili per le famiglie con bambini disabili. Ci sono elementi che suggeriscono la resilienza della famiglia, piuttosto che una catastrofe familiare, caratterizzata da elasticità e ottimismo (Singer, Ethridge, Aldana, 2007). Nonostante il forte impatto emotivo connesso al fatto di avere un figlio disabile, i genitori accolgono la sfida che il bambino presenta e non smettono di vivere, ma vanno incontro a una ridefinizione di valori e di ruoli.
I genitori sperimentano anche esperienze positive, concentrandosi sui punti di forza e abilità, più che di debolezza, e quelli più speranzosi vivono meno emozioni negative, sintomi depressivi e angoscia; sono più soddisfatti della vita, hanno maggior benessere e credono di poter raggiungere i loro obiettivi e generare percorsi praticabili a tal fine (Lloyd e Hastings, 2009). Esistono alcune dimensioni significative per una miglior qualità della vita genitoriale: ottimismo, religiosità, impegno per la vita, divisione tra adulti e bambini (intesa come chiarezza di comunicazioni e richieste tra il sistema genitoriale e quello dei figli), capacità di focalizzarsi sul bambino e senso di controllo sulla situazione (Ransom, Fisher e Terry, 1992). I tratti di personalità come estroversione, apertura, amabilità e coscienziosità predispongono i genitori all’uso maggiore di strategie di coping, a cui fanno seguito pensieri e azioni costruttive (Hassal, Rose, McDonald, 2005; Mancil, Boyd, Besedem, 2009); mentre nevroticità, allontanamento e fuga portano a minor benessere e conseguente depressione (Glidden e Natcher, 2009).
Dunn (1984) ha suggerito che la risposta di una famiglia allo stress derivante dalla disabilità di un figlio può influenzare la percezione della situazione e la reazione dei fratelli. Se i genitori reagiscono positivamente al loro bambino con bisogni speciali, allora la relazione dei fratelli tende ad essere più positiva. Se i genitori avevano una visione ottimista e premurosa, allora il fratello aveva più probabilità di fare lo stesso. Pertanto, la capacità del genitore di accettare le difficoltà del bambino influenza i modi in cui una famiglia opera.
È stato dimostrato che le emozioni positive promuovono la creatività e la flessibilità nel processo di pensiero e risoluzione dei problemi (Isen e Geva, 1987). Un visione positiva facilita anche il trattamento di informazioni importanti e rilevanti anche se tali informazioni sono negative e possono potenzialmente danneggiare l’autostima (Trope e Pomerantz, 1998). Un certo numero di studi ha esaminato le risposte positive ad eventi stressanti. Anche se gli eventi stessi possono non avere avuto esiti favorevoli, i risultati mostrano comunque la percezione di un beneficio di fronte agli eventi stressanti (Affleck et al, 1987), l’acquisizione di nuove abilità e risorse di coping (Schaefer e Coleman,1992), la percezione della crescita correlata al loro stress (Nolen-Hoeksema e Larson, 1999) e la trasformazione spirituale o religiosa che risulta dalle esperienze stressanti (Pargament, 1997).
Scorgie et al. (1999) ha fatto un’analisi qualitativa dei meccanismi che hanno portato i genitori a realizzare trasformazioni positive nelle loro percezioni del loro bambino con disabilità. Questa analisi rivelò che i genitori arrivarono a uno stato più positivo attraverso tre processi: (1) il bisogno di formare nuove identità, (2) i tentativi di trovare un significato alla situazione e (3) lo sviluppo di un senso di controllo personale. Molti genitori trovano significato attraverso l’acquisizione di nuovi ruoli come i capogruppo, i relatori o i rappresentanti nelle scuole, ospedali o strutture che rappresentano persone con disabilità. Altri genitori si sono concentrati sull’acquisizione di nuovi tratti come diventare più compassionevoli e meno concentrati su se stessi, imparando che potevano ottenere di più piuttosto che rimanere impotenti, sviluppando resistenza o una maggiore forza personale di fronte ai loro sentimenti di debolezza, passando dalla depressione alla capacità di considerare la vita come meritevole e di valore, e affrontare la vita con nuova audacia piuttosto che capitolare alla paura. Sebbene non potessero “sorridere” ed essere “felici” nella vita, erano comunque in grado di coltivare il senso dell’umorismo e aumentare i “momenti felici” (Scorgie e Sobsey, 2000).
Alcuni genitori hanno anche denunciato la perdita di amicizie a causa di avere un figlio con disabilità ma hanno anche citato altri genitori di bambini con disabilità, personale di strutture che lavorano con persone con disabilità e professionisti della salute come membri primari delle loro nuove reti di amicizia, dichiarando che non avrebbero potuto avere rapporti con una tale profondità se non avessero avuto un figlio disabile.
Inoltre, nonostante ci siano state segnalazioni di disintegrazione del matrimonio con la diagnosi di una disabilità, alcuni genitori hanno anche riferito che il loro matrimonio era emerso più forte dalla loro genitorialità di un bambino con disabilità, dato che il bisogno di trovare soluzioni a situazioni complesse e lavorare insieme come squadra ha richiesto loro di migliorare le loro capacità comunicative e rafforzare il loro matrimonio (Scorgie e Sobsey, 2000).
La ricerca è stata anche fatta per comprendere i temi delle percezioni positive. Behr, Murphy e Summers (1992) hanno utilizzato l’analisi fattoriale esplorativa per studiare più di 1200 famiglie e hanno identificato nove fattori positivi: (1) una fonte di felicità e amore, (2) un contributo alla forza della famiglia, (3) uno stimolo per la crescita e lo sviluppo personale (4) una fonte di orgoglio, (5) un percorso per l’apprendimento, (6) una chiave per comprendere lo scopo della vita, (8) una guida per comprendere le questioni future e (9) uno stimolo per crescita della carriera.
In una revisione della ricerca pubblicata sulle percezioni positive di famiglie con bambini con disabilità, Hastings e Taunt (2002) hanno confrontato temi, elementi e fattori in vari studi di ricerca e trovato alcuni temi chiave sulla natura e la struttura delle percezioni ed esperienze positive dei genitori di un figlio disabile e l’esperienza di caregiving. Questi possono essere riassunti come: (1) piacere e soddisfazione nel fornire assistenza al bambino, (2) visione del bambino come fonte di gioia e felicità, (3) senso di realizzazione nell’aver fatto il meglio per il bambino, (4) senso di condivisione e amore con il bambino, (5) bambino come una sfida o un’opportunità per imparare e crescere, (6) famiglia e matrimonio rafforzati, (7) un senso e uno scopo della vita nuovo o aumentato, (8) sviluppo di nuove abilità o nuove opportunità di carriera, (9) il diventare una persona migliore (più compassionevole, meno egoista, più tollerante), (10) maggiore forza personale o fiducia, (11) reti sociali e comunitarie espanse, (12) maggiore spiritualità (13) cambiamento nella prospettiva di vita (ad esempio, aver più chiaro cosa è importante nella vita, essere più consapevoli del futuro) e (14) valorizzazione della vita, vivendola ogni giorno a un ritmo più lento.
La presenza di indicatori positivi non sta a significare che i genitori siano ciechi alle difficoltà e ai problemi, ma che sono stati in grado di trovare un significato nella loro vita, riformulando la loro valutazione originale per enfatizzare i risultati positivi, come le loro capacità di raggiungere gli altri bisognosi. Assumere questa nuova prospettiva positiva significa pensare alla disabilità come a una possibilità concreta nella vita di ciascuno di noi; realizzare che la menomazione e la conseguente disabilità sono solo un aspetto della vita delle persone e non coincidono con essa, così la presenza di un membro disabile costituisce solo una parte, per quanto centrale in alcuni momenti, nella vita delle famiglie (Farber, 1986).
È quindi, essenziale riconoscere che le famiglie hanno modi diversi di sperimentare la disabilità di un figlio.
Non è la disabilità del bambino che svantaggia e disintegra le famiglie: è il loro modo di reagire ad essa e tra di loro (Dickman & Gordon, 1985, p. 109).